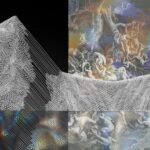Questo articolo è la trascrizione della presentazione di Tecnomemorie: fossili del presente, il secondo evento a cura di Chaosmotics e dell’associazione Uno+Uno+Uno.
Stiamo camminando fra le rovine della città Etrusca di Veio. Già da tre secoli prima della fondazione dell’Urbe, a una distanza di circa quindici chilometri dalla zona dove Romolo tracciò il solco primigenio, la pulcherrima1 Veio proliferava. Per Roma, la città Etrusca sarebbe stata un frammento irriducibile della sua storia millenaria. Dopo dieci anni di assedio, e tre secoli e mezzo di scontri, Veio cadrà nel 396 a.C.. Sarà Marco Furio Camillo – acclamato da tutti come “secondo Romolo”, dice Eutropio2 – a sancirne la fine per mezzo dell’acume, scavando un tunnel sotto le mura. A cent’anni dalla nascita della Repubblica, e ormai trecentocinquanta dalla fondazione, per il popolo romano il vincitore dei veienti meriterà il titolo di secondo fondatore. Camillo assume il nome del pater patriae per eccellenza. Per gli antichi, i nomi erano una cosa seria.
Camminiamo fra le rovine. Osserviamo ciò che rimane delle fondamenta, ciò che rimane delle mura di cinta. Ci sono pochi oggetti, forse qualche coccio da qualche recente scavo. Il terreno è rigoglioso d’erba verde. Il paesaggio non è differente da quello che osserveremmo in uno scavo paleontologico. I mattoni prendono il posto delle ossa; il silenzio è lo stesso. Camminiamo, e ci chiediamo: dove sono questi Etruschi? Come Hofmannsthal sull’Acropoli di Atene, sperso nell’apatia nei confronti delle rovine silenti – “Un sentimento di delusione mi assalì […]. Questi greci, chiedevo dentro di me, dove sono? Tentai di ricordare, ma ricordavo solo ricordi.”3. Quelle tracce di passaggio, fossili di una storia lontanissima eppure di inestimabile importanza, non sanno dirci molto di chi fossero i veienti, e il popolo di cui facevano parte.
“Dove sono questi Etruschi?” chiediamo al bravo archeologo che ci accompagna facendoci da guida. Il suo sguardo lascia il terreno su cui poggiano i nostri piedi, e corre verso le colline circostanti. “Non qui, ma tutt’attorno”, ci risponde.
Veio è attorniata da quindici necropoli, oltre a vari tumuli sparsi per la zona circostante. Quindici città dei morti attorno alla città dei vivi. “Chi vuole sapere di una civiltà, deve osservare come seppellisce i propri morti”, ci tiene a istruire la nostra guida. Da qualche parte ci ricordiamo, in effetti, di aver letto che per sapere a che livello di sviluppo sociale, cognitivo, e simbolico stavano i nostri antenati – anche dalla storia prima della storia – avremmo dovuto chiedere: “Seppellivano i loro morti?”. Il come e il perché non sarebbe stato, anzi, di immediata importanza; se la risposta fosse stata positiva, avremmo saputo già abbastanza. Avremmo saputo che quegli uomini vivevano in un mondo che avevano cominciato a creare loro stessi.
La sepoltura è una delle pochissime pratiche che accomuna gli agglomerati sociali nello spazio tanto quanto nel tempo. Evidenze archeologiche ci parlano dei Neanderthal, già scavatori di tombe nel terreno – strutture di pietra che coprivano il corpo del defunto, posto accanto ai suoi strumenti e a ossa di animali. Ma la sepoltura non è un semplice “atto di cura”, o una qualche forma di attenzione di tipo sanitario. Può capitare di pensare a civiltà come gli Egizi, o gli Etruschi, e riconoscere che l’attenzione ossessiva riposta nella cura del defunto fosse soprattutto di natura religiosa – legata alle specifiche cosmologie e alle loro considerazioni sull’anima e la sua trascendenza. Il fatto che la sepoltura si veda – che il tumulo, la tomba, la necropoli – siano artefatti complessi, pensati per durare a lungo e rimanere presenti agli occhi dei vivi, indica forse che la questione non si ferma solo alle soglie della vita individuale. La tomba è parte della città, del paesaggio, del territorio.
Un artefatto di tale natura esprime una funzione sociale. All’interno del territorio di un agglomerato urbano, l’esistenza di città dei morti è un fatto che ci spiega come per quegli uomini – che siamo anche noi – la morte biologica non equivalga alla morte sociale. Le necropoli di Veio sono dei segni, e in quanto segni sono integrati all’interno di un discorso – il logos di un popolo, il suo intero mondo. Con la morte si diventa altro, per la società, ma non si diventa niente – se il corpo sociale lo decide e lo accetta.
Proviamo a osservare questo oggetto, la tomba, in relazione a ciò da cui essa scaturisce – il bisogno che ipotizziamo vada a soddisfare. Ci verrebbe facile pensare alla relazione fra tomba e morte – la tomba salva il morto dalla scomparsa. Ma il defunto, in effetti, a qualche livello è scomparso.
Che cosa è che la tomba contiene, se, come si è detto, essa è un’integrazione della morte nell’ordine sociale? Si può dire: un immane sforzo descrittivo e narrativo che il corpo sociale mette in atto. La tomba è lo scrigno che contiene la rappresentazione del defunto. Il sepolto è un patchwork di denotazioni: i suoi strumenti in vita, le decorazioni che narrano la sua storia, i suoi averi, il suo corpo, una sua foto. Una stanza di specchi; tutte le cose che compongono il quadro di questa “individualità”. Ma per chi? Proviamo a ipotizzare: per la società stessa, il suo “mondo”, per cui la sepoltura è un atto assolutamente vitale – un atto attraverso cui essa stessa si mostra in vita e attraverso cui sopravvive. Nel reticolato di rappresentazioni che costituiscono il mondo sociale, il vivo e il morto non sono mai davvero differenti. In fondo a ciò, il perduto è il vissuto singolo, la presenza concreta di una coscienza.
In tal senso, osservando una tomba possiamo intuire la forma di vita di un corpo sociale, il modo in cui questo animale respira e si muove. Non è un caso che nei punti di massimo splendore di una civiltà, proliferi la costruzione di monumenti – che, come Nietzsche ci insegna, non sono che epitaffi di una storia4. Una società viva è una macchina che si specchia in se stessa, producendo rappresentazioni che ne definiscono l’identità attraverso la materializzazione di ciò che nella memoria è esteriorizzabile. La società stessa è un patchwork di denotazioni, un corpo che si osserva riflesso negli specchi che ha prodotto. Le proprie tombe sono perciò sistemi di rammemorazione di sé, specchi in cui riflettersi e contemplare la propria immagine.
L’oggetto che vediamo nell’opera Not even a God can Understand a Girl with a Smartphone ha caratteristiche a prima vista differenti dagli oggetti e dalle decorazioni scelti da coloro che performano il rito funebre per il defunto. Prima di tutto perché è l’oggetto a essere “il defunto”.
L’idea di seppellire uno smartphone non ci appare, però, così aliena. Al contrario, sembra descrivere efficacemente qualcosa della relazione con il nostro mondo. La sepoltura del defunto è un atto che mette in moto una collettività di soggetti che accolgono la morte di un individuo attraverso uno sforzo mnemonico rappresentativo. Il defunto è sepolto con ciò che lo rappresenta – un tempo era il corredo di oggetti che utilizzava, i gioielli che ne dichiaravano il rango; oggi, è la foto del volto in un dato momento, un’impressione, il periodo in cui è vissuto, forse una frase che lo identifichi. La sepoltura sembra sopperire alla scomparsa della coscienza presente, come vita vissuta e vivente, affermando così, di contro, la vitalità di un corpo sociale che lo denota, lo connota, lo riconosce. Il morto continua a vivere come rappresentazione, secondo l’insieme di riferimenti che il corpo sociale decide di utilizzare.
Lo smartphone, o il computer, che sono oggetti con cui noi intratteniamo una relazione estremamente intima, condividono con la struttura funzionale della tomba il fatto di essere riserve di descrizioni. In essi, nello spazio digitale a cui sono collegati e che costituiscono, è stipato un sistema estesissimo di descrizioni di noi stessi, e queste fungono da specchi: ci restituiscono riflessi frammentati fra documenti, foto, messaggi, video, programmi e applicazioni, preferenze di sistema, e di ordinamento delle icone del desktop. E queste stesse immagini sono a loro volta restituite al corpo sociale, che ne fa l’uso che vuole. Il mio smartphone sono io come sistema di inscrizioni. Possiamo meglio comprendere, allora, l’affettività che ci lega a questi oggetti, e che viene rappresentata nell’opera Not even a God. Un oggetto come uno smartphone che smette di funzionare, come magazzino di singoli frammenti di noi stessi in cui ci riconosciamo, è un evento assolutamente abissale per la nostra esperienza vissuta. Ciò che esso contiene spesso non è quantificabile materialmente – il pc può essere percepito come il contenitore di “tutta la mia vita”. La promessa di un non-luogo etereo, il cloud, che salvi quella vita dalla dipendenza dai supporti materiali, narra invece di un’estrema alleanza fra gli oggetti. Come espresso in un passaggio di The Land after Time, il cloud decentralizza la dipendenza ma è ben lungi da cancellarla; esso riorganizza la relazione fra l’uno e il molteplice – il bit non è vincolato a una sola unità di memoria, un pc, ma sopravvive attraverso l’interconnessione di un sistema di supporti materiali. L’Idea platonica non riesce a svincolarsi dalle statuette – e nemmeno dalle ombre.
La questione, a questo punto, deve prendere necessariamente in conto la memoria. Se abbiamo detto che l’oggetto tecnico che ci collega al cloud e la tomba condividono una stessa struttura funzionale, è perché entrambi risultano come contenitori di un certo tipo di ricordo: la rappresentazione (riportare alla presenza), o rimembranza (riportare nelle membra, re-incorporare). Per chi è questa ri-presentazione? E ha senso chiederselo? Si è detto: da una parte, il corpo sociale nella tomba e nell’informazione digitale produce se stesso, attraverso numerosi specchi in cui (si) riflette. Dall’altra, c’è il residuo che scompare, ciò per cui la giustapposizione degli oggetti – anche il corpo –, al fine di restituire un’immagine, assume un significato. Ma immagine di cosa? Qui sta il mistero, il punto cieco. Non perché non intuiamo cosa sia ciò di cui si vuole restituire l’immagine, ma perché non possiamo dirlo: è costitutivamente un mistero. È qualcosa che ipotizziamo simile alla “nostra” esperienza in prima persona, ma tale sapere è sempre forcluso. Oltre il limite della descrizione nessuna luce può aiutarci. Anche l’empatia, per quanto celebrata, non è la chiave per oltrepassare alcuna soglia: declina, traduce, accoglie il contenuto intuito di un’altra soggettività nella nostra. Un buon attore saprà sempre farci sentire cose che egli stesso non sente.
Il residuo impresentabile del vissuto personale è non-relazionale; esso sfugge alla rete di rappresentazioni che codifica e costituisce il corpo sociale. Ma quest’ultimo non è un chi, non è senziente – se non attraverso quello stesso residuo che non sa riconoscere come proprio. In The Land after Time, la voce fuoricampo afferma a un certo punto che “senza memoria, le tracce non hanno significato – sono gusci senza i loro fantasmi”. Seguendo quanto abbiamo detto, se con tracce intendiamo gli oggetti, come qualcosa di simile a un guscio, la giustapposizione di memoria e fantasma ci potrebbe portare a pensare che dietro le tracce, gli oggetti, dietro le tombe, i monumenti, le decorazioni, gli strumenti, le macchine, esista qualcos’altro da cui tutto il resto scaturisce. Una pericolosa gerarchia ontologica – il fantasma, il residuo, pieno di valore e di verità, e il guscio, vuota traccia. Posta in questo modo, la traccia – la materialità concreta – conterrebbe una memoria, il suo “fantasma”, o il suo spirito, il suo respiro. La traccia è, infatti, traccia di: qualcosa opera nel mondo in modo tale da manifestare nel paesaggio l’indizio di presenza di una agentività immediatamente riconoscibile – un segno. Ogni guscio è una parte, un frammento, o un sistema di frammenti del fantasma; è il fantasma nella sua stessa assenza dal regime del linguaggio – questo mistero dell’esperienza-in-persona – come principio autosufficiente. E allora ogni tentativo di salvataggio del fantasma – Everything not saved will be lost, come si dice nell’opera – è una dimostrazione della compenetrazione fra il guscio e il fantasma e, se si vuole, tra l’”artificiale” e il “naturale” sullo stesso piano di immanenza, in questo mistero di ciò che, in ultima istanza, non può riflettersi in alcuno specchio. Ci sono ragioni per pensare che questa agentività sia un oggetto separato dal guscio attraverso cui opera? Esiste una differenza tra guscio e fantasma?
Diciamoci che con guscio vogliamo intendere l’insieme, potenzialmente senza fine, di singole rappresentazioni che compongono l’immagine di un individuo, come nella tomba. E con fantasma intendiamo l’esperienza vissuta in prima persona, singolare, irriducibile, e incommensurabile che queste rappresentazioni tentano di ricostruire. Una coscienza individuale, dalla prospettiva dell’Altro, è composta di tracce che ne rappresentano la presenza, ma non il senso di “interiorità” – essere quella coscienza. Essa è, inoltre, immersa in un mondo di ulteriori tracce afferenti alla società e alla cultura, quindi ereditate, accolte, assunte in sé.
L’esperienza in prima persona non è solamente un oggetto fra gli altri, ma piuttosto ciò che il sistema degli oggetti, delle tracce, dei ricordi, tenta di ricostituire e reintegrare all’interno di un dato sistema di riferimenti – all’interno di un dato mondo, un framework. Le politiche identitarie che oggi sono protagoniste del dibattito contemporaneo sono la manifestazione di questa presenza irriflessa che tenta di affermarsi scardinando il sistema di riferimenti in cui è immersa proprio in quanto sistema di immagini incapaci di esaurire, tramite la rappresentazione, il vissuto individuale. Tale vissuto, nel momento in cui non ritrova identità fra il proprio sentire e il sistema di riferimenti in cui è immerso, produce uno strappo, rifiuta le forme di identificazione per mezzo del quale il corpo sociale tenta di integrarlo. Nell’apparire esattamente come vissuto inafferrabile, esso manifesta allo stesso tempo la forma di vita di un mondo come mero sistema di immagini – il rigore delle proprie strutture si rivela come rigor mortis. Come in una casa degli specchi, dove l’unico modo per uscire è affidarsi più al tatto che alla vista, il residuo emerge quando smette di specchiarsi e di restituire un riflesso. Quando, quindi, si scopre frantumato.
***
Se viene uno da Shiragi, è riflesso Shiragi, mentre la gente giapponese riflette il Giappone. Il cielo riflette il cielo e la gente riflette la gente. Abbiamo così studiato il venire e il riflettere, ma non conosciamo il vero significato di riflettere in rapporto allo specchio; semplicemente, ne facciamo esperienza. “Che succede se d’improvviso appare uno specchio limpido?” La risposta: “Si frantumerà in mille parti”. In altre parole lo specchio limpido, nel momento in cui improvvisamente compare, si frantuma. Indagare su queste parti è, ciò stesso, lo specchio limpido. Se cerchiamo di afferrare lo specchio limpido, certamente si frantumerà in molti pezzi. Frantumarsi in pezzi è, ciò stesso, lo specchio limpido. Non dobbiamo fare congetture sul fatto che esista un tempo, nel passato o nel futuro, in cui esso non si frantuma: semplicemente si frantuma.
Questo enigmatico passaggio del trattato Kokyō, nello Shobōgenzō (Eihei Dōgen, XIII sec.), può essere utile a comprendere quanto detto. In un importante testo in cui riflette sulla questione del supporto materiale, Lyotard commenta questo passaggio dicendo: “C’è dunque una presenza che frantuma, essa non è mai iscritta né la si può ricordare. Non appare. Non è un’iscrizione dimenticata, non ha luogo né momento sul supporto delle inscrizioni, nello specchio riflettente. Resta ignorato dalle tracce e dalle ricostruzioni”5. In altre parole, l’insieme di oggetti che compongono “il guscio”, come sistema di rappresentazioni dirette al fine di ricostruire una presenza impresentabile, sembrerebbe rimandare a quest’ultima come a un a priori fondativo. Ma il “frantumarsi in pezzi è, ciò stesso, lo specchio limpido”, questa presenza, il suo operare costitutivo.
Rivediamo allora ciò che abbiamo estratto da Land after Time – “senza memoria, le tracce non hanno significato – sono gusci senza i loro fantasmi” – in una chiave diversa. Ripartiamo da Veio. Lasciando le rovine della città e, seguendo ciò che rimane delle strade, ci dirigiamo verso le necropoli. La nostra brava guida ci mostra i corredi funebri, e la forma delle camere mortuarie e dei tumuli.
“Da questo capiamo che persone erano, che oggetti usavano, che cosa consideravano prezioso, e come la società era suddivisa”, ci istruisce. Non abbiamo memoria alcuna di tutto ciò – fa parte di un altro mondo – e per noi significa qualcosa solo in maniera inerente al nostro, di mondo.
“Ma che cosa voleva dire essere una persona etrusca?” – gli chiediamo, sinceramente incuriositi – “Come soffriva un etrusco? Come provava paura? Come faceva esperienza del suo essere uomo o donna?”. Questo è ciò che cerchiamo, fra ruderi e fossili.
Spazientito da quella che gli sembra essere una presa in giro, la brava guida borbotterà: “E io che ne so? Mica sono Etrusco!”.
Un po’ sconsolati dal rimbrotto, ci chiediamo fra noi che cosa stiamo osservando, davvero, nelle tombe. Come sappiamo che coloro che vi sono sepolti sono stati come noi? Osserviamo gli oggetti, il tumulo, la necropoli, poi le rovine della città. C’erano fantasmi in questi gusci? Non abbiamo altro che indizi. Ma anche se conoscessimo il contenuto delle tracce, in quanto significanti, avremmo accesso solo al fantasma di un significato – non alla potenza di una vita.
Tornati a casa, ci ricordiamo che la guerra veientina la narra Tito Livio. Prendiamo la copia di Ab Urbe Condita che ovviamente abbiamo tutti quanti sul comodino, facciamo per aprirla e ci fermiamo: la osserviamo. Che cos’è questo oggetto? Non è forse memoria messa in salvo? Memoria di una coscienza stata viva, presente, decisa a rappresentare la storia della sua civiltà? Così come i concittadini costruiscono il patchwork di immagini per salvare “il ricordo” del defunto, la sua presenza inafferrabile. La nostra suggestione è allora la seguente: che fantasma e guscio si manifestino solo ridotti in frammenti. Ma che ciò che il guscio tenta di ricostruire, il fantasma, è tale sempre e solo per un’altra presenza. Il fantasma non è soltanto fuori dal guscio, ma anche e sempre fuori da sé.