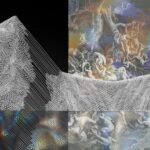Il nuovo definisce se stesso come risposta a quanto è già stabilito; allo stesso tempo, quanto è già stabilito deve riconfigurarsi in risposta al nuovo. Secondo Eliot, l’esaurimento del futuro ci lascia anche senza passato: quando la tradizione smette di essere contestata e modificata, smette di avere senso. Una cultura che limita a preservarsi non è una cultura.
– Mark Fisher, Realismo Capitalista
1.
Il termine chaosmos fu originariamente coniato da James Joyce, nell’opera Finnegans Wake, in cui parlava di un “Chaosmos of Alle”, ossia di un continuum formato da un coacervo di opposti. Il termine fu poi sviluppato tematicamente da Umberto Eco e, successivamente, ripreso e ampliato da Gilles Deleuze (più tardi assieme con Felix Guattari). Deleuze, in particolare, lo utilizzò per descrivere un universo (un tutto) strutturalmente caotico, in cui la continua biforcazione degli eventi genera infine serie dissonanti di incompossibilità e divergenze. Questa crasi di χάος e κόσμος si riferisce alla tensione in cui le differenze, come appunto ordine e disordine, compongono un flusso unico. La contemporaneità è testimone di una evidente complessificazione delle relazioni; gli opposti non possono più essere definiti. Non c’è spazio per pensare gli assoluti, ma solo per la simbiosi dei divergenti, che permeano organicamente l’uno l’altro. Il senso è un ibrido, un chiasmo; il mondo, un campo di inevitabili intermittenze e convergenze.
La decisione di riprendere questo termine per dare il nome a questa rivista si basa su una scelta programmatica. Chaosmotics è concepito come un gesto, il gesto di setacciare il nucleo della complessità simbiotica. Pensare, cioè, la complessità a partire dalla fonte del pensiero stesso e delle sue distorsioni. Questa scelta, inoltre, ha come obiettivo evitare che il pensiero venga reso elemento al servizio della norma. Spingere il κόσμος alla soglia del χάος, sempre diretto fuori dall’intero, oltre la soglia dell’insostenibile rassicurazione. È uno sforzo inumano.
Oggi il discorso critico e filosofico si piega nello stretto giro della professionalizzazione: la genuina e dolorosa capacità di porre in questione si è quasi completamente raffreddata, lasciando spazio al decorativo e all’isteria della compilazione d’ufficio. Dalla scrittura cruenta, agli ingranaggi della pubblicità; dal testo senza fine, allo slogan efficace, consolatorio e sempre disponibile. Il sapere è mercificato; ridotto a elemento delle competenze – un tecnico saper-fare.
Ciò che dovrebbe rappresentare la figura del “filosofo” prende oggi parte alla circolazione schizofrenica dell’economia di mercato con la sua reputazione di lavoratore, di produttore di beni – un impiegato nella sfera dello scambio economico. Un tassello dell’economia politica. Non è certamente casuale che la maggior parte dei pensatori del XX secolo si siano ritrovati ad indagare le radici e l’essenza della filosofia – se non addirittura l’estrema possibilità della fine. Questo è stato, ed è tutt’ora, un punto di riflessione cruciale. Se per una tradizione greca, fare filosofia – intesa come pratica disinteressata e contemplativa – si impose secondo l’apparenza consensuale e spontanea, sotto lo sguardo dei nostri contemporanei essa sta sempre più diventando un composto e stanco esercizio di forme vuote. E il pensiero, con essa, sta occultando nuovamente un suo elemento sotterraneo, disfunzionale al mantenimento dell’ordine produttivo. Il percorso sembra essere costellato di buone intenzioni: la miglior novità sul terreno filosofico è l’appartenenza a un sistema di controllo.
La desolazione degli ambienti che tradizionalmente offrono alla filosofia un porto sicuro – il potere di una legittimazione – modella figure sui suoi criteri univoci, affinché ci sia qualcuno che li abiti. Il sistema-università ha completamente perso di vista la problematizzazione e la tensione critica nei dibattiti pubblici. L’accademia accusa il proprio sintomo: alcuni pensatori e professori vanno allontanati come una malattia. I sopravvissuti alla salute devono essere pochi. Noi stiamo cercando un’uscita, un azzardo – l’arrivo di un’epidemia.
Il ruolo della cultura e del sapere è frainteso – anche ideologicamente. Dovremmo accogliere la cultura in quanto ricettacolo di nozioni stipate in una camera cerebrale? Le nozioni, gli elementi del conoscere, non sono infatti altro che elementi, mezzi; non sono nulla senza un significato, senza una tensione che ne incida la confluenza. Senza gli oscuri movimenti che guidano alla generazione ed estrazione di problemi, idee, e del nuovo a partire da quelle nozioni, il ricettacolo elementare non può essere accarezzato dal lume della vita.
Siamo testimoni del riempimento coatto che automi meccanici subiscono ad opera di parole e segni vuoti, con la totale incapacità di comprendere la storia di e dietro a quelle stesse parole e quegli stessi segni. Ad aggravare la situazione, parte dei discorsi accademici si sono dimostrati inclini ad abbracciare le idee di scientifizzazione e tecnicismo che li rendono nulla più che chiacchiera di pochi. Se è vero che, da una parte, la legittimità deriva dalla rigorosità, dall’altra si potrebbe tuttavia obiettare che il pensiero filosofico ha perso di vista il suo carattere pedagogico. È complesso indicare precisamente dove la filosofia inizi, e dove essa possa finire. Ma non è una questione né di luogo e né di tempo: è piuttosto questione di modo. Perdere di vista il compito della disseminazione – dei problemi, dei concetti, delle prospettive, della capacità di porsi in relazione diretta con problemi, concetti, prospettive – costituisce uno stato avanzato della malattia.
La filosofia sta attraversando un momento di precarietà di cui non ha mai fatto esperienza prima, e barcolla di fronte all’orizzonte che potrebbe sancirne la fine permanente, la sua dismissione. Cosa vogliamo dire, e fare, se le previsioni tratteggiano un futuro in cui non è possibile un pensiero critico – a meno di echi antichi e ridondanti, a meno di un pensiero memorante che non conosce la propria ragione? Può la filosofia, o quello che effettivamente dovremmo chiamare pensiero, avere la capacità di riscoprire se stesso nelle faglie prodotte da questo stato di tremore? Oppure questo stesso tremore preannuncia una ineluttabile sentenza? C’è qualcosa da fare, se il caso fosse quest’ultimo?
2.
Pensare non è umano. Non lo è secondo la presupposizione che “essere umano” sia già e abbia già un significato. Potremmo vedere il pensare come una proiezione, un insidiare, un analizzare, un mescolare, una disseminazione, una diffusione. Paradossalmente, seguendo una certa sedimentazione, il pensiero filosofico si è ridotto ad una meccanica del pensare, utile protesi della produzione di beni – il “valido”, il “vero”, la “denotazione” e il “qualificato”. Il pensiero selvaggio è stato civilmente confinato fuori dalla città. Continuiamo a riesumare spoglie di pensatori pensando di trovar fra le loro secche ossa – esattamente lì, nascosto – un nuovo guardare, nuove prospettive e risposte. Abbiamo consacrato il significato delle nostre vite ai culti della persona. Pensare ha assunto la forma di una carcassa inerme e nauseabonda, che non dispone del carattere che aveva in vita. È evidente che porsi una domanda è lecito, dopotutto: è questo, davvero, il pensiero?
Pensare fuori dalla scatola è ancora il triste gesto di un incapace frustrato. Se per abbandonarsi all’invenzione filosofica c’è bisogno di una scatola da cui uscire, non si fa altro che proiettare la miseria su un capro espiatorio. Espiare il peccato della mediocrità, del sentirsi confinati da un agente senza volto: il peccato di aver presupposto un controllo sulle cose, e di averlo perduto già prima del “traguardo”. La filosofia non è fuori dalla scatola, perché non vi è ovviamente dentro. “Uscire” è trovare uno spazio che sia altro rispetto a ciò da cui si esce. “Filosofare” non necessita di uno spazio. “Uscire” presenta un tempo successivo rispetto all’istante in cui non si è ancora usciti. “Filosofare” non necessita di un tempo. Siamo stati alieni prima di chiamarci terrestri.
Un evento, nella forma di una restituzione, è necessario. La filosofia necessita di ristabilire la connessione con la dimensione speculativa del pensiero, senza che essa si confonda con la mera fantasia. Essa deve riacquisire la divina inutilità che la contraddistingue, la stessa in grado di eludere le logiche di mercato. Giacché il suo prodotto, che sia un concetto, un’interpretazione, un simbolo, un’immagine o un intero sistema, non dovrebbe mai essere un mero bene di consumo. Il pensiero stesso non è, e non deve diventare, soggetto a processi consumistici. Una volta attivatosi, anche nelle sue interazioni con il “mondo finito”, il suo proprio intrinseco valore va ben oltre qualsiasi pura e pratica economia. La mercificazione e la comunicazione sono parte dello scambio, implicano fruizione e, perciò, consumo. Il pensiero non può fruire delle cose, e le cose non possono fruire del pensiero. Esso, a differenza della conoscenza, è in movimento e, in quanto tale, tende a distanziarsi dalle cose, così come tende a distanziare la pratica dall’imposizione, la cosa dal prodotto.
Se la filosofia è qualcosa, lo è perché agisce da strumento per tutti, aperto a tutto e perciò naturalmente ambizioso e folle. Forse anche inclassificabile. Pensare, e pensare propriamente, è un compito che si afferra solo tramite una scelta – anche se appare come una scelta obbligata, inconscia e traumatica. È così per tutti. Come già accennato, fare filosofia non necessita di un tempo e un luogo preciso. Non esiste qualcosa come “il tempo della filosofia”, e non dovrebbe nemmeno. La filosofia, infatti, si annida nell’improbabile e disperato deserto dei luoghi dimenticati – dove il pensiero chiama, visto che non ha fissa dimora, almeno finché non se ne crei violentemente una propria. In ogni caso, non bisognerebbe concepire questo movimento di pensiero a partire dalle proprie vette illuminate verso ambienti popolari: non è una illuminazione – non c’è luce lì dove nasce la domanda. Esso è, invece, un movimento sempre ascendente: da ovunque esso emerga, tende all’elevazione, all’ampliamento prospettico.
3.
Chaosmotics è un tentativo, come detto poco sopra, di restituzione. Di cosa? Risulta banale rispondere con “la capacità di provare terrore” – che non sia, alla fine, meraviglia – ma la questione si pone anche ad un livello pre-originario rispetto all’ordine cosciente impresso sul mondo. Dobbiamo affrontare discorsi complessi con mezzi diretti, semplici, senza però rinunciare a quelle sfumature che la complessità stessa ci offre. Abbiamo bisogno di direzione e chiarezza. La domanda afferma una distanza, e quella distanza produce una direzione fra ciò che è distanziato e ciò che pone la distanza. Produce un movimento che è potenzialmente in grado di essere ripercorso infinite volte, nella ripetizione della differenza. A cosa si riferisce questa domanda, per noi? Essa si riferisce alla fonte del domandare, e ciò potrebbe essere definito filosofia. Come prodotto del pensiero, l’uomo agisce nella dimenticanza dell’essere di questo pensiero, il suo nucleo ancestrale e spontaneo. L’uomo è pensato e perennemente attraversato da anonime correnti, di cui egli non è che un aspetto.
Il movimento del pensiero, dell’immagine polimorfa, deve generare aperture abissali. Chaosmotics cerca di riprodurre questa dinamica – nell’atemporalità del pensiero stesso, nella sua biografia. Proveremo, perciò, a indossare i sandali alati di Perseo ed Hermes, per tracciare il complesso mondo contemporaneo, le sue radici, le sue dinamiche, i percorsi taciuti che stiamo battendo. Il nostro lavoro cercherà di trasmettere la volontà di pensiero, il temporeggiamento, il porre distanza in mezzo alle lotte chiamate “riflessioni sugli eventi”. Questo si esprime come lo sforzo di diventare consci. Il nostro obiettivo è quello di incalzare i dibattiti contemporanei ed estrarre dalle relazioni e dai concetti le dinamiche che guidano la nostra quotidianità. Questo sarà, inoltre, affrontato con un costante movimento prospettico: dalla filosofia per la filosofia alla filosofia per, e con, le arti e le scienze. Con le fauci instancabilmente aperte, per cogliere una maglia allentata nella rete, tra sentieri nuovi e paure antiche. Il percorso di Chaosmotics vorrebbe, parallelamente, essere pedagogico. Distanziamento e avvicinamento. Esso rappresenta, in qualche modo, lo sforzo di diventare, ancora, inumani.
Abbiamo il compito di avvicinarci alle scienze, alle arti, agli eventi e ai linguaggi del presente; speriamo in cuor nostro di produrre mappe utili, per toccare ed esplorare quanto avremo già ammirato da lontano. La filosofia è e deve riappropriarsi del pensiero che viaggia alla velocità della luce, e al termine della notte. Si tratta, dunque, di rigettare la filosofia nello stato selvaggio in cui il pensiero si dispiega.
Il nostro campo di azione vuole essere popolare, ma popolare come perturbante parassita; ben lungi dallo scoprirsi ed esaurirsi nelle opinioni vuote – come il chiacchiericcio delle “filosofie del running” o delle “filosofie del successo”, come se la formula pubblicitaria “filosofia di” insinui nell’idiozia un barlume di eloquenza e valore – esso deve essere sempre alla ricerca di nuovi percorsi della conoscenza. Chaosmotics dovrebbe incontrare il popolare per setacciarlo, stuprarlo, rimodularlo, così da produrre torsioni insopportabili – prospettive altre. Il pensiero può partire da materiale “pop” di modo che questo venga immediatamente disgregato e sfigurato – abbandonato al servizio di un azzardo di pensiero e prassi.
L’imperativo ideologico della produzione regolativa e normalizzata deve lasciare posto alla dissoluta euforia delle intensità, affacciarsi così alla virtuale volontà-del-pensiero. Dobbiamo riguadagnare la capacità di focalizzarci sull’immaginare. Chaosmotics si apre come una possibilità: la possibilità che le circostanze vengano allarmate dalla direzione occlusiva che si vedono innanzi. La possibilità che il pensare si leghi alla follia; che essi si completino vicendevolmente in una nuova sintesi, nel perenne movimento che va dalla sorgente alla foce – e che ad essa fa ritorno, un ritorno differenziato. È un tentativo di emancipazione dalle barriere ideologico-immaginative, di focalizzare lo sguardo sulle pieghe della superficie mentre si osservano le evoluzioni della superficie intera. Fuori dalle torri d’avorio. Per-noi, è la necessità di un di-nuovo per stabilire un puro nuovo.
Non possiamo affrontare questo tempo di crisi da soli: è irreale, presuntuoso ed arrogante. Il percorso, la prassi che abbiamo in mente non avrebbe senso se non ci aspettassimo di far parte di uno sforzo di crescita, di una frenesia immaginativa e artistica che abbia come nucleo non una corrente, una forma o una struttura, ma la forza e la volontà di abbracciare tutte le correnti, le forme e le strutture. La prospettiva di tanti è una strada nuova, è più della somma delle singole unità. Non soltanto un sole vi è tramontato. La nostra fede è legata alle nuove e imprevedibili visioni del futuro.
Porre una domanda, aspettare la risposta (?).