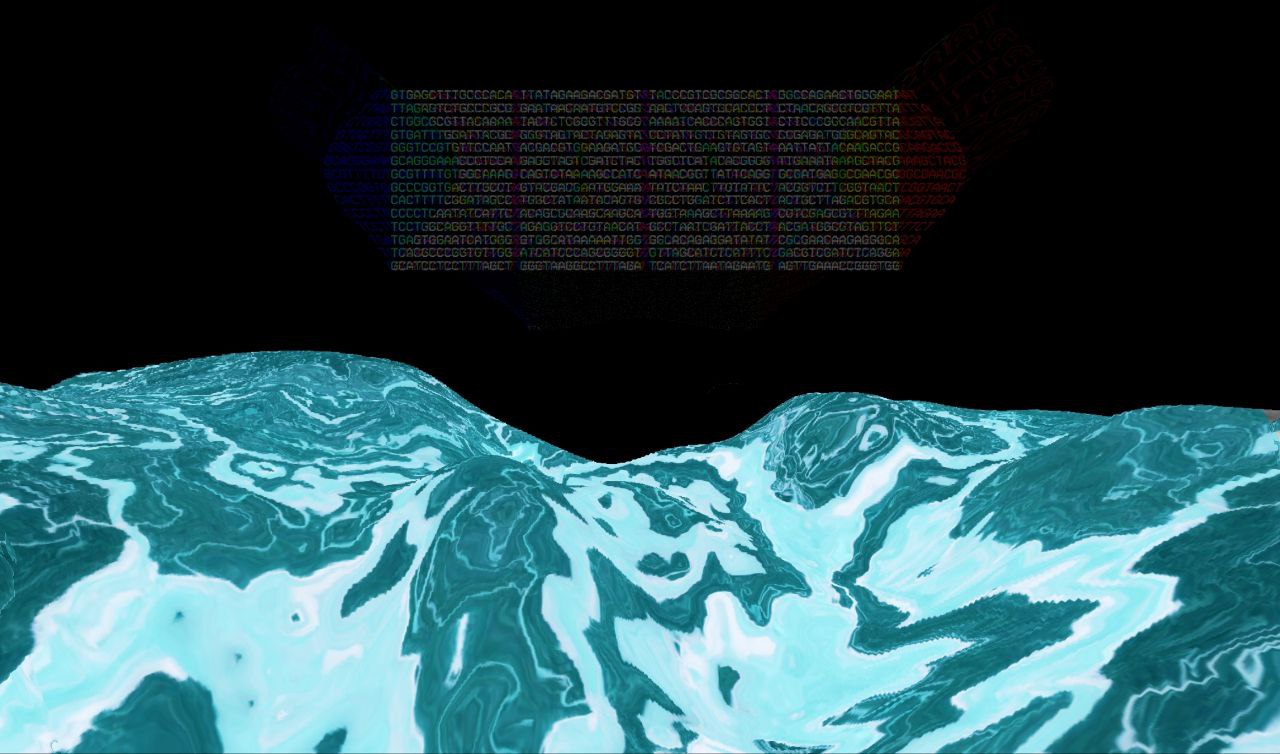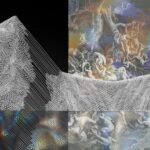Recensione in anteprima di Estetica senza (s)oggetti (DeriveApprodi) di Nicola Perullo, in uscita il 25 Novembre
Se c’è un elemento che domina da sempre il pensiero occidentale è l’idea che esistano, al di là di qualsiasi discussione e decostruzione, dei soggetti e degli oggetti. Nicola Perullo, a partire dalla messa in discussione di questa dicotomia originaria e delle modalità di pensiero che essa genera – come ad esempio la nozione di una separazione tra mente e mondo – mette in luce come ciò che ne consegue non permetta più all’essere umano di stabilire una relazione funzionale con il mondo. La crisi globale in corso, climatica e ambientale, è (anche) una crisi di percezione: una percezione del mondo, della vita e delle relazioni che, intrisa da una volontà di dominio, oggi è messa alla prova dallo scontro tra le rivendicazioni di potere di Homo e il divenire del mondo.
Il problema non è più solo quello di un soggetto antropo-centrico ed ego-centrico, un soggetto come Soggetto con la “S” maiuscola, ma anche della sua controparte “minore”: il mondo ridotto a insieme di oggetti verso cui l’uomo si muove per conoscerli e afferrarli. Non è un caso che «ego», qui, diventi la sigla per estetica governata da oggetti: per quanto l’essere umano si illuda di essere padrone e centro del mondo, l’estetica tradizionale è, di fatto, sottomessa alla tirannia degli oggetti. Entrare in relazione con le cose (pragmata) significa aprirsi a esse, assumere una postura di ricezione e dunque far ritrarre l’ego. Il mondo, infatti, è al massimo costituito da cose, non da oggetti: a differenza di ciò che solitamente si intende con «oggetto» (ob-jectum, «posto innanzi» – ma a chi? A un ego), una cosa (pragma, ovvero «azione, fatto») agisce e patisce: è processo, relazione. Le cose, configurandosi come nodi di relazioni, annullano ogni differenza tra oggetti e soggetti.
Il rischio di una percezione oggettuale del reale è messa bene in evidenza da Tim Ingold, le cui idee sono tra le principali protagoniste di questo saggio: in Making (Raffaello Cortina, 2019), Ingold riflette su come, nel diventare oggetti, i materiali sono «stati recisi da quelle vite e lasciati senza vita». In questo modo, se si smette di percepire la realtà secondo la logica (s)oggettuale, crolla il castello di carte dei dualismi e conseguentemente anche quello dell’individualismo: ci si apre così alle diverse densità del reale, a un percepire non a senso unico e non lineare. Il secondo capitolo del testo, Il reale è relazionale, inizia infatti con una citazione di Carlo Rovelli, che ci aiuta a comprendere come una pietra non sia un oggetto solido ma
una complessa vibrazione di campi quantistici, un’interazione momentanea di forze, un processo che per un breve lasso di tempo riesce a mantenere l’equilibrio prima di tornare nuovamente polvere, un fugace capitolo nella storia delle interazioni tra gli elementi del pianeta, una traccia di umanità neolitica, un’arma dei ragazzi di strada, un esempio per una discussione tra di noi, la metafora di una cattiva ontologia, parte di una partizione del mondo che dipende più dalle strutture percettive del nostro corpo che non dal mondo stesso […] È un nodo complesso di questo gioco di specchi infiniti che è la realtà. (p. 36)
Partendo da questo approccio alla conoscenza e alla riflessione intellettuale, declinata nel senso di un relazionismo radicale, ecologico e implicativo, diviene chiaro il ruolo fondamentale affidato all’estetica, dal momento che la filosofia non deve limitarsi alla riflessione su, ma deve essere in grado di prospettare nuove modalità di vivere e di sapere. L’estetica non riveste il semplice ruolo di disciplina analitica, o di teoria dell’arte, o ancora di ponte che collega soggetto e oggetto, ma assume un carattere eco-logico: sentire e pensare ecologicamente.
L’estetico è «il richiamo a tutto ciò che accomuna, l’extra-individuale e, dunque, non antropocentrico» (p. 22); allo stesso tempo, è proprio l’estetico ad avere il carattere di consapevolezza di tale richiamo, e dunque a rientrare in una dimensione del tutto umana. La riflessione di Estetica senza (s)oggetti è pertanto orientata verso un approccio non antropocentrico e, tuttavia, non per questo post-umano: ciò che occorre, infatti, è invece «un’umanità differente» (p. 9), un’umano che si fa, che sta nel mondo in maniera sostenibile «attraverso un procedere, riprendendo e avvicinando, animando» (p. 9). In questo senso, Perullo è più vicino alla proposta di Haraway di pensarci come compost: proporre un’estetica del compost significa qui invitare Homo a percepire e percepirsi come compost, come corrispondente, convivente, cooperativo, comunicante, con-dominiale; significa fare un’estetica radicalmente con-. L’idea di compost si lega necessariamente a quella di humus: l’umano è humus, ma humus è composto, in continua formazione e in comunità. L’idea di humus rievoca, quasi inevitabilmente, l’immagine della terra, del terreno e del territorio. Nulla di più lontano dalla proposta di Perullo, che mette in guardia da possibili fraintendimenti e, invece, invita a pensare l’umano come «composto di acqua, di aria, di vento» (p. 13). Il richiamo a un approccio radicale, che sia dunque senza compromessi e vada alla radice della questione, a fondo, e all’humus, non va inteso come una ricerca, o una rivendicazione, di fondamenti: l’estetica senza (s)oggetti non ha né fondamento né fine, in essa non c’è spazio per l’ontologia, né tantomeno per la teleologia. Non terra, ma vento: è questo l’elemento che ci apre alla fluidità del reale, che ci riporta al pensiero rizomatico e al vivere nomadico. Al privilegio tradizionalmente concesso alla solidità, dacché sarebbe l’elemento terrestre a consentire quell’apparenza di fondamenta, di essere alla base della conoscenza (s)oggettuale, Perullo oppone un’estetica fluida, che sappia riconsiderare il ruolo di acqua e vento. Il potere dispotico del solido e della visione oggettuale sono a fondamento dell’azione come dominio individuale.
Un altro aspetto da sempre privilegiato dalla tradizione occidentale è quello del visivo. Tutto ciò che vedo è, in principio, alla mia portata: attraverso un approccio ottico si istituisce una relazione di dominio esercitato per presa di distanza senza partecipazione al mondo. È l’approccio su cui per lungo tempo si è modellata la conoscenza della realtà: historìa in greco indicava la ricerca e la conoscenza acquisita tramite indagine, ma anche la conoscenza che si ha perché si è visto qualcosa. La prevalenza della visione ha dunque radici ben salde nella storia del pensiero occidentale, almeno tanto quanto l’idea che il pensiero, per essere buono, debba essere solido e fondato. La filosofia stessa è diventata, da amore della saggezza o della sapienza, una visione del mondo. Eppure, oggi i privilegi del visivo e del solido si rivelano «pregiudizi perché incapaci di farci corrispondere col mondo – sia in termini cognitivi (ciò che sappiamo su di esso) sia in termini eco-estetici ed etici» (p. 61). La visione riconduce la conoscenza a rappresentazione; se invece proviamo a fare a meno di questo paradigma, ci rendiamo conto di come non ci sia possibile avere un punto di vista sul mondo, poiché siamo noi a essere del mondo. In altre parole, a venire modificate sono le nostre pratiche conoscitive: «la filosofia e la scienza non si percepiscono più come visioni, rappresentazioni del mondo. Non abbiamo un punto di vista sul mondo perché siamo un punto di vista del mondo» (p. 62).
Seguendo l’idea di etic-onto-epistemologia di Barad, ossia dell’inseparabilità, nella produzione di conoscenza, dell’entanglement di etica, ontologia (qui deposta a favore dell’ontogenesi) ed epistemologia – quindi con il mondo stesso e i suoi abitanti – possiamo affermare che la nostra conoscenza del mondo deriva dal nostro essere collocati al suo interno. L’idea che possiamo congedarci dal mondo per conoscerlo, analizzarlo da lontano, fa parte del corredo di illusioni che caratterizzano l’approccio frammentario e dualistico alla realtà. Al contrario, la nozione di aptico, già presentata da Perullo nei suoi scritti precedenti e a cui è qui dedicato il quarto capitolo L’aptico, percepire animato e animante, riveste un ruolo di primo piano all’interno di un’estetica pienamente ecologica, dunque in grado di fare a meno di soggetti e oggetti. Il percepire aptico è infatti «patire agendo», è un essere colti dall’esperienza più che esperire; al percepire aptico corrisponde un assottigliamento dell’ego che evapora in favore di «sentendo» impersonale.
Forse però la novità principale di questo testo è il continuo tentativo di fare a meno, di spogliarsi, dei verbi «avere» e «volere». Più di tutto, esso («estetica senza (s)oggetti», in opposizione a ego) non vuole proporre sostituzioni, ma invitare a un percepire che parta da una strategia differente, che si fondi sull’idea dell’inesistenza di modelli giusti o sbagliati in assoluto. La logica di esso non è sostitutiva, ma connettiva, collettiva, cumulativa e analogica. Ciò che ci propone è il superamento di un modello (s)oggettualistico: fare a meno del soggetti ma anche degli oggetti, per approdare a una concezione relazionale e processuale del reale; insomma, riconoscere il mondo, e dunque noi stessi, come processo continuo, come una composizione fatta di nodi complessi di relazioni. Tale invito a percepire e sperimentare un modo diverso di vivere non si esaurisce nella mera proposta filosofica, ma coinvolge l’arte, la scienza, l’archeologia e la cucina.
Fare filosofia, fare antropologia, fare scienza, ma anche mangiare e guardare un dipinto è fare con: fare con le persone, sì, ma soprattutto fare col mondo. Gustare, ad esempio, non è un insieme di capacità critiche o di competenze, ma ha a che fare con quella che Perullo chiama compassione estetica (il latino cum patior si è formato per calco del greco sym patheia, un sentimento di partecipazione alle emozioni altrui, poi declinatosi nel solo senso della sofferenza), ovvero l’attitudine che il dilettante, inteso come amatore, ha nel riconoscere il con che attraversa in egual modo il gustante, professionista o meno. Mentre il critico si pone a distanza, opera un’analisi, ovvero opera per scomposizione e studio delle singole parti, il dilettante attraversa l’esperienza dall’interno e ne è attraversato, riconosce il valore comune e la corrispondenza tra sé e l’altro a cui va incontro, sia esso un’opera d’arte o una pietanza. In particolare l’esempio della cucina, evocato trasversalmente nel corso del testo e a cui è dedicato il capitolo di chiusura Discontinuità percettiva, per procedere, si adatta bene a mettere in luce il carattere dell’arte tutta come evento relazionale e sociale: la cucina infatti «abbatte le barriere tra spazio istituzionale e ordinario, superando l’idea di “autore” individuale e configurandosi come opera realizzata da artefici singolari e non da autori individuali». (p. 211).
In coda, è infine interessante notare come, all’interno di questa disamina, spazio privilegiato sia dedicato al linguaggio e all’uso delle parole. Anche chi cerca di uscire dal recinto antropocentrico, infatti, spesso sembra ricorrere a un insieme di termini che, a ben vedere, non fanno altro che rafforzare la separazione tra soggetto e oggetto alla base. È ciò che accade col concetto di «interazione», che sembra porre al centro il carattere relazionale della realtà e che, al contrario, finisce per svelare un pensiero compromesso con la mentalità dualistica e separatistica: «prima gli individui, poi gli incontri». L’inter-azione richiede individui autonomi, chiusi in se stessi, segmentati; in realtà, gli individui non sono mai tali, ma sono già sempre fasci di relazioni che si corrispondono e prendono parte a un mondo che è sempre con-.
Lo stesso problema si presenta con il termine «immersività», il quale trova oggi ampio utilizzo negli ambienti specialistici così come nel discorso pubblico: un’immersività intenzionale e programmata, di cui usufruire in situazioni apposite e studiate, percepita come esterna e da ottenere tramite dispositivi appositi; ma, per Perullo, noi siamo sempre già immersi nell’atmosfera del vivente e degli eventi. L’immersività, per come viene proposta oggi, è solo l’ennesima iterazione del dualismo soggetto-oggetto che ontologizza la realtà del vivente e ci illude che la nostra percezione, di umani, sia distaccata e oggettiva. Credere di poter entrare e uscire dal carattere immersivo del reale significa riprodurre una retorica di eccezionalità umana, che può scegliere come, dove, quando, e per quanto, entrare in relazione con l’altro. Così interpretata, l’immersività è il perfetto corredo della nozione di inter-azione: entrambe fanno riferimento a soggetti che sono autonomi, individuali, delimitati e autosufficienti e che solo successivamente hanno bisogno di essere messi in relazione – come se la relazione fosse un ponte, un banale strumento e non la materia stessa del vivente. L’interazione e l’immersività sono imperativi ad agire come unica modalità di relazione col mondo. Necessitiamo di meno interazione e più intra-azione (con Barad) o corrispondenza (con Ingold); meno dialettica e più comunicazione; meno competenza e più compassione. Ciò che emerge dal libro di Perullo è una radicale messa in discussione del pensiero ego-centrico, oculo-centrico, binario, lineare, fondato, metodologico, che fa della rigidità e della disciplina una cieca virtù – un pensiero che oggi non solo non funziona più, ma intralcia il vivere dell’uomo nel, e con il, mondo.
Nicola Perullo è filosofo e docente di Estetica presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Il suo ultimo libro continua il percorso già iniziato coi precedenti lavori, tra tutti Estetica ecologica. Percepire saggio, vivere corrispondente (Mimesis, 2020), ma riprendendo anche, nei singoli capitoli, le riflessioni già proposte in Epistenologia. Il vino e la creatività del tatto (Mimesis, 2016) e Il gusto non è un senso ma un compito (Mimesis, 2018).