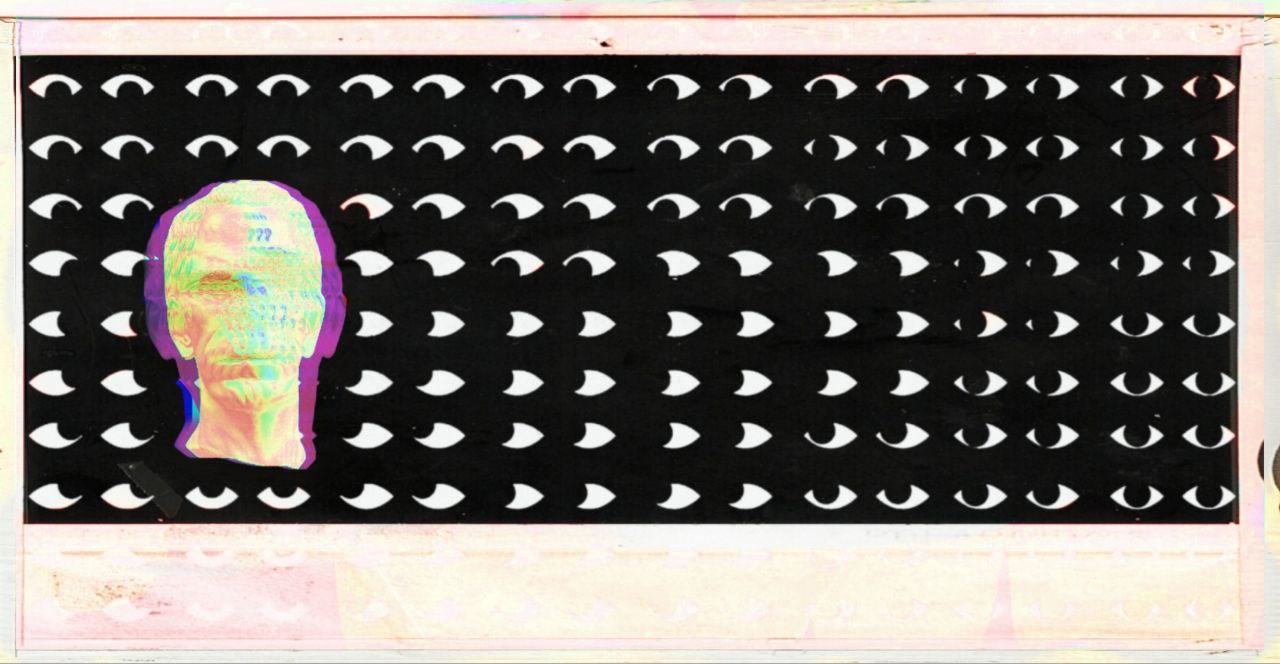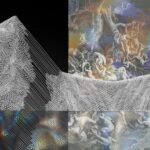Nel tentativo di comprendere il legame tra capitalismo e sorveglianza, soprattutto tra l’impositività capillare e rizomatica del primo e la costruzione – nonché la progressiva sterilizzazione – dell’immaginazione e dell’immaginario sociali contemporanei, la studiosa Lina Dencik, in un lavoro del 20181, sostiene la necessità di partire dall’analisi delle caratteristiche del capitalismo realizzata da Mark Fisher2 al fine di individuare il ruolo funzionale svolto dalla pratica della sorveglianza, principalmente nel rendere possibile l’implosione di una qualsiasi forza (ri)costituente e trasformativa. Ma, per quanto la docente dell’Università di Cardiff colga con acume che sia proprio il carattere sur-pervasivo del capitalismo a determinare una certa forma di autismo immaginativo e di improduttività creativa, individuale e sociale – oltre che a tradursi, quasi naturalmente, nell’operatività del controllo di massa –, in effetti dedica uno spazio limitato alla disamina del fondamentale concetto di ‘realismo capitalista’, attraverso il quale Fisher veicola la sua filosofia politica. Per questo, volendo mantenere per buona e sollecitante l’intuizione di Dencik riguardo a uno strutturale sodalizio, nella contemporaneità, tra capitalismo, immaginazione e sorveglianza, pare necessario, però, approfondire ulteriormente proprio il concetto preliminare e condizionale di ‘realismo capitalista’, dal quale, in seconda battuta, potranno essere tratteggiate con maggiore lucidità le altre due tematiche collegate, ovvero immaginazione e sorveglianza.
Per prima cosa non deve essere trascurato il fatto che l’analisi di Fisher del realismo capitalista venga condotta attraverso il commento al film del 2006 di Alfonso Cuarón I figli degli uomini, pellicola distopica che trasuda in modo impressionante la fattualità/effettualità del tempo presente, per costruire la cornice più idonea a collocare l’intero discorso nella sua sede interpretativa, quella nella quale abitano terribilmente la contraddizione e il paradosso, senza possibilità che essi a un certo punto trovino soluzione e appianamento. Ciò che emerge del capitalismo – inteso nel suo realismo quale dimensione che impone la sua pensabilità, in modo univoco, come un sistema politico ed economico che impedisce già solo di immaginarne un’alternativa coerente –, è la coalizione armonica e non dissonante tra ultra-autoritarismo e Capitale, ovvero tra Stato (che quell’autoritarismo incarna ed espone, con i suoi confini e i suoi obblighi e divieti) e Capitale (che tende a scorrere e scivolare per esistere, eliminando limiti e frontiere, per l’appunto identificanti la sfera dello Stato). Per questo si va configurando, per Fisher, l’integrazione tra questi opposti: da un lato, il Capitale, al contrario della sua speculativa classica definizione che lo vede in antitesi organica allo Stato, colloca in quest’ultimo le sue stesse condizioni di sopravvivenza e di accrescimento; dall’altro, lo Stato, per poter adattarsi a sempre inediti e cangianti situazioni culturali, storiche, sociali, economiche e politiche, deve lasciarsi pervadere dalla liquidità debordante del Capitale, assorbendone così il principio medesimo dell’uguaglianza piatta e uniforme, dello scrostamento di tutte le inutili e dannose asperità e scabrosità che possano generare rallentamenti, quando non l’immobilizzazione stessa di sé e del Capitale. È come dire che, in tale organico rapporto tra Stato e Capitale, l’uno risulti indispensabile all’altro in un gioco di reciproca legittimazione e promozione, o, per dirla diversamente, di vicendevole supporto. In Fisher il Capitale senza Stato è nudo. Vulnerabile. In-potente. Di converso lo Stato senza Capitale è privo di finalità. A-semantico. Kenotico.
In certo senso, se, per un verso, il Capitale vede nello Stato il suo paracadute costante, soprattutto in tempi di crisi – quando può contare su di esso come eutrofico fondamentale per ri-stabilirsi in circostanze eccezionali di collasso –, per un altro, lo Stato investe la sua propria forza e potenza nel Capitale per auto-teleologizzarsi, cioè per finalizzare la sua esistenza, così da perpetuarsi e svilupparsi, sfruttandone la carica e lo slancio produttivo. Ma ancor di più, e al contrario di quanto si possa pensare, proprio l’integrazione di Capitale e Stato permette alla idraulicità del primo di impiegare l’aspetto limitante del secondo, espresso dal suo carattere poliziesco e militare, come sua condizione imprescindibile di incessante superamento e indeterminata replicazione. Nel senso che la natura contenitiva e controllante dello Stato, esposta attraverso la legittimità della sua forza obbligante, costringente, confinante, viene utilizzata dal Capitale come quel ‘limite-da-superare’ continuamente, senza il quale esso non potrebbe presentarsi come quel superamento infinito stesso che propriamente è. Senza confine, nessun oltrepassamento. Senza limite, nessuna illimitatezza. Senza Stato nessun Capitale.
È per questo che, come sottolineato da Fisher – e argomentato in tante altre interessanti direzioni e declinazioni da Paolo Gerbaudo, sociologo e teorico della politica della Normale di Pisa, in un suo recentissimo studio dal titolo Controllare e proteggere. Il ritorno dello Stato3 –, lo Stato si è ripresentato e riaffermato, anche meglio e più che nel passato, proprio grazie al ruolo totalizzante ed avvolgente che si è guadagnato nell’attuale situazione di incertezza e caos che oggi è determinata da pandemia e guerra, mentre solo ieri era prodotta dalle peripezie del Capitale – con questo non volendo da parte nostra per niente trascurare l’ipotesi che proprio pandemia e guerra possano essere rappresentate come le nuove modalità fenomenologiche dell’irrequietezza del Capitale medesimo! Insomma lo Stato, e il margine che esso raffigura materialmente, è allo stesso tempo la garanzia onto-tetica del Capitale e il mezzo inedito della sua riproduzione, dacché contribuisce ad alimentarne internamente – come soglia-già-sempre-superata, come limite-in-sé-illimitato e producente-illimitatezza proprio mentre svolge la sua funzione limitante: miracoli del Capitale! – l’enérgheia e la vitalità. Dunque Stato come interiore negazione, che però, nella sua ob-posizione, autorizza implicitamente il Capitale a dilatarsi, presentandosi come la sua condizione di possibilità e di attuabilità. Una negazione che è diventata attualmente indispensabile all’accadere stesso del Capitale, e che esso, mantenendo sempre viva e operativa, trascina con sé quale presupposto interiore intoglibile della sua propria posizione in essere. Quella negazione che costituisce il necessario prerequisito, logico e fattuale, della taxis del Capitale, ovvero ciò senza di cui esso o sarebbe in-significante o non sarebbe affatto, almeno nella forma diluita in cui lo conosciamo nel presente.
A conferma di tale direttrice esegetica, anche se con le debite distinzioni, si potrebbero considerare proprio gli studi – che in questa sede non è possibile approfondire – di Byung-Chul Han ne La società della stanchezza4 e L’espulsione dell’Altro5. Qui il tema della soppressione della negazione a fini iper-performativi e quello con-corde del rigetto dell’alterità – ordinato all’affermazione dell’unicità dell’Uguale –, si configurano come aspetti dello stesso plesso teorico della omogeneizzazione totalizzante, frutto dell’azione di un Capitale digitale, che, attraverso l’esasperazione di una comunicazione-senza-comunità, di un’informazione-senza-limiti, di una connessione permanente, di una velocità incontrollabile, tende a imporsi come positività dell’Uguale. Esso, per porre (“ponere”) se stesso, deve ob-porsi – nel caso di Han per eliminarla/annientarla definitivamente, mentre nel caso di Fisher per mantenerla-per-superarla-continuamente – all’implicita pre-costituente negazione, che cioè la anticipa logicamente e prassicamente; rapporto, questo, che nel linguaggio e nella rappresentazione teoretica propria di Fisher viene incarnato appunto dal Capitale (l’Uguale) e dallo Stato (la negazione).
Il filosofo inglese, inoltre, rimarca come la dimensione in cui si situa la statualità dello Stato realistico-capitalistico sia quella non di un’eccezione della democrazia – di una sua sospensione temporanea, di una sua contingente interruzione a causa di eventi stra-ordinari che mettano in crisi l’impianto ordinariamente democratico dello Stato –, ma di una democrazia, la cui democraticità altro non sarebbe se non la normalizzazione dell’eccezione e la standardizzazione dell’a-nomalia, ovvero la ordinarizzazione della crisi continua, che consente una certa fluidità giustificativa delle azioni del governo e delle disposizioni giuridiche, cosicché si stemperi e si svigorisca anche il diaframma esistente tra (ultra-)autoritarismo e democrazia, i quali possono con-vivere storicamente e fattivamente anche se sono tra loro contradditori logicamente e semanticamente. Per questo il realismo capitalista, da un lato, riesce a tenere insieme processi e concetti opposti o dis-omogenei, mentre dall’altro, esige che, per realizzare tale risultato prodigioso, l’atmosfera culturale e ideologica di base deve ispirarsi all’accettazione e alla legittimazione sociale della ‘continuità ininterrotta dell’eccezione quale neo-iconicità, teoretica e pratica, della democrazia. Ovvero pretende che una svolta radicale si avveri a livello dell’immaginario collettivo, il quale non dovrebbe più cogliere come stridente la relazione tra autoritarismo (profondo), Stato e democrazia, ma che anzi la debba avvertire come un’occasione imperdibile proprio per perseguire il “bene” di tutti i cittadini, che, anche questo, dovrà prospettarsi come compatibile proprio con quel Capitale induttivo della maggioranza delle disparità e disuguaglianze sofferte dalle democrazie contemporanee. Alla fine, se ben si valuta, la ‘morte della differenza’ rappresenta cogentemente e al contempo la precondizione e la conseguenza alterate, ma purtuttavia accettate socialmente, di una sorprendente e quanto (or)mai regolare e usuale (dis-)attività dell’immaginario collettivo.
Ed è allora, proprio in virtù di tutto ciò, che assume un profilo più chiaro il discorso di Fisher sull’impercettibilità della catastrofe in cui sono immersi i figli degli uomini, ovvero gli individui di un futuro molto più che presente, che si agitano nella tragicità del qui e ora, iper-tecnologicamente sorvegliato, dilaniatamente oltre-umano. Quello che pare scomparire, dunque, è proprio il limes differenziale, che permette(rebbe) l’intercettazione del principio della catastrofe, dell’inizio del rovesciamento, dell’avvio dell’inversione, ma che, invece, nel presente viene inghiottito a ritroso – senza che di tutto ciò si abbia esperienza e senza che ne rimanga traccia – dal (e nel) suo stesso prodotto, ovvero dall’occorrere medesimo della catastrofe ormai a-cefalizzata, an-archizzata, de-capitata, de-eziologicizzata, ridotta al suo puro presentarsi e al suo assoluto scorrere impersonale. Cosicché si affermi la coscienza (?) che la sinistra situazione attuale non solo non sia effetto di una qualche precisa causa, ma anche che non abbia nessun responsabile: le cose, a ben vedere, devono mostrarsi come disposte così, come ora sono, già da sempre, secondo una condizione di depressione, desolazione e rovina, nella loro mera e ininterrogabile fattualità e fatalità. Se, quindi, sparisce per incanto la potenza negativa dell’inizio della catastrofe, che sollecita, con la sua dis-parità infrattiva, l’attivazione della sensibilità e dell’attenzione (verso di essa), e anche della critica, allora la catastrofe non potrà mai essere l’eccezionale frutto marcio di un albero che un tempo era stato buono, da osservare e da contrastare, ma il normale stato di piatta e continua ordinarietà del neo-umano, di quel nuovo umanesimo che stilla degenerazione e devastazione proprio mentre costruisce, tessendone le lodi e innalzandone gli inni, l’inarrestabilità del progresso tecnologico e l’incontrovertibilità del digitale. Uno stato di perenne eccitazione, di frenetica esaltazione, che, dinamizzando all’estremo e senza soluzione di continuità l’esistenza di singoli e collettività, in associazione integrata all’operatività di apparati macchinici e di intelligenze artificiali algoritmiche, genera spontaneamente stati di visionaria ipnosi, di narcomatica prostrazione, di abbacinato intorpidimento, che appannano la coscienza proprio mentre la infiammano e la elettrizzano.
Dunque si è davanti a una catastrofe continua, non più capace di mostrare la sua storicità, ma che afferma, al contrario, la sua onto-metafisicità compiuta, la sua estensione infinita, la sua Totalità impulsiva, talmente piena da rendere impraticabile l’immaginabilità di qualsivoglia alternativa, di uno spazio altro di manovra, di una via d’uscita, della stessa speranza che possa esistere un futuro a cui guardare con fiducia. Grazie, quindi, a un’investigazione più elaborata del concetto di realismo capitalista di Fisher, che nel connubio Stato/Capitale individua il dispositivo di attuazione della saturazione della realtà, si può conseguentemente cogliere, con maggiore pregnanza e consapevolezza, lo sviluppo del correlato strangolamento dell’immaginazione umana e della castrazione psico-chimica dell’immaginario antropico di cui parla Dencik. Essi, causati anche dall’idea per cui nulla di nuovo possa ormai emergere e per cui ogni azione trasformativa dell’esistente sia del tutto inutile e inefficace, anzi addirittura un danno laddove sia già solo la si pensi, vengono legittimati e promossi anche e proprio dalla sorveglianza, individuo-puntuale e massivo-generale, messa in atto dall’unico apparato che abbia le risorse economico-finanziarie e l’armatura tecnologica per poterla così ampiamente sostenere, promuovere e attuare, ovvero lo Stato, in collaborazione con i colossi transnazionali del digitale. Lo Stato, in tal modo, tenendo “sott’occhio” i propri cittadini, sempre “per il loro bene” e “per la loro sicurezza”, porta a realizzazione il compito di deprimerne ogni forma di accensione immaginativa, culturale e politica, e di consegnarli alla docilità subordinata nei confronti del Capitale, di cui è alleato fedele. Se, quindi, come Fisher sostiene, agire è inutile, non è perché si sia arrivati al punto nel quale, avendole provate tutte, si è assunta la consapevolezza che il Capitale sia inattaccabile e inscalfibile per la sua maggiore forza intrinseca – questo anche, semmai! –, ma soprattutto per il fenomeno della ‘sterilizzazione preventiva e cautelare dell’azione, intesa come spegnimento dell’azione (sociale) lì dove invece dovrebbe o avrebbe dovuto accendersi per produrre effetti. Detto diversamente: prima che l’azione trans-mutativa prenda corpo e si esplichi nella dimensione della realtà, in capo a essa deve necessariamente essere forgiata un’immagine preventiva della stessa (che pre-figuri la sua forma e la sua direzione applicativa, oltre che anticiparne sommariamente gli esiti esecutivi sull’orizzonte materiale e simbolico su cui impatta). In virtù di ciò, il fatto che essa venga al contrario insterilita nel suo tratto in-ventivo/generativo significa un inasprimento radicale e massimalistico del suo ‘governo depressivo’ da parte del potere capitalistico/statualistico. Questo, purtroppo, è un aspetto ormai divenuto talmente dominante e dilagante, che il non-luogo che l’u-topia contiene come sua essenza significale, intesa però come l’ideale verso cui l’azione (vorrebbe e dovrebbe) tende(re) con tutte le energie possibili affinché possa mutarsi in realtà, in effetti si è esso stesso con-vertito in non-luogo-a-procedere, anzi addirittura in a-prioristica in-fecondità, in trascendentale vacuità, in cinerea nihil-ità. Un aborto come (non-)inizio di una (non-)azione all’interno di una realtà in cui la singolarità eccezionale della catastrofe si è normalizzata, cosa che produce una saturazione soddisfacente e un’assuefazione saturante.
Tale insterilimento dell’immaginario, intimamente connesso con il carattere colmativo e riempitivo, in modo assoluto, del Capitale, per il tramite ingiuntivo e obbligativo dello Stato, si lega rigorosamente alla pratica della sorveglianza, che agisce (e questa sì che è una vera azione, per di più permanente e pervasiva!) come attuale strumento privilegiato di espressione del potere. La sorveglianza, però, estesa e diffusa in modo ramificato e minuzioso, ovvero dilatata all’infinito, dimensione propria dello spazio del Capitale, disperde in esso la verticalità e la perentorietà della propria direzione osservazionale e monitorativa, cosicché si perdano le vestigia minacciose della sua presenza e la percettibilità della sua funzionatività castigativa. In tal modo la coercitività che è insita nella definizione stessa della sorveglianza e nella sua propria naturale operatività, e che genera ed estorce automaticamente obbedienza agli osservati, in fin dei conti, disciolta e stemperata com’è nell’indeterminazione reiterata della pratica del controllo totale, oltre-panopticale, di massa, pur continuando a mantenere la sua funzione e il suo ruolo asimmetrico e dissimmetrizzativo, viene però percepita (?) dai soggetti controllati/obbedienti solo come ‘ordinaria compagna di viaggio’ nella propria esistenza individuale e sociale. Con l’ulteriore conseguenza paradossale di ingenerare nei singoli soggetti la docile richiesta, implicita e spontanea, di mantenerla attiva su di sé costantemente, quasi a volerla concepire ormai come componente con-genita della propria definizione identitaria, della propria ontologica dimensionalità, della propria strutturalità funzionale. Una sorta di neo-vocazione alla subordinazione e all’obbedienza coatta, che la sorveglianza digitale di massa sottende di per se stessa, e che si esplica nell’anti-libertario ‘narcisismo del sorvegliato/obbediente’, il quale ormai non riesce a intendersi se non con un occhio elettronico sulla testa, che, a ben guardare, ormai gli si è completamente interiorizzato, con l’effetto per lui di sentirlo parte integrante e ineludibile di sé. Così, il risultato per il quale l’attivazione di dispositivi di sorveglianza di massa – mezzi propri di un realismo capitalista digitale di Stato, saturo e saturante l’immaginazione individuale e sociale – si configura come sistema di controllo ad altissimo tasso di pervasività è che il carattere interdittivo della struttura panopticale, tipica della società disciplinare-punitiva, capace di determinare obbedienza passiva ex post, si volge in coazione preventiva che, al posto di condannare e punire una qualsiasi azione anti-sistema e de-regolante eseguita in risposta a una direttrice obbligativa, al converso smorza sul nascere la sola concepibilità di un agire-contro, di una resistenza. In definitiva disattiva ogni dispositivo di sanzione dal momento che ha anticipatamente disinnescato ogni potenziale azione peccaminosa/oltraggiosa. Di conseguenza il passaggio dal Pan-opticon al Ban-opticon (dove ban sta per punizione, interdizione e bando) non fa altro che rivelare un arretramento sempre maggiore del potere di inibizione dell’azione, addirittura al livello del concepimento dell’immagine stessa dell’azione. Ma anche oltre, vista l’indeterminatezza dell’applicabilità e dell’efficacia produttivo-interdittiva della sorveglianza digitale. Una specie di contemporaneistico regressus ad infinitum dello sguardo artificiale sorvegliante, che blocca l’azione non nella sua esecuzione, bensì nella sua stessa condizionalità approntativa individuale e sociale, così che essa sparisca del tutto dall’ordine, illimitatamente e retificatamente costituito, che il Capitale è stato capace di generare nel tempo, partorendo quel fisheriano realismo che, opprimendo e soffocando l’esistente, oblitera le coscienze e le abitua a essere remissive e accondiscendenti nei confronti del potere di cui è espressione, con la conseguenza di indurre il sorvegliato/obbediente alla complicità con il suo stesso carceriere. E ciò perché nel Ban-opticon la perimetralità del carcere, che pur nel fondo rimane esattamente com’era nella società disciplinare, ha smarrito però la sua concretezza e la sua percettibilità, in ragione di quella strumentale de-materializzazione dei confini, capace di trasformare l’effettiva e sostanziale reclusione in sensazione di apertura (e libertà) illimitata. Quella unica e totale, però, che, seppure in termini completamente inediti, definisce comunque una spazialità totalitaria, non priva di limiti costrittivi, ma semmai provvista di una radura digitale in-finita che, allo stesso modo dei confini carcerari, costringe i soggetti alla detenzione e all’isolamento visto che a quello spazio in-finito non v’è alternativa. Un lockdown dell’/nell’aperto, sintomatologico di una lucida follia, di cui si stenta ad avere coscienza.
Ma questa situazione è considerabile come un amaro, inesorabile e inevitabile destino? Può davvero lo spazio stato-digitale infinito del capitalismo (e) della sorveglianza ottundere l’immaginazione dei singoli e delle collettività fino al grado di avvilire qualsiasi ipotesi di cambiamento radicale che essi possano avanzare, di schiacciare cioè l’immaginario sociale sulla funzione di mera legittimazione confirmativa dell’esistente, di una sua unicamente reiterabile e interminabile riproduzione? Fino al grado cioè di assoggettare totalmente le umanissime istanze utopico-progettuali e trasfigurative della realtà, cosicché rispetto a quest’ultima si possa solo assumere una postura rassegnata di ricezione, accettazione e consenso? Perché l’immaginazione sociale torni a esprimere la sua energia ideale, ovvero a ripresentare in pubblico il carattere dirompente della possibilità e della potenz(i)a(lità), relegando a uno spazio minore l’immaginazione ideologico-riproduttiva; perché si porti a demolizione il muro dell’anti-utopismo, costruito coi mattoni dell’adattamento, curvo e subalterno, a una realtà de-semantizzata o uni-semantizzata; perché si rifugga dallo scenario inquietante di una de-politicizzazione completa della vita sociale, ovvero di una cessazione per decreto della relazionalità inter-individuale finalizzata alla costruzione di un’azione comune, democratica, di cambiamento dell’esistenza sociale, è fondamentale soprattutto assumere la piena coscienza del tenore e della consistenza tanto delle pratiche discorsive quanto delle relative sanzioni di sostegno attraverso cui oggi vengono concretate e puntellate le norme di condotta incoraggiate, giustificate e ratificate dal Capitale nel suo applicarsi alla società.
Comprendere, dunque, il ruolo centrale dello Stato contemporaneo nel suo servizio al Capitale per mezzo dell’impiego della legittima esclusiva forza di obbligazione e di sanzione, entrambe esemplificate nell’azione allo stesso tempo verticale e orizzontale di sorveglianza e controllo di massa di individui/cittadini, oltre che nell’applicazione di un diritto penale totale6, vuoto, e pericolosamente onni-significabile, non vuol dire non aver aggiornato e superato (la teoria del)la società disciplinare di Foucault, ma, diversamente, di aver colto proficuamente la permanenza della strutturalità disciplinare nel maquillage, fascinoso e seduttivo, a cui il Capitale ha sottoposto la società attuale al contrario considerata post-disciplinare. La smaterializzazione e la digitalizzazione delle relazioni politiche ed economiche, per quanto sia in grado di dilatare e portare alle estreme conseguenze percettive l’idea foucaultiana di microfisica multipolare e plurinodale del potere, non può però celare che tale liquefazione spaesante e contro-localizzativa non impedisca una determinata canalizzazione fenomenologico-ricettiva del potere. Dinamica, questa, rinvigorita proprio dall’intervento dello Stato, il quale, nonostante il più famoso informatico della storia statunitense, Edward Snowden, ritenga che non sia più l’unico e principale detentore del controllo della sorveglianza, e a prescindere dal fatto che Bernard E. Harcourt impieghi il concetto di oligarchia per indicare il nuovo trasversale gruppo di attori (commerciali, finanziari, tecnologici, dell’intelligence, dello spionaggio) che possiede dis-articolatamente la gestione della sorveglianza globale, rimane, proprio per la sua forza obbligativa, la capillarità del suo apparato burocratico e la sua potenza economica, l’interprete principale della pratica di governo degli individui, che consente la con-vergenza attuativa delle molteplici azioni monitorative realizzate dai tanti e diversi soggetti della sorveglianza. E questo è da considerarsi un punto ineludibile nell’elaborazione di una risposta critica e nell’organizzazione di una resistenza nei confronti della sorveglianza di massa praticata dagli Stati o da aziende private, con il placet, anche indiretto, degli Stati medesimi. Per opporsi alla forma digitale-sorvegliativa assunta dal potere che il Capitale esplica, anche e soprattutto attraverso lo Stato e la sua forza/potenza, non solo bisogna cominciare a trattare, come Fisher suggerisce, il capitalismo nella sua realtà storica come una prassi e un’ideologia non necessaria, insostituibile, ma contingente, nonostante la sua pervasività conduca a credere il contrario, così da individuare delle possibili alternative ad essa, ma sarebbe opportuno, al di là o in integrazione all’attivismo reattivo per la protezione contro la sorveglianza, l’esacerbazione della datificazione e gli eccessi di data-ismo, avviare una riflessione sull’inquadrabilità morale di atti ingiusti, dall’aspetto digitale, perpetrati dallo Stato – sotto forma di sorveglianza e di correlato atteggiamento sanzionatorio – nei confronti dei propri cittadini7. In tal modo ripristinando quello spazio pubblico, concretamente/materialmente/umanamente connesso, secondo la butleriana formula della alleanza dei corpi8 – e non certo di pixel o di avatar o nickname –, necessario a ri-attivare percorsi di critica e di resistenza, legittimi e intangibili per una democrazia. E questo sotto la granitica condizione che l’immaginazione individuale e collettiva riprenda a generare fiduciosamente rappresentazioni sorgive di un futuro emancipato e autonomo, scettico e dialettico, in cui sia possibile che la sorveglianza, intesa come sistema operativo del potere, sia essa stessa posta sotto sorveglianza critica continuativa da parte degli individui/cittadini, fino a porla in definitivo declino, affinché al paradigma del controllo si sostituisca quello della con-laborazione e della con-divisione. E si riabiliti, così, l’assonanza semantica e fattuale tra libertà e democrazia, troppo deteriorata e degradata da processi destitutivi provenienti dall’alto e profondamente de-significata e mortificata da in-azioni avallate dal basso.
Eppure la condizione, metodologica e contenutistica, che può rendere praticabile tale inversione di rotta è rappresentata dalla costruzione di un doppio piano di resistenza: uno di tipo collettivo e politico, l’altro di tipo ideale e sistemico. Per quello che concerne il primo, in base ai contenuti dello studio di Dencik9, la concentrazione della resistenza su gruppi di interesse – che operavano una certa pressione di lobbying nei confronti dei legislatori chiamati in causa a giudicare di lesione di diritti di privacy, di compressione delle libertà di espressione in Internet e di violazione dei processi/procedure di protezione dei dati –, ha comportato uno slittamento dell’opposizione a un livello di individualità o di elitarietà, che, centrato eccessivamente su specifiche e particolari competenze tecniche o su categorie professionali o associazioni di convenienza, ha prodotto una sorta di isolamento e di perifericità tecnologica e antropo-sociologica nella pratica del dissenso, cosa che ha relegato l’antagonismo più nelle anguste aule di tribunale o nei salotti di pochi esperti che nelle piazze popolate da gente comune e da moltitudini trasversali, proiettate a difendere diritti fondamentali e dignità umana. Ragion per cui, per raggiungere oggi l’obiettivo di una maggiore incidenza sull’immaginario sociale, diventa improcrastinabile e strategicamente fecondo il ritorno a un coinvolgimento personale delle collettività, in grado di tramutare la singolarità tecnica e specialistica della reazione al realismo della sorveglianza in collettività dell’azione politica, com-partecipata ed esuberante. In ordine, invece, al secondo piano di resistenza proposto, l’idea di prospettare la tessitura di una tattica socio-narrativa, che provveda a legare dataficazione e sorveglianza digitale non a situazioni contingenti di tornaconti di particolari aziende, ma a interessi economici dominanti, più ampi e strutturati, oltre che a precise architetture progettuali politiche, esprimenti, nelle loro agende, le peculiarità distintive del capitalismo più evoluto e audace, può notificare il passaggio a un dissenso di carattere più generalmente etico, che si vada a intrecciare produttivamente con il recupero del dimensionamento collettivo e politico della protesta e possa concorre a caratterizzare l’analisi de-costruttiva di dataismo e sorveglianza di massa in senso sistemico e organico, quasi a delineare una sorta di bozza di scienza della critica digitale. In grado tanto di inquadrare i due fenomeni digito-centrici or ora ricordati nel più esteso territorio del realismo capitalista, fornendo loro una collocazione tematica macroscopica che ne favorisca l’interpretabilità pluridisciplinare, quanto di sottrarre ad essi la rappresentabilità nei soli termini, utili al Capitale e allo Stato, di destinalità ineluttabile, quando, al contrario, sono solo escrescenze di un tempo storico particolare. E dunque contingenti, discutibili, destituibili, soppiantabili. Ma questo sotto la condizione imprescindibile che l’immaginario individuale e sociale torni a considerarsi non come un mero deposito di idee collettivamente condivise e da replicare/rilegittimare senza fine, ma la dimora spumeggiante e impetuosa dell’immaginazione, strumento di vitalizzazione incessante dell’esistenza sociale e veicolo di mobilitazione politica degli individui, cosicché la realtà non venga considerata idonea a sopportare in modo unico e immutabile il capitalismo, ma giudicata atta a concretare dinamicamente le forme più diverse di articolazione economica, politica e sociale
- Lina Dencik, Surveillance realism and the politics of imagination: Is there no alternative?, in «Krisis. Journal for Contemporary Philosophy», 1 (2018), pp. 31-43; tr. it. Il realismo della sorveglianza e le politiche dell’immaginazione: non c’è alternativa?, in «Studies in Communication Sciences», 19.2 (2019), pp. 173-188.
- Cfr. Mark Fisher, Realismo capitalista, Nero, Roma 2018.
- Nottetempo, Milano 2022.
- Nottetempo, Milano 2020 (1ͣ ed.: 2012).
- Nottetempo, Milano 2017
- Cfr. Filippo Sgubbi, Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa, il Mulino, Bologna 2019.
- Cfr. Jason Brennan, Estremi rimedi. Come resistere a uno Stato ingiusto, Luiss University Press, Roma 2019.
- Cfr. Judith Butler, L’alleanza dei corpi. Nota per una teoria performativa dell’azione collettiva, Nottetempo, Milano 2017.
- Cfr. Lina Dencik, art. cit., pp. 184-188.