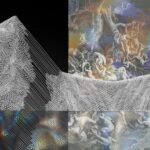Queste osservazioni sono state originariamente pronunciate come dichiarazione di apertura della sessione “The ontological turn in French philosophical anthropology”, nell’incontro annuale dell’American Anthropological Association (AAA), Chicago, 23 novembre 2013.
The original, in English, was published by HAU: Journal of Ethnographic Theory, vol. 4, no. 1, 2014.
***
Nozioni come “natura” o “cultura” non denotano una realtà universale, ma un modo particolare, concepito dai moderni, di ritagliare domini ontologici dalla trama delle cose. Altre civiltà hanno escogitato modi diversi di organizzare le continuità e le discontinuità tra umani e non umani, di aggregare gli esseri in collettivi, di definire chi o cosa è capace di agency [agence] e conoscenza. L’articolo evidenzia che questi processi di predicazione ontologica non sono “visioni del mondo”, ma, propriamente, stili di mondiazione. Parlare di ontologia significa designare un livello analitico di studio della mondiazione più elementare di quello normalmente adottato dall’antropologia. È a questo livello, dove si fanno le inferenze di base sui tipi di cose che esistono e sulle relazioni che intrattengono, che l’antropologia è in grado di svolgere al meglio la sua missione di rendere conto del modo in cui i mondi sono strutturati.
__________________________________________
La menzione del termine “antropologia filosofica” nel titolo di questa sessione ci invita a ritornare alle origini. Partiamo quindi da zero1 . La maggior parte delle persone ragionevoli ammetterà che gli esseri umani condividono un insieme di disposizioni cognitive e sensomotorie di base e che quelle che di solito vengono chiamate “variazioni culturali” non sono dovute a differenze nelle capacità, ma a differenze nel modo in cui le caratteristiche salienti del mondo vengono attualizzate da quelle stesse capacità. Perché questo? Da dove viene il processo di filtraggio che seleziona alcune qualità di oggetti e relazioni, trascurandone altre, come nutrimento per il pensiero e come vettore di azione? La risposta più comune è che i fenomeni sono multidimensionali. Questa proprietà, a cui Geoffrey Lloyd ha dedicato il suo libro Cognitive variations (2007), è stata un locus classicus della filosofia fin da quando Boyle e Locke l’hanno resa popolare come distinzione tra qualità primarie e secondarie: le prime sono dette intelligibili, separabili e, in larga misura, calcolabili; le seconde sono l’oggetto di ciò che Lévi-Strauss ha chiamato “la logique du concret“, la capacità della mente di stabilire relazioni di corrispondenza e opposizione tra le caratteristiche salienti del nostro ambiente percepito. Se ci si occupa delle dimensioni di un fenomeno in cui le sue cosiddette qualità primarie sono ritenute rilevanti, si otterranno molto probabilmente proposizioni che rientrano in un regime universalistico, mentre se ci si occupa delle impressioni che esso lascia ai nostri sensi, si apriranno molte possibilità di inferenze e connessioni relative alle circostanze personali e storiche. Questa distinzione filosofica tra i modi di essere di uno stesso fenomeno, – che possono essere attualizzati in modo differenziato da diversi approcci – ha generato la summa divisio epistemologica tra il dominio delle scienze della natura e quello delle scienze della cultura portando a un anatema contro l’esportazione dei metodi e delle aspettative delle prime (generalizzazione, misurazione, replicabilità, previsione, ecc.) nei metodi e nelle aspettative delle seconde (individualizzazione, interpretazione, condivisione di valori, coerenza semantica, ecc). Il processo di selezione, purificazione e controllo dei confini che ne deriva ha reso estremamente difficile affrontare nella prassi la multidimensionalità dei fenomeni, che sono necessariamente dislocati tra varie forme di espressione e vari regimi di veridizione. La geologia e la chimica spiegheranno un aspetto dei suoli che ho incontrato tra gli Achuar dell’Alta Amazzonia, mentre l’antropologia ne spiegherà un altro.
La direzione che sto esplorando cerca di evitare questa parcellizzazione dei fenomeni come modo per spiegare la diversità delle percezioni umane dell’ambiente. Esiste infatti un’altra spiegazione per i modi molto diversi, tradizionalmente etichettati come “culturali”, di dare conto del mondo nonostante un’attrezzatura biologica comune. Definiamo “mondiazione” [worlding] questo processo di unificare ciò che viene percepito nel nostro ambiente. Qui considero la mondiazione in un senso diverso da quello dato a questa parola dagli autori postmoderni e postcoloniali, ovvero come una costruzione sociale della realtà da parte dell’egemonia occidentale. In contrasto con questa accezione culturalista corrente – che implica una distinzione tra una realtà trascendentale preesistente e le varie versioni culturali che se ne possono dare – vedo il worlding piuttosto come un processo di stabilizzazione di certe caratteristiche degli accadimenti. Un omaggio nascosto, e forse infedele, alla famosa proposizione di Wittgenstein secondo cui “il mondo è tutto ciò che accade”2. Ora, suppongo che questo processo di mondiazione non avvenga a caso, ma si basi principalmente su una predicazione ontologica. Per tale motivo, la contrapposizione tra il mondo come totalità delle cose e i molteplici mondi della realtà vissuta è alquanto fuorviante, sebbene sia diventata un principio di base dell’epistemologia modernista e il fondamento implicito della maggior parte di ciò che attualmente passa per antropologia. Sostengo che “ciò che è il caso per noi” non è un mondo completo e autosufficiente che aspetta di essere rappresentato secondo diversi punti di vista, ma, molto probabilmente, una vasta quantità di qualità e relazioni che possono essere attualizzate o meno dagli esseri umani, a seconda di come i filtri ontologici discriminano tra le affordance ambientali. Gli oggetti materiali e immateriali del nostro ambiente non stanno nel regno delle idee eterne pronti per essere catturati dalle nostre facoltà, né sono semplici costruzioni sociali che danno forma e significato a una materia prima; essi sono gruppi di qualità che in parte individuiamo e in parte ignoriamo. La varietà delle forme di mondiazione deriva dal fatto che questa attualizzazione differenziale delle qualità non è casuale, ma segue la linea delle inferenze di base su come le qualità vengono associate agli oggetti che percepiamo vengono correlate. Mi sembra che questa epistemologia rustica, fondamentalmente humeana, sia abbastanza coerente e plausibile per un non filosofo da fornire un fondamento generale al compito antropologico di tentare di dare un senso ai molteplici modi attraverso cui gli esseri umani descrivono il mondo e ciò che fanno al suo interno3. Parlare di “filtri ontologici” è per me un modo di sottolineare il fatto che il livello analitico da cui ritengo debba partire l’impresa antropologica è più elementare di quello che di solito si dà per scontato. La mia convinzione è che i sistemi di differenze nei modi in cui gli esseri umani abitano il mondo non devono essere intesi come sottoprodotti di istituzioni, sistemi economici, insiemi di valori, modelli culturali, visioni del mondo o simili; al contrario, essi sono il risultato di assunzioni più basilari su ciò che il mondo contiene e su come gli elementi di questo insieme sono connessi. La parola “ontologia” sembra appropriata per qualificare questo livello analitico antepredicativo, ed è per questo che ho iniziato a usarla parsimoniosamente due decenni fa. La mia unica rivendicazione nella cosiddetta “svolta ontologica” – espressione che non ho mai usato – è quindi una questione di igiene concettuale: dovremmo cercare le radici della diversità umana a un livello più profondo, dove si fanno le inferenze di base sui generi di esseri di cui è fatto il mondo e su come si relazionano tra loro.
Permettetemi di chiarire la mia proposta secondo cui la varietà delle forme di mondiazione deriva dalla varietà dei regimi ontologici in cui questo processo si realizza. Vorrei iniziare con una precisazione su cosa penso sia l’antropologia. Il suo compito principale, a mio avviso, non è quello di fornire “descrizioni dense” di specifiche istituzioni, abitudini culturali o pratiche sociali – questo è il compito dell’etnografia4. Il compito principale dell’antropologia è quello di portare alla luce il modo in cui gli esseri di un certo tipo – gli esseri umani – operano nel loro ambiente, come individuano in esso talune proprietà di cui fanno uso, e come riescono a trasformare questo ambiente tessendo con esso e tra di loro relazioni permanenti o occasionali di una notevole, ma non infinita, diversità. Per portare a termine questo compito, dobbiamo mappare queste relazioni, comprenderne meglio la natura, stabilire le loro modalità di compatibilità e incompatibilità ed esaminare come si attualizzano in stili di azione e di pensiero che appaiono immediatamente distintivi. In breve, il compito dell’antropologia è quello di spiegare come si compongono i mondi. Ora, alcuni potrebbero vedere tutto ciò come “antropologia filosofica”, come suggerisce il titolo della sessione, o addirittura come un’oltraggiosa francesità, o forse entrambe le cose. Io la vedo piuttosto come una semplice antropologia, se si considera che lo scopo di questa scienza inquietante dovrebbe essere quello di elaborare modelli comparativi e deduttivi non di istituzioni reali, ma di oggetti che sono qualificati dal processo stesso di essere selezionati come elementi di un modello. Questi oggetti non sono né empirici né ideali, non sono una sintesi ad hoc di rappresentazioni e pratiche; sono un insieme di caratteristiche contrastanti astratte dalle descrizioni della vita sociale al fine di evidenziarne alcune proprietà.
Quali sono questi stili distintivi di azione e pensiero umano che l’antropologia dovrebbe portare alla luce? Essi vanno intesi come modelli cognitivi e sensomotori di pratica, in parte innati, in parte risultanti dall’effettivo processo di interazione tra organismi, cioè dalle modalità pratiche di coordinamento delle agency umane e non umane in un determinato ambiente. Tali schemi sono quindi più che dispositivi di inquadramento usati dagli analisti per descrivere una situazione; sono dispositivi di inquadramento utilizzati dagli agenti per dare un senso alla situazione e gestire la messa a punto di ciò che si potrebbe chiamare interazione [interagency]5. Questi dispositivi di inquadramento possono essere visti come strutture astratte – come la prospettiva artificiale o gli scenari di routine delle interazioni quotidiane – che organizzano le competenze, le percezioni e le azioni senza mobilitare una conoscenza dichiarativa. Sono, per riprendere le parole di Maurice Bloch, “cose che non si dicono” (1992), cioè schemi cognitivi che regolano l’habitus, guidano le inferenze, filtrano le percezioni e sono in gran parte il prodotto delle possibilità che il mondo offre alle disposizioni specificamente umane.
Una delle funzioni fondamentali di questi dispositivi di inquadramento è quella di attribuire identità raggruppando, o dissociando, elementi del mondo vissuto che sembrano avere qualità simili o dissimili. La mia tesi è che una delle caratteristiche universali del processo cognitivo in cui tali disposizioni sono radicate è la consapevolezza di una dualità di piani tra processi materiali (che chiamo “fisicità”) e stati mentali (che chiamo “interiorità”). Questo assunto si basa su una serie di elementi derivati dalla filosofia, dalla psicologia e dall’etnologia sui quali non mi soffermerò in questa sede. Mi limito a sottolineare il fatto assodato che, fino a quando le teorie fisicaliste occidentali della fine del XX secolo non hanno spiegato la coscienza come una proprietà emergente delle funzioni biologiche, non c’era alcuna prova di una concezione che descrivesse la normale persona umana vivente come un puro corpo fisico senza alcuna forma di interiorità, o come una pura interiorità senza alcuna forma di incarnazione. Pertanto, la distinzione tra piano dell’interiorità e piano della fisicità non è la semplice proiezione etnocentrica di un’opposizione tra corpo e mente specifica dell’Occidente; bisogna piuttosto considerare questa opposizione, così come è emersa in Europa, e le teorie filosofiche e teologiche che sono state elaborate su di essa, come varianti locali di un sistema più generale di contrasti elementari che possono essere studiati comparativamente. Utilizzando questa griglia universale, gli esseri umani sono in grado di enfatizzare o minimizzare la continuità e la differenza tra loro e i non umani. Ne risulta un quadruplice schema di ontologie, cioè di qualità ed esseri contrastanti individuati nell’ambiente umano e organizzati in sistemi, che ho etichettato come “animismo”, “totemismo”, “analogismo” e “naturalismo”, dando così nuovi significati a concetti antropologici ben noti.
Esaminiamo alcune proprietà di queste modalità di identificazione. L’animismo come continuità di anime e discontinuità di corpi è abbastanza comune in America del Sud e del Nord, in Siberia e in alcune zone del Sud-Est asiatico, dove le persone conferiscono soggettività a piante, animali e altri elementi del loro ambiente fisico e stabiliscono con queste entità ogni tipo di relazione personale, di amicizia, scambio, seduzione o ostilità. In questi sistemi animistici, gli esseri umani e la maggior parte dei non umani sono concepiti come dotati dello stesso tipo di interiorità, ed è a causa di questa soggettività comune che si dice che gli animali e gli spiriti possiedano caratteristiche sociali: vivono in villaggi, rispettano regole di parentela e codici etici, si impegnano in attività rituali e barattano beni. Tuttavia, il riferimento condiviso dalla maggior parte degli esseri del mondo è l’umanità come condizione generale, non l’uomo come specie. In altre parole, gli esseri umani e tutti i tipi di non umani con cui gli esseri umani interagiscono hanno fisicità diverse, in quanto le loro identiche essenze interne sono alloggiate in diversi tipi di corpi, spesso descritti come abiti che possono essere indossati o dismessi, per meglio sottolineare la loro autonomia dalle interiorità che li abitano. Ora, come ha giustamente sottolineato Eduardo Viveiros de Castro (1996), questi abiti specifici spesso inducono prospettive contrastanti sul mondo, in quanto i vincoli fisiologici e percettivi propri di un tipo di corpo impongono a ciascuna classe di esseri una posizione e un punto di vista specifici nell’ecologia generale delle relazioni. Le persone umane e non umane hanno una visione integralmente “culturale” della loro sfera di vita perché condividono lo stesso tipo di interiorità, ma il mondo che queste entità percepiscono è diverso, perché le loro attrezzature sono distinte. La forma dei corpi è quindi più della conformazione fisica; è l’intero kit biologico che permette a una specie di occupare un habitat e di condurvi la vita distintiva con cui è identificata. Sebbene molte specie condividano una certa interiorità, ognuna di esse possiede una propria fisicità sotto forma di un particolare etogramma che determinerà il suo Umwelt, nel senso di Jakob von Uexküll – vale a dire, le caratteristiche salienti del suo ambiente sono quelle orientate ai suoi specifici strumenti corporei: modalità di locomozione, di riproduzione, di acquisizione del cibo, e così via.
Passiamo ora alla seconda modalità di identificazione, per cui alcuni esseri del mondo condividono una serie di attributi fisici e morali che superano i confini delle specie. Lo chiamo totemismo, ma in un senso molto diverso da quello che è stato attribuito al termine da quando Lévi-Strauss ha cercato di sfatare l'”illusione totemica”. Il totemismo, infatti, non è solo un dispositivo classificatorio universale, ma è anche, e forse soprattutto, un’ontologia estremamente originale, che trova la sua migliore esemplificazione nell’Australia aborigena. Lì, il totem principale – il più delle volte un animale o una pianta – a cui una comunità di esseri umani si referisce, accanto a tutte le altre entità, umane e non umane, a esso affiliati, si dice che condividano alcuni attributi generali di conformazione fisica, sostanza, temperamento e comportamento in virtù di un’origine comune localizzata nello spazio. Tali attributi non derivano da quella che viene impropriamente chiamata entità eponima, poiché la parola che designa il totem in molti casi non è il nome di una specie, cioè di un taxon biologico, ma piuttosto il nome di una proprietà astratta che è presente in questa specie così come in tutti gli esseri sotto di essa, in un raggruppamento totemico. Ad esempio, le società totemiche dei Nungar dell’Australia sud-occidentale erano chiamate rispettivamente maarnetj, che può essere tradotto con “ciò che afferra”, e waardar, che significa “l’osservatore”; questi due termini sono stati utilizzati anche per designare i totem di queste società, il cacatua bianco e il corvo (von Brandenstein, 1977). In questo caso, i nomi delle classi totemiche sono termini che denotano proprietà utilizzate anche per designare le specie totemiche, e non il contrario, cioè nomi di taxa zoologici da cui si dedurrebbero gli attributi tipici di quelle classi. La differenza fondamentale risiede tra aggregati di attributi comuni agli esseri umani e ai non umani all’interno di classi designate da termini astratti, e non tra generi naturali che fornirebbero spontaneamente, viste le loro manifeste discontinuità di forma e comportamento, un modello analogico che potrebbe essere utilizzato per strutturare le discontinuità sociali.
La terza modalità di identificazione, l’analogismo, si basa sull’idea che tutte le entità del mondo siano frammentate in una molteplicità di essenze, forme e sostanze separate da intervalli minimi, spesso ordinate lungo una scala graduata, come nella Grande Catena dell’Essere, che è stata il principale modello cosmologico durante il Medioevo e il Rinascimento. Questa disposizione permette di ricombinare i contrasti iniziali in una fitta rete di analogie che collegano le proprietà intrinseche di ogni entità autonoma presente nel mondo. Ciò che colpisce di più in questi sistemi è l’abilità con cui vengono attivamente ricercate tutte le somiglianze che possono fornire una base per le inferenze, soprattutto quando queste si applicano a domini di fondamentale importanza per la vita, come la prevenzione e il trattamento di malattie e disgrazie. L’ossessione per le analogie diventa una caratteristica dominante, come nell’antica Cina, dove, secondo Granet, “la società, l’uomo, il mondo, sono oggetti di una conoscenza globale costituita dal solo uso dell’analogia” ([1934] 1968: 297). Tuttavia, l’analogia è qui solo una conseguenza della necessità di organizzare un mondo composto da una molteplicità di elementi indipendenti. L’analogia diventa possibile e pensabile solo se i termini che essa unisce sono inizialmente distinti, se il potere di rilevare somiglianze tra le cose viene applicato a singolarità che, attraverso questo processo, vengono parzialmente estratte dal loro isolamento originario. L’analogismo può essere visto come un sogno ermeneutico di completezza e totalizzazione che procede da un’insoddisfazione: ammettendo che tutte le componenti del mondo siano separate da minuscole discontinuità, nutre la speranza di intrecciare questi elementi debolmente differenziati in una tela di affinità e attrazioni che ha tutte le apparenze della continuità. Lo stato ordinario del mondo, però, è in effetti una molteplicità di differenze riverberanti, e la somiglianza è solo il mezzo previsto per rendere intelligibile e tollerabile questo mondo frammentato. Tale moltiplicazione dei pezzi elementari del mondo che riecheggiano all’interno di ciascuna delle sue parti – compresi gli esseri umani, divisi in numerose componenti parzialmente situate al di fuori dei loro corpi – è una caratteristica distintiva delle ontologie analogiche e il miglior indizio attraverso cui identificarle. A parte il caso paradigmatico della Cina, questo tipo di ontologia è abbastanza comune in alcune zone dell’Asia, nell’Africa occidentale o tra le comunità native della Mesoamerica e delle Ande.
L’ultima modalità di identificazione, il naturalismo, corrisponde alla nostra ontologia. Il naturalismo non è solo l’idea che la natura esista, che certe entità debbano la loro esistenza e il loro sviluppo a un principio estraneo sia al caso sia agli effetti della volontà umana. Non qualifica solo l’avvento, convenzionalmente situato nel XVII secolo, di uno specifico dominio ontologico, un luogo di ordine e necessità dove nulla accade senza una causa. Il naturalismo implica parimenti una controparte, un mondo di artificio e libero arbitrio la cui complessità è progressivamente emersa sotto lo sguardo degli analisti, fino a rendere necessaria, nel corso del XIX secolo, l’istituzione di scienze speciali a cui è stato affidato il compito di stabilizzarne i confini e le caratteristiche. Ora, se si considera il naturalismo – la coesistenza di un’unica natura unificante e di una molteplicità di culture – non come il modello onnicomprensivo che permette l’oggettivazione di qualsiasi realtà, ma come una tra le altre modalità di identificazione, allora le sue proprietà contrastive appaiono più chiaramente. In particolare, il naturalismo inverte le premesse ontologiche dell’animismo poiché, invece di rivendicare un’identità di anima e una differenza di corpi, si fonda su una discontinuità di interiorità e una continuità materiale. Ciò che per noi distingue gli esseri umani dai non umani è la mente, l’anima, la soggettività, la coscienza morale, il linguaggio e così via, così come i gruppi umani si distinguono l’uno dall’altro per una disposizione interna collettiva che un tempo si chiamava “Volksgeist” o “génie d’un peuple“, ma che oggi ci è più familiare con l’etichetta moderna di “cultura”. D’altra parte, siamo tutti consapevoli, soprattutto dopo Darwin, che la dimensione fisica degli esseri umani li colloca all’interno di un continuum materiale in cui non si distinguono come singolarità. L’esclusione dalla personalità di organismi non umani che sono biologicamente molto vicini a noi è un segno del privilegio accordato nel nostro modo di identificazione ai criteri basati sull’espressione di una presunta interiorità piuttosto che a quelli basati sulla continuità materiale.
Questi modi di individuare ed enfatizzare le pieghe nel nostro intorno non devono essere considerati come una tipologia di “visioni del mondo” strettamente isolate, ma piuttosto come uno sviluppo delle conseguenze fenomenologiche di quattro diversi tipi di inferenze sull’identità degli esseri nel mondo. A seconda delle circostanze, ogni essere umano è in grado di seguire una qualsiasi delle quattro inferenze, ma molto probabilmente emetterà un giudizio di identità in base al contesto ontologico – cioè la sistematizzazione per un gruppo di esseri umani di una sola delle inferenze – in cui è stato socializzato. Le ontologie reali possono essere molto vicine al modello (l’animismo in Amazzonia e nel Subartico, il totemismo in Australia, l’analogismo nell’antica Cina o in Messico, il naturalismo nella letteratura epistemologica e filosofica della modernità europea); ma forse la situazione più comune è quella dell’ibridazione, in cui una modalità di identificazione prevale leggermente su un’altra, dando luogo a una varietà di combinazioni complesse. Questa quadruplice tipologia va quindi considerata come un dispositivo euristico piuttosto che come un metodo di classificazione delle società; un dispositivo utile, tuttavia, in quanto porta alla luce le ragioni di alcune delle regolarità strutturali osservabili nei modi in cui il mondo fenomenologico è istituito e delle compatibilità e incompatibilità tra tali regolarità, due compiti antropologici fondamentali che sono stati troppo rapidamente scartati e lasciati aperti a rozzi approcci naturalistici.
Torno ora alla mia preoccupazione iniziale. Dovrebbe essere ovvio che la mia posizione esclude sia l’ipotesi dei mondi multipli sia quella delle visioni multiple del mondo. Non possono esistere mondi multipli, nel senso di contenitori ermetici dell’esperienza umana con proprietà e leggi fisiche specifiche, perché è altamente probabile che le qualità e le relazioni potenziali offerte alla cognizione e all’azione umana siano uniformemente distribuite. Una volta che il processo di mondanizzazione è stato realizzato, una volta che alcune di queste qualità e relazioni sono state individuate e sistematizzate, però, il risultato non è una visione del mondo, cioè una versione tra le altre della stessa realtà trascendentale; il risultato è un mondo a sé stante, un sistema di proprietà attualizzate in modo incompleto, saturo di significato e ricco di agency, ma parzialmente sovrapposto ad altre configurazioni simili che sono state attualizzate in modo diverso e istituite da diversi attori. Tutte queste attualizzazioni frammentarie, comprese quelle personalissime di grandi artisti o psicopatici, sono varianti, o istanziazioni parziali, di potenzialità che non sono mai state, e probabilmente non saranno mai, pienamente integrate in un unico mondo unificato. Come sogno di perfetta totalizzazione, il realismo a tutti gli effetti sembra irraggiungibile; il relativismo, invece, è facilmente raggiungibile ma autodistruttivo, poiché presuppone uno sfondo universale di cui ogni versione è una resa parziale.
A prima vista, questi mondi parzialmente sovrapposti sembrano condannarci a vivere nel solipsismo, forse persino nella disperazione politica, una volta persa la rassicurante consolazione dell’universalismo. Infatti, di fronte a situazioni simili, non tutti i frammenti di umanità si pongono le stesse domande, o forse le formulano in modi così diversi che altri frammenti possono avere difficoltà a riconoscere in esse le stesse domande che essi stessi si sono proposti di affrontare. Ciò induce enormi discrepanze, solitamente chiamate “incomprensioni culturali” nel linguaggio dei moderni. Ora, la maggior parte di queste domande possono essere raggruppate come problemi la cui espressione assumerà forme diverse a seconda dei contesti ontologici in cui si presentano. Se si accetta che la distribuzione delle qualità degli esistenti varia a seconda delle modalità di identificazione che ho tratteggiato, si deve anche accettare che i regimi cognitivi, le posizioni epistemologiche che rendono possibili tali regimi e le conseguenti modalità di affrontare un problema varieranno nella stessa misura. Ciò rende la nostra sfera pratica molto più complicata di quanto la consueta opposizione tra universalismo e relativismo ci abbia fatto prevedere.
Allo stesso modo, ognuno di questi modi di identificazione prefigura il tipo di collettività adatta a riunire in un destino comune i vari tipi di esseri che distingue. Se prestiamo attenzione alle diverse idee che i popoli hanno elaborato in merito alle loro istituzioni, noteremo che raramente esse portano a isolare il dominio sociale come un regime di esistenza separato, con precetti che regolano esclusivamente la sfera delle attività umane. Solo quando il naturalismo ha raggiunto la sua maturità, un corpo di discipline specializzate ha preso come oggetto il dominio sociale e di conseguenza si è impegnato a rilevare e oggettivare questo campo di pratica in ogni parte del mondo e con scarso riguardo per le concezioni locali, proprio come se le sue frontiere e il suo contenuto fossero ovunque identici a quelli che gli occidentali avevano fissato per esso. Lungi dall’essere la base presupposta da cui deriva tutto il resto, la socialità, al contrario, risulta dal lavoro ontologico di composizione dei mondi a cui conduce ogni modalità di identificazione. La socialità non è quindi una spiegazione, ma piuttosto ciò che deve essere spiegato. Se, fino a poco tempo fa, l’umanità non operava distinzioni rigide tra naturale e sociale e non pensava che il trattamento degli esseri umani e quello dei non umani fossero separati, allora dovremmo considerare ciò che di solito chiamiamo società e cosmologie come una questione di distribuzione degli esistenti in diversi collettivi: cosa o chi si associa con cosa o chi, e in che modo, e per quale scopo?
Porre questo tipo di domande e cercare di rispondervi implica che gli strumenti convenzionali che le scienze sociali hanno ereditato dalla filosofia politica europea del XVII e XVIII secolo devono essere spogliati della loro centralità e del loro peso paradigmatico, perché questi strumenti sono il risultato diretto di un resoconto riflessivo altamente insolito di circostanze storiche altamente insolite. All’epoca in cui è stato prodotto – da Mandeville a Marx, per dirla con Dumont – questo resoconto ha colto e modellato la peculiarità del tipo di collettività all’interno della quale i moderni sentivano di dover vivere; ma è diventato evidente, anche in Occidente, che questo resoconto non è più adeguato agli stati di mondialità multipla in cui viviamo e all’urgenza dell’imminente catastrofe ecologica. In gioco c’è l’intero quadro concettuale attraverso il quale affrontiamo l'”organizzazione sociale e politica” dei collettivi, il regime messianico della storicità che abbiamo imposto ad altri modi, molto diversi, di affrontare il dispiegarsi nel tempo di una prospettiva comune, e le nozioni di base attraverso le quali rafforziamo il nostro pensiero sul perché gli esseri umani sono distinti e su come attuano in modo differenziato questa distintività – nozioni come la natura, la cultura, la società, la sovranità, lo Stato, la produzione e, sì, anche la classe, la razza e il genere. Tutta questa griglia pazientemente costruita dovrà essere, se non del tutto scartata – perché esprime un’antropologia specifica che merita di essere presa in considerazione insieme ad altre – almeno declassata dalla sua posizione imperiale. È tempo, dunque, di prendere atto che i mondi sono composti in modo diverso; di cercare di capire come sono composti senza ricorrere automaticamente al nostro modo di composizione; di ricomporli in modo da renderli più accessibili a una più ampia varietà di abitanti, umani e non umani.
Bibliografia
1. Bloch, Maurice. 1992. “What goes without saying: The conceptualization of Zafimaniry society.” In Conceptualizing society, edited by Adam Kuper, 127–46. London: Routledge.
2. Deleuze, Gilles. 1953. Empirisme et subjectivité: Essai sur la nature humaine selon Hume. Paris: Presses Universitaires de France, Épiméthée.
3. Descola, Philippe. 2005. “On anthropological knowledge.” Social Anthropology 13 (1):65–73.
4. _____. 2010. “Cognition, perception and worlding.” Interdisciplinary Science Reviews 35 (3–4): 334–40.
5. _____. 2013. Beyond nature and culture. Translated by Janet Lloyd. Chicago: University of Chicago Press.
6. Granet, Marcel. [1934] 1968. La pensée chinoise. Paris: Albin Michel.
7. Ingold, Tim. 1997. “Life beyond the edge of nature? Or, the mirage of society.” In The mark of the social: Discovery or invention?, edited by John D. Greenwood, 231–52. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
8. Lloyd, Geoffrey E. R. 2007. Cognitive variations: Reflections on the unity and diversity of the human mind. Oxford: Clarendon Press.
9. Viveiros de Castro, Eduardo. 1996. “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio.” Mana 2 (2): 115–44.
10. von Brandenstein, Carl Georg. 1977. “Aboriginal ecological order in the south-west of Australia—meanings and examples.” Oceania XLVII (3): 170–86. 2014
11. Wittgenstein, Ludwig. [1921] 1989. Logisch-philosophische Abhandlung/Tractatus logicophilosophicus. Kritische Edition. Edited by Brian McGuinness and Joachim Schulte. Frankfurt am Main: Suhrkamp
______________________________________
- E anche da brani pubblicati in precedenza, tra cui Par-delà nature et culture (2005) e “Cognition, perception and worlding” (2010), da cui ho preso in prestito alcune delle mie argomentazioni in questo articolo.
- “Die Welt ist alles, was der Fall ist”, la prima proposizione della Logisch-philosophische Abhandlung di Wittgenstein ([1921] 1989: 11).
- Forse più che a Hume direttamente, aderisco alla lettura molto suggestiva di Hume offerta da Deleuze in Empirisme et subjectivité, ben riassunta dalla seguente citazione: “Il dato non è più dato a un soggetto, il soggetto si costituisce nel dato. Il merito di Hume è di aver isolato questo problema empirico allo stato puro, mantenendolo lontano dal trascendentale ma anche dallo psicologico” (1953: 92).
- L’antropologia può essere praticata dagli etnografi e l’etnografia può essere fatta dagli antropologi, ma i loro obiettivi e metodi non devono essere confusi (si veda il mio articolo “Sulla conoscenza antropologica”, 2005)
- Un neologismo che preferisco alla nozione di “interagentività” [interagentivity] coniata da Ingold (1997: 249), ovviamente in contrasto con “intersoggettività”.