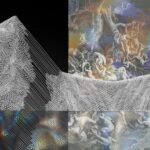La storia è finita – e tale fine ha continuato a trascinarsi come un fantasma, ancora e ancora, alla ricerca di un nuovo corpo. Ma per chi questa fine ha avuto realmente luogo?
Se l’invasione Russa ai danni dell’Ucraina ha insegnato – o ricordato – qualcosa, ciò può essere riassunto in due punti:
- La storia non finisce se si finisce di raccontarla, o se ne si annuncia la fine. Porsi al di fuori dell’orizzonte della storicità, come in una stasi compiuta, o in una dimensione libera dall’incedere del tempo – magari giustificato dalla fine delle grandi narrazioni – non significa altro che rendersi ciechi e sordi alla furia di ciò che continua a divenire.
- La storia, non avendo bisogno di essere raccontata, decifrata, analizzata, decostruita, perché si manifesti – comprendere la storia non significa neutralizzarla -, trascende la teoria nella forma di previsione e interpretazione e si rivela puramente come azione, e i suoi attori come catalizzatori, punti di reazione.
Le cause di tutto questo sono profonde e complesse e antiche ma anche recenti, parte di quella storia di cui Fukuyama, nel 1992, annunciava la fine con la caduta dell’URSS. Fu piuttosto la fine delle resistenze che l’Ovest percepiva: la strada si sarebbe aperta alla fine dello scorrere del tempo, realizzazione dei sogni liberaldemocratici. La storia non è fatta di teoria; è composta d’atti, e questi atti sono materiali, e la teoria non lo è. Il vero essere dell’uomo sta piuttosto nella sua azione; è in questa che l’individualità è effettiva (Hegel). Atto è una parola-baule; in essa, divergenti, si raggruppano l’accadimento, atto frutto della contingenza, e la visione, teoria d’atto che ha il fine nella costruzione.
Putin è oggi un frammento dell’anima del mondo – restauratore dell’immagine di una Russia protagonista della storia universale. L’occidente diviso, i nuovi assetti geopolitici, le nuove zone d’influenza; la lettura del presente ha offerto ragionevoli indicazioni a coloro che hanno pensato che l’Ovest non avrebbe sopportato il ritorno della storia. Afghanistan, Iraq, eccetera: noi in una cupola, il tempo sembrava procedere solo all’esterno. 9/11, Charlie Hebdo, Bataclan: è difficile per la cupola decodificare gli eventi di un tempo che ha smesso di essere percepito come il proprio – “pazzo” Putin, “folli” e “mostri” gli altri: il patologico salva il normale dalla necessità di riflessione, semplifica e aliena. L’imprevedibilità della storia è data dall’incalcolabile complessità delle reazioni che seguono a un singolo atto. Ci sono azioni frutto di teoria; esse compongono le “visioni”, e manifestano il campo della storia ben oltre il passato e il presente, verso la costituzione dell’avvenire. Fare/la/storia: non un atto compiuto, ma un divenir-compiuto – racconto in fase di scrittura.
Il panslavismo di Putin (di Dugin? 1), visione come sistema coordinato di atti e reazioni, come “sua” narrativa che concorre alla storia universale, si contrappone alle altre visioni – se presenti. Una visione che si fa operativa nutre le eventuali fiamme dormienti nel cuore degli altri frammenti dell’anima del mondo; nasce Volodymyr Zelensky, l’ultimo dei volti dell’archetipo dell’eroe, finzione fattasi reale che cancella la finzione stessa – l’arte è un modo per dir cautamente ciò che si dovrebbe dire violentemente. Si riscopre “l’Occidente”, forse “l’Europa” – accenni delle *visioni* in seno ai concetti, indizi della loro mancanza. Ciò che reagisce solo se minacciato non dimostra di certo alcuna solidità rilevante, e anzi nasconde malizia o inconsistenza, eppure anche la ricomposizione è una reazione, e concorre alla storia anche solo come povero accadimento. C’è spazio per una visione, in grembo a ciò che si è dimostrato fino a oggi solo una sfilata di maschere litigiose? C’è tempo per attendere la messianica venuta di nuovi visionari, narratori della storia, abitanti del futuro?
La Russia fuori dal mondo; l’antagonista forse basta a creare l’eroe, ma non a dare un nome a ciò che viene al termine di quella notte che al di fuori della cupola occidentale ha continuato a essere la norma. Un nuovo occidente che cancelli {l’Occidente}; tale forse dovrebbe essere il compito dell’ultimo eroismo, così che non ci siano più cupole, ma una schiuma densa e appiccicosa che si infiltri ovunque, e non solo fin dove serve.
***
Scrive Baudrillard nel 1990 – nel pieno di quella Storia nel procinto di compiersi:
Se si dovesse caratterizzare lo stato attuale delle cose, direi che è quello del dopo orgia. L’orgia è tutto il momento esplosivo della modernità, quello della liberazione di tutti i campi. […] Possiamo ormai soltanto simulare l’orgia e la liberazione, far finta di muoverci nella stessa direzione accelerando, ma in realtà acceleriamo nel vuoto, poiché tutte le finalità della liberazione sono già dietro di noi e ciò da cui siamo assillati, ossessionati, è questa anticipazione di tutti i risultati, la disponibilità di tutti i segni, le forme, i desideri. […] Questo è lo stato di simulazione, quello in cui possiamo solo rimettere in gioco tutti gli scenari perché hanno avuto già luogo – realmente o virtualmente. É quello di tutte le utopie realizzate, in cui bisogna paradossalmente continuare a vivere come se realizzate non fossero. (2018, 9)
Questa liberazione realizzata si è dimostrata ricadere nel proprio opposto, continua Baudrillard: in essa, tutto ciò che è stato fatto per definire confini netti e produrre immagini definite e definitive si è trasformato, al proprio teorico compimento, nel proprio altro. Contaminazione generale di ogni campo da parte di ogni altro, trionfo del principio d’incertezza, e vittoria ineluttabile della comunicazione ossessiva: rumore incessante, pensieri introflessi su loro stessi, parole che parlano di parole. Raggiunta l’utopia, che è il fine della Storia in quanto progresso, ci si è inebriati della sensazione di abitare una cupola celeste, da cui la storia stessa è stata esiliata. Eppure, recita il corollario: che nessuno mantenga memoria di quell’esilio, il tempo continua, e l’utopia realizzata è tale solo se deve ancora realizzarsi – nonostante il campo da gioco, questa volta, sia il deserto fuori la cupola. Che sia quella, la terra di coloro che non hanno saputo far storia – Africa, Sud America, Asia, Medio Oriente, … – , il peso che tiene in equilibrio la bilancia.
Nella cupola, in salvo dall’incedere del tempo, è avvenuta la gestazione del pacifismo razionale, eminentemente morale nell’accezione peggiore, costume di pensiero, predica dell’assassino all’assassinato; la memoria organica, con grandi pregi e altrettanti difetti, esilia i ricordi peggiori al di là delle mura della città, dove risiedono – dicevano i greci – gli dèi e le bestie. Ogni condizione d’esistenza, che sia individuale o collettiva, è frutto di un’affermazione, sempre, e di una lotta, talvolta. Si sente oggi criticare aspramente il sostegno agli Ucraini, si sente spesso affermare che l’Ucraina è destinata a cadere, e allora giusto sarebbe accelerare questa caduta, deporre le armi: ogni giorno in più sono più cadaveri. La responsabilità della sofferenza sarebbe divisa fra offesi e offensore: i primi più combattono e più causano la (propria) morte; il secondo uccide, ma le cause sono complesse. Nella cupola non c’è che teoria: non c’è nulla da pensare se non i propri pensieri. L’obiettivo è la pace, a qualsiasi costo – dicono gli abitanti della cupola. Lo dicono perché di quest’ultima non vedono i contorni, perché danno per scontato che la loro forma di società sia la più giusta, e che quindi nutrendo l’essenza della giustizia essi non meritino il lato più infame della storia – loro civilizzati, eredi dei lumi, nemici della rozza violenza. Eppure, sarebbe così semplice per i grandi uomini recarsi sul terreno di guerra, tenendosi per mano davanti ai soldati e alle bombe, dicendo: se ci uccidete, sarà davvero guerra, e sarà responsabilità vostra, e lo dimostrerete a tutti. Questo sarebbe davvero un atto di pace. I fatti corrono più della teoria.
Cosa c’è di più violento della pretesa d’essere gli stendardieri del giusto? Ha l’occidente forse qualcosa da insegnare – se non in fatto di guerra, di cui siamo sempre stati fini intenditori come in Corea, e in Vietnam, in Afghanistan, in Iraq, e poi Palestina, Somalia, Jugoslavia? Ci sono guerre giuste, o la guerra è sempre sbagliata? Perché le costituzioni degli stati europei ripudiano la guerra d’offesa, ma ammettono quella di difesa? Ogni parola proferita dall’Ovest, ben difeso dal vetro della cupola, tesa a spiegarsi e spiegare quale sarebbe il modo più giusto di agire per coloro che stanno sotto il fuoco nasconde solo il ritorno del reale, e della paura a esso legata. Il rumore, il tifo, la polarizzazione dei discorso: paura. E se il vetro della cupola si incrinasse per qualche fendente maldestro? E se toccasse a noi? Fiancheggiamo l’offensore, che è anche chi ci minaccia, oppure l’offeso, per i nostri valori, ma rischiando che il primo si incazzi, o ancora stiamo equidistanti, spettatori interessati ma ben attenti a non abbandonare il terreno dell’ignavia?
Rimane qualcosa dei valori e della storia d’Europa, qualcosa attraverso cui definire un’identità? O dobbiamo arrenderci all’idea dell’Impero Latino di Kojéve? Se non altro, la paura è un’emozione che risveglia i sensi e mette in moto il pensiero.
La fine della storia ha significato questo: abitare un mito di trasparenza, per cui la cupola è l’autorealizzazione della storia razionale, e in quanto razionale giusta, e al di fuori di essa il deserto, e ciò che si è compiuto nella cupola non è solo un fatto, ma è il vero. Pacifismo razionale, anti-semplificazionismo: la pretesa di epurare l’alterità dall’ignoto che si porta dietro – ogni relazione può essere un idillio e, se può, allora deve. Nel cammino della storia universale niente è stato compiuto – perché niente può esserlo, tutto continua a sfuggire e decomporsi, e noi dovremmo inseguirlo, tamponarne le piaghe purulente. Come si combatte ciò che si deve combattere? E sulla base di quale criterio esiste tale dovere? L’Umanismo virtuoso è mitologia; è necessario riconoscere il senso della propria storia.
***
Nel capitolo centrale della Fenomenologia dello Spirito, sullo Spirito e sulla Moralità, Hegel manifesta, senza direttamente citarlo, l’ordine napoleonico come la realizzazione ultima della storia universale, attraverso e oltre la rivoluzione francese e il Terrore. Hegel assiste forse fortuitamente all’entrata di Napoleone a Jena; è il testimone necessario di questa storia nell’atto di ardere, dell’anima del mondo incarnata. Nelle lezioni sulla Fenomenologia, Kojéve riconosce nella testimonianza hegeliana il fatto che la filosofia, la riflessione dello spirito su se stesso, rappresenti il vero compimento dell’ideale realizzato della storia universale: tale compimento è in Napoleone, in quanto attore cosmico-storico, e in Hegel stesso, in quanto testimone. La filosofia, così, giunge sempre al crepuscolo, nell’ora in cui l’azione si è compiuta, o si sta delineando il suo compimento: lo spirito può contemplare i propri atti solo una volta che essi si sono realizzati. La “fine della storia” hegeliana è il compimento di una scienza filosofica che definisce il suo scopo – ma il tempo, e il suo contenuto, procedono a eguale intensità.
La natura della storia umana, attraverso gli occhi di Hegel, viene rappresentata come definita a partire dagli atti che la compongono, dagli attori che catalizzano il divenire storico, e dalla materia inerte che subisce tale divenire. Non c’è repressione, né alcuna strategia di contenimento valida che possa arrestarne l’incedere. Nessuna teoria può porsi dinanzi all’azione come un mastro di chiavi, detentore unico della verità del tempo; la teoria è l’atto contemplativo posteriore, il comprendere e l’apprendere. Oggi, che ciò sia terribile o meno, Vladimir Putin è un frammento dell’anima del mondo, l’attore che ha dimostrato, con un movimento reale e tangibile, che la storia non è finita in nessuno di quei luoghi in cui essa sembrava essersi spenta – possa essere Hiroshima nell’Agosto del 1945, o Berlino nel Novembre del 1989. Ma l’anima del mondo non ha un viso: essa è frammentata, sparsa, è tentacolare, nasce da risacche di silenzio e di incompiuto, e non ha una direzione a priori. La direzione la si imprime, e ciò fa di essa un’azione interna allo svolgimento stesso della storia. Così come Putin, allora, l’anima del mondo si manifesta ugualmente, e forse con maggiore forza, nella figura di Zelensky.
Che cosa crea una nazione, e che cosa la distrugge?
La caduta del muro, e la conseguente fine dell’Unione Sovietica, è stata vissuta come la fine di un’epoca, la chiusura di una guerra combattuta attraverso deterrenti e minacce d’azione piuttosto che con la loro concretizzazione. La fine della divisione del mondo in zone d’influenza fu forse per l’occidente la realizzazione di un’utopia in cui la storia si sarebbe davvero conclusa con un trionfo dell’illuminismo virtuoso dopo decenni di fitta oscurità. Francis Fukuyama descrive la fine della storia come coincidente con il trionfo della democrazia liberale e del capitalismo occidentale – la conclusione entusiastica della marcia del progresso incarnato nel sublime risultato che è la democrazia capitalistica. La storia risultava così un percorso diretto a un risultato che ne avrebbe sancito la conclusione: il compimento in cui finalmente si varca la soglia di casa, e l’antico terrore che abita lo spirito viene esiliato una volta per tutte.
La narrazione della fine della storia ha tenuto banco sotto forma di mitologia: anche i conflitti successivi alla caduta del comunismo sovietico sono stati interpretati come residui, rantoli di un’epoca conclusa, scosse d’assestamento. L’occidente ha esiliato la storia al di fuori di sé, oltre i propri confini e al di là dei propri territori semantici. La cupola occidentale – la megalopoli – ha affermato in sé il linguaggio del trionfo sulla storia come dimensione esistenziale, più che su un antagonista concreto: non ci sarebbero più stati eventi o accadimenti, la carovana era ormai in moto, come afferma Fukuyama; tutto è compiuto, siamo liberi. L’occidente ha creduto in una nuova sacralità, all’interno degli spazi vuoti in cui il tempo sembra non procedere.
Non sorprende che l’Occidente sia risultato, e risulti, impressionato e impaurito di fronte all’incedere frenetico degli eventi – alla loro pura neutralità. Il dramma dell’11 Settembre 2001, degli attentati alla Francia, della pandemia, così come dell’invasione Russa, manifestano solamente questo: l’Occidente si è seduto su quello che pensava fosse il cadavere della storia, chiudendo il confine al tempo, e pensando di potersi rifugiare in una stasi, in un’iperrealtà per cui ogni attentato al proprio benessere non avrebbe potuto essere decodificato se non con il linguaggio della patologia e dell’orrore. È stato, così, percepito come alieno e incomprensibile. L’Occidente ha finito per nascondersi nella propria utopia, velocemente trasformatasi nel palco di attori litigiosi e di annoiate pulsioni. La storia continua, e noi, come tutti, continuiamo a sentirne i passi che incedono sulla soglia, sudditi inermi o attori complici. L’unica vera scelta è quella di agire nella storia, contribuendo al suo sviluppo, o subirla.
L’Occidente ha perso la visione di se stesso e del proprio significato, ha perso il senso della propria narrazione – perché sì, nel procedere della storia universale si affermano le piccole narrazioni locali, le visioni del mondo, i loro cosmogrammi. Perdendo la visione, esso non ha più saputo quale direzione prendere, cosa costruire, né comprendere il significato di quanto è stato costruito fino ad allora: ha perso l’aspetto costruttivo del desiderio, per ritornare o regredire alla pulsionalità dell’energia libidinale lasciata libera di espandersi e penetrare in ogni interstizio – proprio come ha preannunciato, e non auspicato, Lyotard. Certo, le strutture investite dei flussi libidinali mutano, si fanno turbolente, malleabili, ma tutto ciò accade all’interno di una cupola che rende vana ogni definizione dell’altro da sé, ogni riconoscimento del differente, ogni percezione dell’alterità. Soccomberà, così, alle costruzioni di quell’alterità radicalmente reale che sempre e comunque, come parte ed essenza dello spirito, continuerà a manifestarsi.
Senza un proprio senso, una propria narrazione – e questo vale parimenti per la dimensione individuale come per quella collettiva dell’esistenza – ci si riduce a essere semplicemente vittime della storia, vittime dell’azione dell’altro. Rifiutando di agire, si rifiuta di essere. Bisogna sforzarsi di pensare il proprio posto nel cosmo, se si vuole avere accesso all’azione, e se si vuole avere la possibilità di essere attori – frammenti dell’anima del mondo.
Può esserci speranza per la condizione in cui versa l’Occidente? Non quella che inerisce all’attesa. Jean Monnet affermò che l’Europa si farà nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni apportate a queste crisi. Una tale etica della reazione può certamente risultare sensata, se si tiene conto dell’irriducibile varietà di narrazioni locali e interpretazioni culturali di cui è composta l’Europa. Il miglior modo per definire una comunione d’intenti è attendere che venga minacciata la stessa libertà che permetterebbe tale comunione: reagire insieme è pur sempre un essere insieme. Ma è solamente un’indicazione, l’accenno di una potenzialità; se nella reazione si scopre il terreno condiviso, allora esso esiste anche come potenza d’atto, come moto della volontà. Eppure il desiderio non sembra instanziarvisi. L’Europa procrastina alla ricerca di segni, ma se da una parte l’azione in seno alla narrazione russa sembra scomposta e indifendibile, e offre la possibilità di pigre reazioni, dall’altra la modernità cinese continua a reclamare spazio per la sua storia.
Se esiste un lato positivo a questa manifestazione violenta della storia all’interno dell’idillico panorama di cui l’Occidente si diceva di attingere a piene mani, esso è perciò relativo al potere unificante in seno alla figura dell’”antagonista”. Il pericolo della “guerra in Europa” portato da Putin ha messo in moto – con alterna efficacia – la coscienza europea. Una coscienza che è tempo che costruisca le basi per la propria emancipazione dall’influenza statunitense e dal suo imperialismo egualmente criminoso, una coscienza che rifiuti il disegno delle “zone d’influenza”, e che mobiliti il proprio spirito – se esiste – alla ricerca del proprio senso. È una vecchio racconto, che ha le sue radici nella (turbolenta) unificazione delle poleis greche durante la seconda Guerra Persiana, contro il nemico comune. I greci non impararono dalla loro storia, pure vittoriosa, e soccombettero ad architetture culturali ben più solide e intrecciate. Tale unificazione d’intenti per reazione non può che essere il pretesto per un’Europa unita nella coscienza e nello spirito, nello sforzo massimo di creare una visione e una narrazione collettive che riempiano il concetto di Europa di una vera luce, di una chiara e ferma identità – nella consapevolezza che il terreno fertile alla produzione d’identità è lo sconfinato oceano della differenza e dell’alterità. Questo è il campo in cui l’Europa mette in gioco se stessa, in cui o si realizza come attore storico, o perisce.
Rispondere a Jean Monnet quanto segue: L’Europa si farà nelle crisi, e sarà la somma delle lezioni apprese nel cammino che essa ha intrapreso verso la propria realizzazione.
Oltre quella realizzazione, nulla sarà compiuto – ma aperto, volto alla definizione di ulteriori percorsi.
- scrive Massimiliano di Pasquale nel 2018:
“Dugin plaude all’azione del Cremlino e considera la riconquista della Crimea e la nascita delle Repubbliche Popolari di Luhansk e Donetsk tasselli chiave di un puzzle più complesso che prevede la colonizzazione dell’Ucraina e la costituzione di una Nuova Unione Sovietica, chiamata Unione Eurasiatica che dovrebbe in futuro estendersi da Vladivostok a Lisbona. E che nasce in contrapposizione al mondo liberale e Occidentale rappresentato da UE e Stati Uniti. L’intuizione delle potenze di terra – l’Eurasia e i territori dell’ex Impero Russo – contrapposte alle potenze di mare – Gran Bretagna e Stati Uniti – teorizzata da Sir Halford Mackinder nel 1904 viene manipolata da Dugin per propagandare l’idea che il conflitto con l’Occidente è condizione che da sempre caratterizza la Russia.