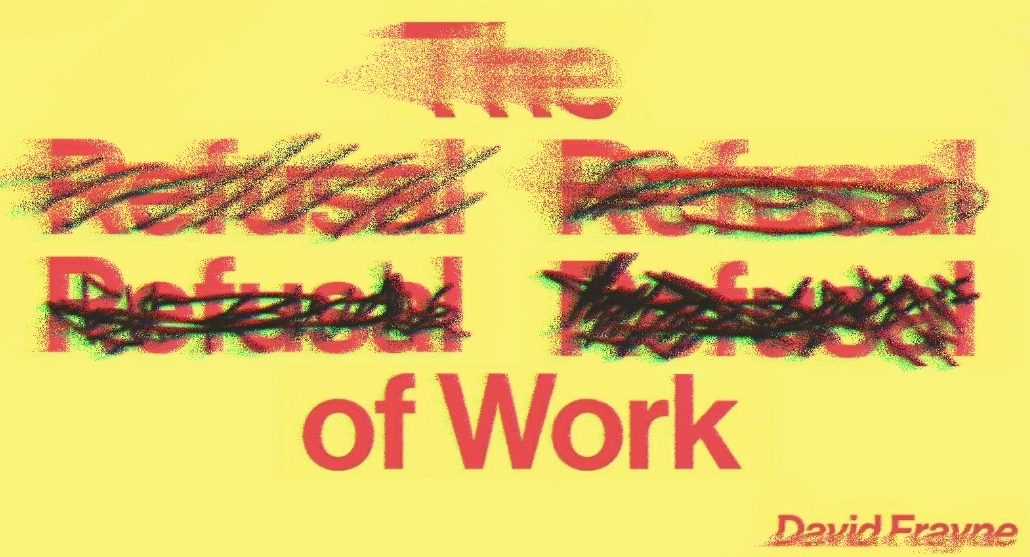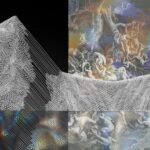trad. it. a cura di Chaosmotics
Quando si incontra per la prima volta uno sconosciuto, la prima domanda che viene praticamente sempre posta è: “Cosa fai?”. La convenzione ci dice che ciò che realmente si intende chiedere è: “Che lavoro fai?”, che è una domanda terribile da porre a una persona che non lavora, o a cui non piace il lavoro che sta facendo. È anche un segnale certo, ci piaccia o meno, che noi nella società industriale, viviamo in un mondo profondamente lavoro-centrico. La centralità del lavoro viene colta quando si riflette su quanto tempo la società dedica ad esso, tempo in cui si potrebbe anche includere quello speso a cercarlo, a prepararci ad esso, ad andare e tornare dal luogo di lavoro, e infine a riposarsi per ricominciare a produrre. Nel suo in Praise of Idleness (1935) Betrand Russell lamentava dell’esigua quantità di tempo libero moderno dedicato a “divertimenti passivi e insulsi”, ma la verità è che il lavoro, dopo aver divorato il tempo e le energie delle persone, spesso le lascia con risorse insufficienti per fare qualcosa di più appagante.
Per chi fa lavori impegnativi, diventa impossibile dedicarsi a qualunque cosa richieda un investimento di tempo e attenzione, o legami con la comunità, al di fuori del lavoro. Nemmeno la disoccupazione offre tregua, poiché anch’essa si è trasformata in una sorta di mansione. Nella società moderna, la disoccupazione assume la forma di “ricerca di lavoro”, che, come il lavoro, ha le sue esigenze performative e il suo sistema di responsabilità. Possiamo cogliere la natura lavoro-centrica della società anche considerando quante funzioni sociali importanti sono state delegate al lavoro. Esso è il principale meccanismo di cui la società si serve per la distribuzione del reddito, il che significa che la maggior parte delle persone fa affidamento sul proprio lavoro per sopravvivere. La possibilità di guadagnarsi da sé il proprio pane è ciò che tradizionalmente segna il passaggio alla maturità, e il lavorare è certamente il modo principale, e sicuramente il più approvato culturalmente, attraverso cui le persone vivono l’esistenza pubblica.
La crisi del lavoro
Se il lavoro è vitale per il reddito, per l’inclusione sociale e per il senso di identità, allora una delle contraddizioni più preoccupanti del nostro tempo è che la sua centralità persiste anche quando il lavoro si trova in uno stato di crisi. Lo svanire progressivo di un’occupazione stabile e soddisfacente rende sempre meno chiaro se i lavori moderni possano offrire il senso di autonomia morale, di riconoscimento e di orgoglio necessari per garantire che il lavoro sia fonte di senso e di identità. La standardizzazione, la precarietà e la dubbia utilità sociale che caratterizzano molti lavori oggi sono una delle principali cause della miseria moderna.
Oggi la disoccupazione di massa è anche una caratteristica strutturale e duratura delle società capitalistiche. L’eliminazione di enormi quantità di lavoro umano per mano dello sviluppo tecnologico è un processo che va avanti da secoli. Tuttavia, forse a causa del loro più alto grado di sofisticazione, si veda il caso di Siri – l’assistente virtuale di Apple – o dei droni di consegna di Amazon, la discussione sull’automazione si è nuovamente accesa. Uno studio spesso citato da Carl Frey e Michael Osborne prevede un’escalation della disoccupazione tecnologica nei prossimi anni. Tra le professioni ad alto rischio vi sono quella di modello, di cuoco e operaio edile, grazie a progressi come gli avatar digitali, gli strumenti di autocottura e la capacità di produrre edifici prefabbricati in fabbriche automatizzate. Si prevede inoltre che i progressi dell’intelligenza artificiale e del machine learning permetteranno di automatizzare una quantità sempre maggiore di attività di lavoro cognitivo.
Tutto questo significa che stiamo diventando, sempre di più, una società di lavoratori senza lavoro: una società di persone che sono materialmente, culturalmente e psicologicamente legate al lavoro retribuito, ma per le quali non ci sono abbastanza posti stabili e significativi. Il problema più pressante per molte persone, paradossalmente, non è più lo sfruttamento in sé, ma l’assenza di opportunità di essere, sufficientemente e in maniera affidabile, sfruttate. L’impatto di questo problema nell’attuale epidemia di ansia e di esaurimento nervoso non va sottovalutato.
Ciò che rende la situazione ancora più difficile è il senso pervasivo che le vittime precarie della crisi siano, in qualche modo, personalmente responsabili del loro destino. Nel Regno Unito, non passa nemmeno una settimana senza che vi sia una riaffermazione compiaciuta dell’etica del lavoro, attraverso i media, o qualche storia che definisce la disoccupazione come una forma di devianza. Mi viene in mente lo show televisivo inglese Benefits Street, ma forse l’esempio più oltraggioso degli ultimi tempi non viene dal mondo della televisione spazzatura, ma dalla tesi del dottor Adam Perkins, The Welfare Trait.
Pubblicato l’anno scorso, il libro di Perkins affronta quella che viene definita la “personalità resistente all’occupazione”. La disoccupazione è spiegata in termini di disturbo psicologico intergenerazionale. Lo studio di Perkins è il prodotto più raffinato dell’ideologia del lavoro che si possa concepire; il suo studio è talmente abbagliato dalle sue stesse pretese di obiettività scientifica, così insensibile alle sue stesse fondamenta nell’etica del lavoro, da fargli perdere la testa.
Sembra che ci troviamo nel mezzo di una sorta di faglia. Da un lato, il lavoro è stato concepito come fonte centrale di reddito, solidarietà e riconoscimento sociale, mentre dall’altro, la promessa di un’occupazione stabile, significativa e soddisfacente si è sgretolata intorno a noi. La domanda cruciale è: come devono adattarsi le società a questa crisi sempre più profonda del lavoro?
Affari, come al solito
Nel corso della storia del capitalismo, le società hanno avuto la tendenza a compensare gli effetti di sfasamento della produttività, sia aumentando la produzione di particolari industrie, sia espandendo l’economia verso nuovi settori e nuove imprese. Anders Hayden ha definito questa soluzione un tapis roulant: la necessità di un’espansione economica infinita col semplice obiettivo di mantenere i livelli di occupazione.
Tra le concretizzazioni più distopiche di questa traiettoria c’è la visione di un mondo affondato nella merce usa e getta, prodotta principalmente per mantenere le persone a lavorare e a spendere, così come esiste la triste prospettiva di una società in cui praticamente tutti i bisogni sono esternalizzati al mercato, e tutte le relazioni sociali mediate attraverso l’economia. Forse il più grande ostacolo alla soluzione “più posti di lavoro” è legata alla natura insostenibile della perpetua espansione economica. Anche se la crescita economica potesse tenere il passo della domanda di posti di lavoro, quali sarebbero i costi ambientali? Riferendosi a organismi di ricerca consolidati circa l’esaurimento delle risorse naturali, la perdita di biodiversità, l’inquinamento del suolo, e che madre di tutti i limiti, il cambiamento climatico, gli ecologisti politici come Tim Jackson hanno dimostrato che l’espansione dell’economia per fornire lavoro è diventata una strategia sempre meno efficace.
Se la soluzione non è “più posti di lavoro”, quali altre risposte esistono a nostra disposizione? Sotto il neoliberismo, i cittadini sono stati incoraggiati a prendere in mano la situazione e partecipare al dibattito. La strategia socialmente più accettabile oggi è quella di evitare il vortice di precarietà, disoccupazione e lavoro senza senso, investendo personalmente nella “occupabilità”, facendo uno sforzo a lungo termine per acquisire le competenze, le qualifiche e le sensibilità che saranno più attraenti per i datori di lavoro.
Il progetto dell’occupabilità potrebbe plasmare qualsiasi cosa, da quali materie le persone scelgono di studiare a quali aspetti della loro personalità ritengono “problematici” e che necessitano di una riforma. Una delle maggiori vittime di questa attenzione all’occupabilità è l’istruzione, il cui ruolo nella società incentrata sul lavoro è stato ridotto a funzione economica. Il contributo più prontamente accettato dall’istruzione non è quello di insegnare i principi della democrazia, del pensiero critico o dell’autosufficienza, ma di preparare e certificare i giovani per l’adozione di un ruolo lavorativo predefinito. L’ansia si scatena nella fabbrica dei diplomi (sia tra gli insegnanti che tra gli studenti), e la mobilità sociale promessa dal progresso educativo è in ogni caso un povero sostituto della vera giustizia economica. È chiaro che non tutti possono avere successo nella corsa ai posti di lavoro dignitosi.
La necessità di diventare quello che Michel Foucault ha definito un “imprenditore di sé” per mitigare l’insicurezza della vita sotto il neoliberismo demolisce anche il potere contrattuale dei lavoratori precari della società. Uno dei migliori punti di forza di un soggetto impiegabile è il consenso – l’obiettivo di essere riconosciuto, di piacere – che mette i lavoratori in una posizione di debolezza nella negoziazione di condizioni migliori per loro stessi. Questa è forse una delle spiegazioni del fenomeno, recentemente documentato, del “presenteismo”, che vede le persone rimanere in ufficio fino a tardi, anche se non hanno un lavoro da svolgere.
In un recente articolo sull’occupabilità dei laureati, Costea e colleghi hanno suggerito che la tragedia finale dell’occupabilità è la sua condizione psicologica di “infinite potenzialità”. Il giovane – e meno giovane – lavoratore non è mai soddisfatto, mai convinto di aver fatto abbastanza. Ogni relazione è una potenziale “connessione” e ogni attività un potenziale elemento per il curriculum. Accoppiata alla diffusione dello smart working, attraverso le tecnologie di rete, la “potenzialità infinita” dell’occupabilità rende comprensibile uno dei più terribili desideri segreti collettivi della società: una breve ondata di malattie personali per far cessare tutto. Almeno per qualche giorno.
Un’alternativa radicale
Sembra che abbiamo bisogno di un’alternativa più radicale – e, fortunatamente, non mancano le risorse a cui rivolgerci per trovare l’ispirazione. Esiste un’importante schiera di pensatori critici che hanno sostenuto che la soluzione più razionale e liberatoria alla crisi del lavoro non è né economica né personale. Questo gruppo di pensatori provocatori, da critici come André Gorz e Herbert Marcuse a membri del movimento post-lavorista italiano e ad autori femministi contemporanei come Kathi Weeks, hanno tutti sostenuto che l’unica soluzione legittima alla crisi del lavoro è una soluzione politica. Riconoscendo che la società del lavoro non è più sostenibile, questi autori sostengono che dobbiamo ripensare radicalmente il ruolo del lavoro nella società moderna.
Un tema comune a queste critiche è la sottolineatura di come l’enorme capacità di sviluppo produttivo del capitalismo abbia aperto la possibilità teorica di avere più tempo libero. Le macchine fanno più del lavoro necessario, lasciandoci liberi per altre cose. Fondamentalmente, però, la tecnologia da sola non ha la capacità di liberarci dal lavoro. Come ha sostenuto Gorz nella sua Critica della Ragione Economica, “lo sviluppo delle forze produttive può, di per sé, ridurre la quantità di lavoro necessario [ma] non può, da sola, creare le condizioni che renderanno questa liberazione del tempo una liberazione per tutti”. Per i critici come Gorz, la sfida che ci si pone è quella di sviluppare una lotta politica che ci permetta di trasformare finalmente il tempo risparmiato da decenni di guadagni di produttività, in fini umani. Questa sfida collettiva – che Gorz ha chiamato “politica del tempo” – richiede la definizione di nuove libertà e garanzie collettive, che permettano a tutti di beneficiare di più tempo libero. Una delle cose che rende la critica del lavoro un progetto così entusiasmante è che le preoccupazioni dei critici sono sempre diversamente accentuate. Tuttavia, in termini di proposte politiche, ce ne sono alcune che sono abbastanza coerenti tra loro.
La prima proposta è quella di una politica sociale di riduzione dell’orario di lavoro, accompagnata da una ridistribuzione sociale del lavoro necessario. Distribuendo l’orario di lavoro disponibile in modo più uniforme tra la popolazione, l’obiettivo è quello di invertire la crescente divisione della società in élite occupazionali stressate da un lato, e una massa di disoccupati, sottoccupati o precari dall’altro. Ognuno di noi lavorerebbe di meno per poter lavorare di più.
Questo va di pari passo con una seconda proposta, quella di dissociare il diritto a un salario dall’attività lavorativa, ed esplorare metodi alternativi di distribuzione del reddito. La crescente discussione sul reddito di base universale (Universal Basic Income) è un buon segno. Il reddito di base ha molte giustificazioni che concorrono a sottolinearne la legittimità, ma la più importante è che esso promette di porre rimedio al deprimente spreco di tempo e talento testimoniato nel capitalismo contemporaneo, dove l’inclusione sociale dipende ancora dalla capacità di mantenere un lavoro. Che la loro forza lavoro sia richiesta dall’economia formale o meno, le persone che beneficiano di un reddito di base avranno le risorse per intraprendere un lavoro per se stessi e per gli altri, se lo desiderano. La speranza è che, con il beneficio del tempo e di un reddito, le persone siano in grado di sviluppare una serie di interessi e capacità al di fuori dell’occupazione.
Questi ultimi scenari di cambiamento non sarebbero probabilmente molto significativi, se non fossero sostenuti da un cambiamento qualitativo delle nostre culture e delle nostre sensibilità. Una soluzione radicale alla crisi del lavoro richiede anche che ci si riesamini, in modo da esplorare la possibilità di modi alternativi per sperimentare il piacere e la solidarietà che le persone hanno cercato convenzionalmente (spesso senza successo) nel lavoro. Per articolare questo in termini di asserzione: dobbiamo esigere la dipartita dell’idea conservatrice che il lavoro retribuito è intrinsecamente sano e civile.
Alcuni obietteranno senza dubbio dicendo che l’occupazione è cruciale per il senso di benessere delle persone (e c’è una grande quantità di ricerche sulle miserie della disoccupazione che possono essere addotte a prova). Le dinamiche di questo dibattito sono complicate perché il lavoro è davvero importante per la salute in una società organizzata per promuovere la dipendenza dal lavoro. È solo un attaccamento morale al lavoro, tuttavia, che ci impedisce di rimanere aperti all’idea che il futuro potrebbe essere diverso. In futuro, è perfettamente possibile che le attività alternative ci permettano di sperimentare il senso di solidarietà e di finalità che il lavoro oggi offre (o non offre, a seconda dei casi).
Faremmo anche bene a ricordare ai dubbiosi che l’attuale costruzione dell’identità e della solidarietà sociale attraverso il lavoro ci rende estremamente adatti allo sfruttamento. Altri potrebbero protestare contro la critica del lavoro come difesa un po’ giovanile del “diritto di essere pigri”. Per esempio, quando il primo ministro britannico David Cameron ha dichiarato che il suo governo avrebbe servito principalmente gli interessi delle “persone che lavorano sodo”, le linee etiche sono state tracciate con decisione: sei un lavoratore o uno che si sottrae al lavoro? Si pensava che non ci fosse spazio da occupare nel mezzo, che non ci fosse un modo legittimo di dare un contributo sociale se non attraverso il lavoro.
È importante rifiutare questa dicotomia ogni volta che è possibile, e riconoscere anche che la critica del lavoro è molto di più che la difesa del diritto di essere pigri. Mentre la pigrizia ha certamente un posto legittimo in un futuro post-lavoro, ciò che in definitiva viene richiesto dalla critica del lavoro non è tanto il diritto all’ozio, ma il diritto a potere sviluppare più pienamente le capacità umane. In The Problem with Work, Kathi Weeks è chiara quando sostiene che criticare il lavoro non significa necessariamente negare il valore del lavoro: si tratta piuttosto di insistere sul fatto che ci sono altri modi per organizzare e distribuire tale attività e di ricordarci che è possibile essere creativi anche al di fuori dei confini tracciati dal lavoro. È per suggerire che ci possono essere una varietà di altri modi per sperimentare il piacere che ora troviamo in esso, così come altri piaceri che possiamo desiderare di scoprire, coltivare e godere.
In un momento in cui il lavoro è chiaramente in uno stato di crisi, il progetto critico che Weeks descrive è un progetto importante. Di fronte alle crescenti crisi del lavoro, il sognatore non è forse più l’utopista che cerca alternative, ma la persona che crede che le cose possano andare avanti così come sono. La soluzione radicale è la soluzione sana.
Allo stesso tempo, però, sarebbe un errore vedere la critica del lavoro solo come una “soluzione” alla crisi. È anche un’occasione per mantenere finalmente la promessa originaria dello sviluppo produttivo del capitalismo: liberarci dal lavoro e permetterci di godere collettivamente di più tempo libero. La speranza è che una politica del tempo ci permetta di esplorare quelle attitudini e quegli aspetti di noi stessi che spesso vengono messi da parte in un mondo incentrato sul lavoro. La speranza è che avere più tempo al di fuori del lavoro, con il beneficio di nuove strutture pubbliche, inneschi la creazione di reti informali di produzione e di scambio al di fuori dei confini dell’economia formale.
Forse un aumento del tempo libero potrebbe anche permettere alle persone di diventare cittadini più attivi. Uno dei motivi per cui il dibattito democratico è attualmente in uno stato così moribondo è che le nostre vite impegnate ci lasciano così poco tempo per fare politica, per organizzarci collettivamente o scoprire cosa succede nelle nostre comunità. Forse ciò che promette una politica del tempo, però, è soprattutto di permetterci di usare il nostro tempo libero per qualcosa di diverso dalla fuga dal lavoro.
La strada da percorrere
La costruzione sociale del lavoro come fonte chiave di reddito, di diritti e di appartenenza è incessante. Ma è anche chiaro che per un gran numero di persone il lavoro è diventato una fonte inaffidabile di queste cose. Si tratta di una crisi profonda, che richiede una rivalutazione altrettanto profonda del lavoro e del suo posto nella società moderna. Questo compito – la “politica del tempo” di Gorz – ha lo scopo di offrire una risposta pratica alla disintegrazione dell’odierno mondo del lavoro. Ma più di questo, ci invita anche a parlare delle condizioni di libertà e di avviare un nuovo dialogo sul tipo di società in cui vorremmo vivere.
In linea generale, sono incline a convenire con il suggerimento di Gorz per cui il cambiamento culturale verso una società del post-lavoro è già in parte accaduto. Se diamo un’occhiata alla glorificazione dell’etica del lavoro nei media conservatori, ciò che troviamo è un’enorme quantità di persone che hanno già mentalmente rinunciato all’idea di una società incentrata sul lavoro, e che stanno attivamente cercando di massimizzare il loro tempo libero, riconfigurando la loro identità attraverso attività non lavorative. Le sensibilità anti-lavoro si trovano ovunque, tra gli artisti o le persone con degli hobby che cercano di trovare del tempo per fare ciò che amano, tra i volontari e i badanti che spendono il loro tempo per gli altri, tra le persone che vanno anticipatamente in pensione per riscoprire passioni perdute, oppure tra i laureati che gradualmente rinunciano al sogno di godere del posto fisso.
In una certa misura, ho documentato queste sensibilità anti-lavoro nel mio libro, The Refusal of Work, servendomi di interviste con persone (con diversi gradi di successo) che cercano di sottrarsi dallo svolgere un lavoro retribuito. Molti erano disposti a sopportare notevoli difficoltà nel farlo. Una delle cose più rimarchevoli di questo studio fu che i partecipanti erano dei soggetti politici, richiedenti alternative sociali, meno radicali rispetto alla gente comune che cercava solamente di lavorare meno e avere più tempo libero. Questi soggetti hanno incarnato un’insoddisfazione latente nei confronti del lavoro che deve ancora trovare un’offerta politica, e il dilemma che forse ora ci ritroviamo ad affrontare è come legittimare e mobilitare questa insoddisfazione. Dobbiamo trovare dei modi per articolarla nella forma di un’alternativa politica.
Per quanto riguarda la prospettiva di sviluppare una politica fondato sul post-lavoro su queste basi, è giusto sottolineare che ho concluso la mia ricerca con una nota piuttosto pessimistica. Nel Regno Unito, la politica mainstream – sia di destra che di sinistra – sembra ancora ossessionata dalla dignità del lavoro. Tuttavia, vi sono stati alcuni importanti cambiamenti da quando la mia ricerca è stata pubblicata. Vale la pena menzionare qui le politiche anti-lavoro del gruppo attivista britannico Plan C, così come la New Economic Foundation — un think tank che sta esplorando la possibilità di una settimana lavorativa di 21 ore. Anche la discussione sul reddito base sembra acquisire più riverbero, con una serie di campagne ed esperimenti importanti documentati dal Basic Income Earth Network negli ultimi mesi.
Vale la pena menzionare inoltre il recente “No Jobs Bloc”- una coalizione di gruppi coordinati dalla Radical Assembly -, la quale ha marciato nella protesta anti-austerità di Londra all’inizio di quest’anno. I manifestanti portavano con sé striscioni con slogan ispirati dalla recente critica al lavoro di Nick Srnicek e Alex Williams, Inventing the Future, chiedendo un reddito base universale, piena automazione, la riduzione della settimana lavorativa, e l’attribuzione di valore al lavoro non retribuito ed emotivo. Questa diffusione popolare della critica del lavoro è incoraggiante, ed è difficile prevederne il destino. Ad ogni modo, una cosa è certa: se qualcuno, qualche anno fa, mi avesse detto che degli attivisti nel Regno Unito avrebbero cantato slogan contro il lavoro per le strade, non ci avrei mai creduto.
Questo articolo è stato scritto, in originale, per Roar Magazine