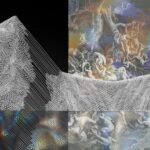copertina da Man’s reflection, Guy Billout
Il vocabolario dei più recenti discorsi emancipatori sembra stare integrando progressivamente parte del lessico psicologico e neuropsicologico. Ma cosa succede se i sintomi, i tratti e le diagnosi rivendicate sono solo quelle che più si adattano al sistema capitalistico?
__________________________________________
[…] la cultura identitaria finisce per essere una cultura povera, che per giunta non conosce la sua miseria. In fondo, l’identità è l’ultima risorsa che rimane quando c’è penuria di strumenti per immaginare un futuro diverso, quando si chiudono gli occhi di fronte alle possibilità dell’alterazione.
F. Remotti, L’ossessione identitaria
Introduzione
Dai paper accademici alle rivendicazioni sotto forma di TikTok o Instagram carousel, il leitmotiv delle più recenti lotte emancipatorie può essere definito come la scoperta del “diritto di definirsi”. Questa scoperta può risultare fondamentale dal momento che, come sostiene Chiara Durastanti, «il rovescio del diritto di definirsi è il diritto di dimenticarsi»1: ci si dimentica di rientrare all’interno di una categoria quando si fa storicamente parte di quella che ha avuto il potere di definire le altre per la prima volta. Il diritto di definirsi – e di usare tale definizione come mezzo emancipatorio – è la base teorica delle Identity Politics, un approccio politico che prende forma durante la seconda metà del secolo scorso negli Stati Uniti, parallelamente all’emergere di nuovi movimenti sociopolitici che rivendicavano giustizia per specifici gruppi sociali. Si apre così una stagione di lotta politica basata sulle identità – e quindi sulle diverse esperienze di discriminazione – dei gruppi sociali oppressi.
Le Identity Politics hanno portato in Italia questa modalità di rivendicazione sociale basata sul (auto)riconoscimento: anche movimenti come il femminismo intersezionale 2 stanno progressivamente abbracciando le rivendicazioni di stampo identitario, proponendo una descrizione dell’individualità come assemblaggio di intersezioni di identità sociali, quali ad esempio la classe, la razza, il genere, l’orientamento sessuale e il grado di abilità. Questa intersezione, nel discorso mainstream, si ferma per lo più sul piano degli individui e delle loro identità composite, mancando del respiro più ampio della riflessione intersezionale.
In questo intrecciarsi di componenti identitarie vediamo crescere quelle che provengono dal mondo della psicologia e neuropsicologia: si parla sempre più spesso di se stessi attraverso sintomi, tratti e diagnosi. Che sia in modo ironico attraverso i nuovi format contenutistici dei social, o attraverso blog che raccontano l’esperienza personale filtrata attraverso il punto di vista della diagnosi, libri, slogan più o meno predicatori, scritte a grandi lettere su cappelli e magliette, di diagnosi si parla molto più che di altri ambiti delle scienze psicologiche. Ci troviamo in un momento di particolare interesse per queste discipline, che va di pari passo con l’aumento dei disordini mentali diagnosticati negli ultimi anni. 3 Anche in Italia, sebbene gli orientamenti maggioritari siano stati storicamente per lo più di stampo dinamico e umanistico, l’influenza degli approcci evidence-based che basano i propri interventi sull’assessment psicodiagnostico e sulle relative linee guida internazionali è sicuramente una tendenza in forte crescita. Non risulta dunque strano che con l’aumento delle diagnosi e con l’incremento della diffusione dei contenuti inerenti le diverse condizioni psicopatologiche – con diversi livelli di approfondimento e stereotipizzazione – le condizioni mentali entrassero a far parte del discorso sociale, soprattutto nelle fasce più giovani dove c’è una maggiore apertura verso queste tematiche.
Il motivo per cui questo tipo di identificazione è abbracciato e diffuso anche nelle piattaforme e dai soggetti che si occupano di attivismo4 per le minoranze è facile da identificare: le persone diagnosticate con condizioni mentali sono un gruppo vulnerabile, e la salute mentale si trova sempre agli ultimi posti dell’agenda istituzionale.
I movimenti che si rifanno alla grammatica delle Identity Politics pongono moltissima enfasi sulle pratiche discorsive come veicolo di “normalizzazione” di certe istanze. In questo senso, reagire a uno stato di cose significa inserire nella propria narrazione personale questa o quella mancanza narrativa, manifestando la propria “verità scomoda” agli altri – la diagnosi in questo caso – per presentarsi come frammento discorsivo che, nel coro delle altre narrazioni, contribuirà a rendere normale, quindi accettabile, una certa idea.
In questo articolo cercherò di analizzare la congiuntura di significati e motivazioni che permette alle Identity Politics e al linguaggio psicodiagnostico di diventare singolari alleati, in modo da far emergere alcune interrogazioni necessarie riguardo questa stagione di lotta politica. È importante sottolineare che, in riferimento alle modalità attraverso cui determinati discorsi emergono dalla molteplicità delle nuove forme di rivendicazione sociale, la riflessione non riguarderà né questioni interne all’accademia né specifici movimenti. La ricerca e la critica all’interno dei diversi approcci alle Identity Politics sono ampie e feconde, ma non corrispondono alla loro realizzazione nella società. Allo stesso modo la questione delle diagnosi psicologiche ha risvolti clinici ed epistemologici che eccedono gli obiettivi di questa riflessione. L’intento del testo è sollevare criticità e dubbi rispetto al modo in cui alcune influenze e tematiche emergono e producono significati nel discorso collettivo quando incontrano le necessità, le vulnerabilità e i desideri di questo spirito del tempo.
Questioni di origine
Come accennato, le motivazioni esplicite dell’uso di diagnosi psicologiche come arma di rivendicazione si riferiscono per lo più alla mancanza di attenzione che le istituzioni riservano alla salute mentale e alla volontà di rendere meno discriminatorio il discorso intorno alle condizioni mentali.
Parlare della propria diagnosi diventa quindi un modo di “portare il problema nel discorso”, farlo esistere socialmente. Il singolo assume su di sé il peso della narrazione mancante per farsi portavoce di una richiesta collettiva. Questo aspetto evidenzia un sistema di critica sociale basato sull’esperienza individuale convalidata attraverso quella che Kruks5 definisce criticamente “un’epistemologia della provenienza”. Quest’ultima radicalizza l’individualismo del sentire e del patire, rendendo i singoli attori unici custodi di un’esperienza – di sofferenza o di discriminazione – che può essere solo da loro confermata e resa operativa6.
Rispetto ad altri approcci, le basi teoriche delle Identity Politics si sono diffuse in maggior misura nell’infosfera mainstream perché si prestano all’individualismo della cultura neoliberista e rispondono in modo palliativo, eppure convincente, alla fame dilagante di autoreferenzialità, moltiplicando le rivendicazioni e i portavoce.
In diversi articoli Fisher spiega in che modo stress, depressione e ansia siano espressioni medicalizzate del disagio dell’individuo che si trova a vivere in un contesto esistenziale le cui regole sono dettate dalla competizione e dalla rassegnazione proprie del realismo capitalista:
Da qualche tempo, una delle tattiche di maggior successo della classe dirigente è stata la responsabilizzazione. Ogni singolo membro della classe subordinata è incoraggiato a sentire che la propria povertà, mancanza di opportunità o disoccupazione è colpa loro e solo loro. Gli individui daranno la colpa a se stessi piuttosto che alle strutture sociali, che comunque sono stati indotti a credere che non esistano realmente (sono solo scuse, invocate dai deboli)7.
Secondo David Smail, psicologo che ha cercato di integrare nella sua pratica una consapevolezza più approfondita delle condizioni materiali della società in cui i soggetti sono calati, «[l]a maggior parte delle psicoterapie pone poca enfasi teorica sulla necessità per le persone di confrontarsi con quelle strutture materiali nel mondo esterno che hanno contribuito a rendere le loro vite una miseria» 8, e questo è curioso, dal momento che interventi psicoeducativi – sull’affettività, sull’emotività, ma anche sulle specifiche della propria condizione – sono parte integrante di moltissime tipologie di intervento. Le pressioni sociali e immediatamente concrete che, se non causano, quantomeno contribuiscono all’insostenibilità della vita dei soggetti, tuttavia non vengono viste come qualcosa di fondamentale in questa educazione. Il timore, come spesso accade nelle discipline di frontiera tra la scienza e la vita pratica, è quello della contaminazione con il politico. Si plasma così, sia nei soggetti che negli amministratori della cura una sostanziale ingenuità rispetto agli aspetti materiali, patologici, della sofferenza mentale, spesso controbilanciata da un’eccessiva focalizzazione sugli aspetti nosografico-descrittivi e neurocognitivi delle diverse condizioni.
Questa resezione del politico conduce a una visione essenzialista della sofferenza mentale, definita come tutta interna al soggetto, costitutivamente e colpevolmente sua. È questa facilità di riduzione di un’esperienza soggettiva che rende le Identity Politics il veicolo perfetto per la diffusione dei discorsi sulle diagnosi, che dal canto loro offrono un’identificazione già pronta e già ferita: un’identità sofferente che necessita di riscatto, ma soprattutto di attenzione, comprensione e legittimazione.
Miserie dell’identità
La realizzazione sociale delle Identity Politics pone grande enfasi sulla capacità del linguaggio di cambiare il modo in cui pensiamo, di aprire varchi di significazione per le identità degli ultimi.
Tuttavia, se il breve raggio d’azione di questi discorsi fallisce nell’interrogare le strutture di potere – che peraltro contribuisce a creare –, soccombe al rischio di nuove gerarchizzazioni e, nel caso specifico, di una perdita di controllo su delle meccaniche che erano state concepite come emancipative. Le rivendicazioni identitarie degli ultimi anni sono state facilmente assorbite dal sistema economico, e questa assimilazione non è un accidente, ma è stata, in un certo senso, esplicitamente richiesta: la domanda di una maggiore rappresentanza mediatica delle categorie emarginate è stata infatti prontamente concessa – quantomeno a tutte le categorie che potevano pagarla, che si sono finalmente viste entrare nel “discorso” – e colossi come Netflix hanno costruito gran parte della propria immagine sulla categoria di inclusività. Se in parte di questo risultato non si può che essere soddisfatti, perché la rappresentanza è importante, forse anche vitale, nondimeno non risolve i problemi delle condizioni materiali delle categorie marginalizzate, e inoltre interessa una fascia di persone scolarizzata, con ampio accesso all’informazione e ai media, una classe non povera.
Il rovescio della medaglia della richiesta di rappresentanza è la commodification. È facile accorgersene: il consumismo identitario ci inchioda tutti agli store online; una t-shirt che parla della nostra causa, ma perché no, anche un pezzo di arredamento a chilometro 0, perché siamo ecologisti, anche se non smettiamo mai di comprare. Non possiamo andare al supermercato, in farmacia o guardare un film senza che ci venga venduto un pezzetto di identità. Tutto intorno sembra dirci: «Tu esisti! E sei proprio così, sei questa cosa qui! Parlane, perché è questo il pezzettino di puzzle che manca nel mondo». Il mercato identitario è questo commercio di illusioni a cui rendiamo spesso grazie: grazie di averci riconosciuti, grazie per questi orpelli che mostrano a tutti chi siamo.
Per Remotti9 l’identità è attraente perché permette di definire i noi e gli altri all’interno di una gerarchia di potere che si può legittimare come naturale e astorica. Questo vale per le culture come per gli individui: non dobbiamo dimenticarci della separazione che precede ogni creazione identitaria, nonostante l’identità serva proprio a questa dimenticanza. Scordare la scelta, l’arbitrio, il percorso accidentato che ci porta a essere l’assemblaggio traballante che siamo nel qui e ora e che non saremo più: la vulnerabilità di questo involucro.
L’affannato ricorso a queste identificazioni stabili e l’uso identitario delle diagnosi rispondono a una stessa necessità fondamentale: quella di sentirsi giusti anche se diversi, di non sentire su di sé la responsabilità di ciò che è mancanza o differenza. Le Identity Politics utilizzano come arma emancipatoria un concetto – quello di identità e dell’esperienza essenziale che ne deriverebbe – così facilmente assimilabile dalle meccaniche di dominio esistenti che il rischio di accettare una vana sostituzione delle identità dominanti con alcune identità minori senza riuscire a scardinare radicalmente le condizioni di dominio dei gruppi emarginati è molto concreto.
Vecchie e nuove gerarchie
Questo rischio emerge in modo emblematico volgendo la riflessione alle diagnosi che vengono accolte maggiormente dalle narrazioni presentate come emancipatorie e normalizzanti. Non si parla molto di schizofrenia, psicosi, di disturbi di personalità borderline e narcisistica, quanto si parla di diagnosi di depressione, di disturbi di ansia, fobie, di neurodivergenze o disturbi dell’apprendimento, che sono certamente più diffusi, soprattutto nel caso della depressione e dell’ansia.
Ci sono infatti diagnosi, come quella di disturbo narcisistico di personalità, che vengono utilizzate in modo discriminatorio10 anche in ambienti progressisti, e che molto di rado vengono palesate. Un discorso simile si può fare per le diagnosi del disturbo borderline, che tuttavia guadagna un margine maggiore di enunciabilità nella tolleranza che gli ambienti progressisti concedono alle narrazioni sofferenti delle donne, maggiori ricevitrici di questo tipo di diagnosi.
In fin dei conti, per definirsi pubblicamente, non tutte le diagnosi sono ugualmente valide, e questa spinta al disvelamento non è dettata solo dall’impulso alla “normalizzazione della malattia mentale” che fa da slogan alle rivendicazioni, ma anche da un certo controllo della narrazione di sé messo in atto dagli individui. Le diagnosi che storicamente sono state più segregate tendono a essere ancora oggi taciute e nascoste, e nuove diagnosi sono assurte al ruolo di indesiderabili.
Si parlerà allora di diagnosi preferendo mettere al centro del discorso quelle più autoassolutorie, comprensibili, in grado di suscitare empatia e comprensione, oppure, di quelle che grazie alla radice “neuro” possono fregiarsi del titolo di problema “biologico”, non arbitrario, subìto dal soggetto. È la natura che lo ha voluto, non quel pantano confuso e colpevole che è l’esistenza soggettiva. Questo controllo della narrazione non riguarda solo la rivelazione della diagnosi, ma ogni tipo di narrazione del dolore personale. Dove si ferma questa estetizzazione della sofferenza, e quali ultimi crea? Mentre speravamo di creare spazi per parlare della sofferenza e della differenza abbiamo avallato vecchie gerarchie e ne abbiamo create di nuove. Questo puntuale controllo della narrazione mostra la dipendenza dall’altro e della legittimazione esterna che l’epistemologia della provenienza aveva cercato di nascondere. D’altronde, come scrive Butler, il soggetto è
[o]bbligato a cercare conferma della sua stessa esistenza in categorie, definizioni e nomi creati da altri, il soggetto cerca tracce della sua esistenza al di fuori di se stesso, in un discorso che è, contemporaneamente, dominante e indifferente. Le categorie sociali rappresentano un segno di sottomissione, così come di esistenza. 11
Questa sottomissione è particolarmente evidente nella logica che le Identity Politics mettono in atto verso i riconoscimenti mancati. Si mostra quanto l’esperienza minoritaria sia sofferente e vulnerabile, sperando di suscitare empatia e attenzione, ma anche senso di colpa. Se ciò non avviene, è l’identità degli avversari a venir ridefinita: non si parlerà di comportamenti, atteggiamenti o punti di vista problematici, ma saranno le persone a esserlo.. La grammatica dello scontro sociale Identity Politics è manichea, e non può che essere impietosa. Non riesce a sganciarsi da una tipologia di approvazione esterna che assomiglia molto a quella della dinamica genitoriale, manifestando così, a un tempo, il residuo di subalternità percepita, ma anche quanto sia complesso riscrivere le rivendicazioni emancipatorie in una cultura fortemente paternalista.
Per superare il proprio senso di mancanza lo si porta fuori, nell’altro, contribuendo a mantenere intatte le retoriche delegittimanti della vergogna e della colpa che, forse emulando anche un certo prescrittivismo di matrice cattolica, sono stati efficaci strumenti di mantenimento dello status quo. Così la critica sociale fallisce nel suo scopo principale, la possibilità di creare nuove narrazioni di legittimazione e mancanza che non ricalchino le retoriche egemoniche che si vuole superare.
Brown sostiene che la politica dell’identità deve la sua genealogia al capitalismo liberale che rinforza inesorabilmente gli “attaccamenti feriti” che afferma di recidere: «[l]’identità politicizzata si enuncia così, rivendica se stessa, solo radicando, riaffermando, drammatizzando e inscrivendo il suo dolore nella politica; non può offrire alcun futuro – per se stesso o per gli altri – che trionfi su questo dolore».12 La politica dell’identità si mantiene su categorie gerarchizzate, definite per opposizione, e si identifica eccessivamente con il dolore, il trauma e le ferite che la società gli ha inflitto. Questa identificazione richiede un certo tipo di performatività del dolore e di estetizzazione della sofferenza. Da questo punto di vista è evidente perché può essere appetibile identificarsi attraverso una diagnosi – benché non una qualsiasi, e non in qualsiasi modo – che confina la sofferenza e la differenza all’interno di una categorizzazione pulita, ben delimitata e adeguata allo storytelling.
Gli strumenti del padrone
La storia delle diagnosi psicologiche è una storia complessa, segnata da un percorso estremamente accidentato tuttora oggetto di ricerca e discussione. Accettare in modo acritico il realismo psicodiagnostico14 per legittimare certe rivendicazioni è quindi molto più di un mero problema epistemologico: è un problema politico e un problema esistenziale, che chiama in causa la nostra profonda incapacità di legittimare le differenze, lo scontro con l’altro e la mancanza di pratiche di autolegittimazione diverse da quelle disegnate dalla dinamica passiva e manipolatoria della vittima.
Gli studi postcoloniali e i rilievi dell’epistemologia femminista hanno mostrato come il progresso della conoscenza avvenga tra determinanti sociali che lo indirizzano in modo non neutrale e spesso discriminatorio15, dimostrando che un aspetto necessario della lotta sociale è l’atteggiamento critico verso le istituzioni che producono verità e con questa verità operano. La storia recente ha posto la questione della credenza nelle scienze al centro del discorso pubblico in una maniera tanto polarizzata da aver creato un pessimo ambiente per questa critica. Tuttavia, alle scienze non si crede, perché non sono religioni, a esse ci si affida, e proprio perché ci si affida le si supervisiona in quanto collettività16. Anche alla psicologia e la psichiatria: serve a poco ottenere i fondi pubblici per la terapia, se poi la maggior parte degli specialisti è impreparata o discriminatoria verso le minoranze che vi accedono17, o se le categorizzazioni che utilizza sono influenzate da pregiudizi su certe fasce della popolazione18.
Se i soggetti minoritari sono tali perché la loro identità è stata definita e differenziata dalle altre a partire dalle classi dominanti, si può pensare di rivendicare quell’identità senza mettere in discussione il modo in cui essa è legata alla propria provenienza subalterna?
Il problema non sta tanto nel – seppur criticamente fondamentale – argomento lordeiano dell’impossibilità di condurre la lotta sociale usando gli strumenti del potere19. Secondo Chapman20, filosofo e attivista che si occupa di neurodivergenze, dal momento che le diagnosi nascono nella società, e solo dopo vengono categorizzate nelle tavole rotonde degli specialisti, reclamare le categorizzazioni è molto più utile che sperare che queste smettano di venire utilizzate in modo improprio dall’alto. Nessun cambiamento avviene in un vuoto categoriale e discorsivo.
Quello che può rivelarsi problematico è un uso di questi strumenti che non metta fortemente in discussione i loro legami con le strutture di dominio e la vulnerabilità che ci attira verso determinate forme di sottomissione palliativa. Mettere in discussione il contenuto di una diagnosi può significare abdicare alla legittimità della diagnosi stessa e quindi al sollievo identificativo che ne trae il soggetto. La diagnosi non può emanciparsi completamente dalla dinamica di potere verticale nella quale è iscritta: necessita di qualcuno che la conferisca, e anche nel caso dell’autodiagnosi, pratica emancipatoria utilizzata ad esempio all’interno di alcune comunità autistiche, di una serie di organi e istituzioni epistemiche che la legittimino a monte. Non prendere sul serio la vulnerabilità sotterranea che rende addirittura delle diagnosi di disturbi mentali più appetibili del vuoto simbolico in cui il soggetto si sente annegare significa mettere in atto una lotta che è, in fondo, già alla fase di resa.
Conclusione – Inadeguati
Il piano della legittimazione, quando la lotta politica si fa discorso, è fondamentale perché si trasforma in una chiave in grado di aprire nuove possibilità di riconoscimento. Ho argomentato che, tuttavia, se per legittimare i discorsi vengono utilizzati concetti senza vigilare attentamente sulle dinamiche di dominio che li hanno resi possibili, si rischia di portare quelle vulnerabilità nei movimenti e nella lotta sociale. D’altronde, proprio perché fare politica solo attraverso il discorso non può che comportare un continuo sforzo di legittimazione dei discorsi minori, è chiaro che questa rischia di avvenire attraverso le modalità immediatamente disponibili nello status quo, come una fiducia acritica nella neutralità scientifica o l’indugiare in narrazioni vittimistiche e colpevolizzanti, che situano nell’individuo e nella sua esperienza ferita la giustificazione delle rivendicazioni. Di fronte a questo rischio, ha senso chiedersi perché concentrare tante forze solo sul piano linguistico-narrativo e la sua presunta capacità, da solo, di liberare le identità.
Non credo che rivendicare le diagnosi psicologiche sia impossibile, a patto che la critica su di esse sia radicale, che la loro interconnessione con antiche e nuove logiche di potere sia severo oggetto di interrogazione, non solo all’interno degli ambienti accademici, ma anche in quelli di lotta sociale. D’altra parte, trovo che sia anche importante chiedersi quando è necessario utilizzare le diagnosi come mezzo emancipatorio, quanto indulgere nella meccanica di subordinata assoluzione che mettono in atto, e quanto queste categorie autoesplicative stiano cannibalizzando le nostre possibilità di sentire quello che proviamo in modi diversi da quelli permessi dalla grammatica del linguaggio medico, basato su funzionamenti e malfunzionamenti, adeguatezza e inadeguatezza alle strutture sociali esistenti.
Sul piano individuale, il sentimento che dobbiamo interrogare è proprio quel sollievo che proviamo quando utilizziamo una diagnosi o un termine come “funzionamento” e “depressione” perché quelle parole ci sembrano avere il potere di una verità confermata da altri. Come se il sentire non fosse mai sufficiente, come se nella relazione non esistesse possibilità di ibridazione e traduzione, ma solo gli estremi dell’accettazione e dell’annichilimento. In questo sollievo risiede tutta la sconfitta, l’evidenza del fatto che anni di pratiche discorsive abusanti ci hanno davvero convinti di essere difettosi, e che a questa mancanza supposta o reale non sappiamo come rispondere se non cercando un’immediata assoluzione esterna – dovunque questa provenga – prima di rientrare nelle torri delle nostre identità sicure. Vogliamo poter dire: «siamo nati così, non c’è scelta e non c’è arbitrio, non possiamo che essere questa cosa inadeguata che vi presentiamo». Porci la questione in modo sincero porta alla luce la sostanziale sfiducia verso un mutamento delle dinamiche sociali che non comporti solo un sollievo individuale ma anche un mutamento concreto delle condizioni di vita. Si pensa di poter agire sui comportamenti, ma non sulle coscienze; sull’immediatezza dell’enunciazione, ma non sulla temporalità della relazione.
La necessità di fondare le rivendicazioni all’interno dei contorni di un sentire reso insindacabile rivela una sfiducia profonda nella capacità di poter agire sul piano orizzontale delle relazioni e dei desideri, una resa preventiva verso la conflittualità intrinseca alla differenza e le sue possibilità trasformative. Il Comitato Invisibile scrive che perché un’insurrezione funzioni – ovvero: che non permetta il ritorno di ciò che aveva combattuto – bisogna aver eliminato sia l’autorità che il bisogno dell’autorità21. Dal momento che l’insurrezione non è nei piani del futuro più prossimo e possiamo solo contare su processi di lungo periodo, facciamoci una promessa temporanea, nella speranza di ricordarci di essere passati di qui e che questa non si dimostri un’occasione persa: saremo responsabili delle nostre differenze e attraverso il loro incontro creeremo collettività solidali.
Giulia Bergamaschi si è laureata in Filosofia della Scienza e della Mente all’Università di Roma Tre e in Psicologia all’Università di Pavia. Toscana di nascita, milanese di adozione, si occupa principalmente del rapporto tra scienze e discorso pubblico e di epistemologia sociale
- C. Durastanti, Traduzioni, impegno e identità, [on-line] in: Internazionale, pubblicato in data 26 marzo 2021 [8 febbraio 2022].
- P. Hill Collins, S. Bilge, 2016, Intersectionality, Cambridge: Polity.
- Cfr: https://www.apa.org/news/press/releases/2019/03/mental-health-adults
- Nelle diverse e più o meno criticabili accezioni che questo termine ha assunto recentemente, con la diffusione di forme di divulgazione, advocacy e sensibilizzazione che si situano anche, e forse soprattutto, sulle piattaforme social.
- S. Kruks, Retrieving Experience: Subjectivity and Recognition in Feminist Politics, Cornell University Press, Ithaca NY 2001.
- Per sofferenza performata non s’intende sofferenza inautentica: anche le sofferenze genuine vengono performate, nel senso per cui austinianamente ogni atto comunicativo è anche performativo. La sincerità delle difficoltà non è mai oggetto di questa analisi.
- M. Fisher, Good for nothing [on-line] in: The Occupied Times, pubblicato in data 19 marzo 2014 [8 febbraio 2022] traduzione dell’autrice.
- D. Smail, The origin of unhappiness. A new understanding of personal distress, Harper Collins, New York 1993, traduzione dell’autrice.
- F. Remotti, L’ossessione identitaria. Laterza, Roma-Bari 2010.
- Il caso del disturbo narcisistico di personalità è particolarmente interessante perché viene spesso utilizzato (anche su piattaforme e ambienti progressisti) per parlare di relazioni abusanti e per dare istruzioni alle donne su come interrompere questo tipo di relazioni. Si crea così una percezione che lega causalmente narcisismo e abuso che, oltre a non essere suffragata dalla ricerca (non tutti i narcisisti abusano, non tutti gli abusi vengono compiuti da narcisisti) sposta il discorso dalla questione sistemica – l’abuso – alla questione categoriale. Il narcisismo per gli uomini, come il disturbo borderline per le donne, è una condizione che mostra un grande bias di genere nella diagnosi, come si può leggere qui: W. Braamhorst, J. Lobbestael, W.H. Emons, A. Arntz, C.L.Witteman, M.H. Bekker. Sex Bias in Classifying Borderline and Narcissistic Personality Disorder. J Nerv Ment Dis. 2015 Oct;203(10):804-8. Questo potrebbe significare, come molte femministe hanno suggerito per il disturbo borderline (Cfr: C. Shaw & G. Proctor, (2005). Women at the Margins: A Critique of the Diagnosis of Borderline Personality Disorder.” Feminism and Psychology 15(4): 483-490.), che queste condizioni vadano indagate in termini più ecologici e meno riduzionistici.
- J. Butler, La vita psichica del potere. Teorie del soggetto. (1997) Mimesis, Milano 2013.
- W. Brown, States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity, Princeton University Press, Princeton 1995.
- In questo senso è importante sottolineare che il realismo psicodiagnostico, ovvero la pretesa che le diagnosi ricalchino in modo 13ccurato delle condizioni esistenti in modo assoluto e essenziale, è più una credenza di psicologia ingenua che un assunto teorico della disciplina, per cui la diagnosi è una forma sintetica di conoscenza clinica utile per fare previsioni sull’evoluzione futura del quadro e stabilire i trattamenti specifici con più probabilità di successo.
- Cfr: per gli studi postcoloniali: W.D. Mignolo. (2009) Epistemic Disobedience, Independent Thought and Decolonial Freedom. Theory, Culture & Society. ;26(7-8):159-181; per l’epistemologia femminista: D. Haraway, (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. Feminist Studies, 14 (3), 575–599.
- Sto assumendo qui una prospettiva diffusa tra i sociologi della scienza, per i quali questa necessità è fondamentale per la cittadinanza tutta, con le parole di Heather Douglas: «The need for contexts in which citizens can constructively debate scientifically-informed policy-making has never been greater. We need forums in which values relevant to these decisions can become clarified». H. Douglas, (2006). Inserting the Public Into Science. 10.1007/1-4020-3754-6_9.
- S.N. Rees, M. Crowe, S. Harris. (2021). The lesbian, gay, bisexual and transgender communities’ mental health care needs and experiences of mental health services: an integrative review of qualitative studies. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 28(4), 578-589.
- Pensiamo alla storia della diagnosi di isteria, o alla “sindrome nordafricana” analizzata da Frantz Fanon in: Le Syndrome nord-africain (1952), trad. it. La «sindrome nordafricana», in Scritti politici. Per la rivoluzione africana, vol. I, DeriveApprodi 2006, pp. 23 – 41.
- A. Lorde. The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House.1984. Sister Outsider: Essays and Speeches. Ed. Berkeley, CA: Crossing Press. 110-114. 2007.
- R. Chapman, Will opposing psychiatric labels stop over-medicalisation? [on-line] in: Psychology Today, pubblicato il 12 ottobre 2020 [8 febbraio 2020].
- Comitato Invisibile, L’insurrezione che viene. Nero Edizioni, Milano, 2019.