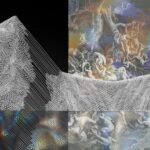Qui per parte I
Al punto fermo del mondo
rotante. Non corporeo
né incorporeo; non da
né verso; al punto fermo
là è danza, ma non arresto
né movimento. E non chiamatelo fissità,
il luogo dove passato e futuro
sono uniti.
…
Solo attraverso il tempo
si conquista il tempo.
– T. S. Eliot, La terra desolata – Quattro quartetti1
In un passaggio fondamentale de Le forme elementari della vita religiosa, Durkheim spiega come il sacro, in tutte le sue forme, rappresenti una modalità di autocelebrazione della società stessa. L’oggetto della venerazione è l’ordine sociale. Da un certo punto di vista, Girard approverebbe: la società è ciò che ci salva dalla violenza originaria, dalla colpa ancestrale. Sebbene ogni rituale e ogni mitologia raccontino di quell’origine, e tentino parimenti di tenerla separata dal presente, l’ordine sociale è l’orizzonte in cui un mondo si conserva. La società è l’apparizione dell’uomo, la sua separazione da ogni altro ente; è una tecnologia che manifesta l’umano come soggetto, anche se questa sua veste è sempre minacciata. I rituali rinnovano la separazione, mentre i miti la raccontano, tenendola ferma nel tempo, e sopra di esso. Se non ci si ricordasse dell’origine, e se non si riproponesse ad infinitum la prima purificazione, si rischierebbe di perdere il cosmo; quando la memoria è persa, le tracce diventano inutili. La memoria, così, è l’elemento fondamentale per la società e per la sua sacralità. Ma non memoria della “verità” dei fatti, delle cose, delle origini manifeste e illuminate dalla conoscenza. La memoria è della separazione – e del passaggio; non accadimento, ma continuum. Ricordarsi di non aver mai posseduto il ricordo.
Apollo è gemello di Artemide. Quando Pausania fa parlare Erofile, sibilla del santuario di Apollo a Delfi, le fa dire, sotto l’influenza di Artemide: io sono moglie, sorella, e figlia di Apollo2. Di Artemide si diceva fosse vergine e pura (hagné), intoccabile – a parte che dal fratello, e padre, e marito, dio del sole, dell’intelletto e delle arti. La più selvaggia delle divinità, signora degli animali e della caccia, nasceva dallo stesso grembo e nello stesso giorno di colui che rappresentava ciò che, in futuro, avrebbe cancellato la “natura” sancendo la separazione fra questa e la “cultura”. Apollo e Artemide sono un Rebis, unione sacra degli opposti, l’androgino completo. Entrambi sono arcieri infallibili – uccidono senza toccare. Nota Calasso: il carattere di Artemide, hagnós, “implica un distacco. È la riverenza davanti all’ignoto. La qualità corrispondente a hagnós è detta hagneìa: senza di essa nessun atto culturale può essere efficace”3. Secondo Kuhn, l’unico progresso scientifico possibile è un “aumento delle soluzioni agli enigmi posti da un determinato paradigma”4. Nessun fenomeno potrà mai essere afferrato nella sua essenza, poiché ogni visione di mondo è condannata a essere una rappresentazione insufficiente della totalità. Ma poi, rinnovando la cura oracolare nella scelta delle parole, aggiunge: la nostra ricerca e le nostre pratiche sono determinate dalla resistenza che il mondo oppone ai nostri tentativi di lettura5. Artemide non parla, e Apollo lo fa per enigmi. In principio fu resistenza – ma il principio è solo un passaggio.
La Teogonia di Esiodo è un poema mitologico che, riconoscono Burkert6 e Cornford7, raccoglie influenze da un’area geografica che va dalla Mesopotamia all’Egitto, dagli spazi montuosi a nord della Colchide fino alle foreste della Tracia. Esiodo narra l’origine del mondo, dal Caos primordiale fino a Zeus re, tentando di fare ordine fra le parole di quello che era, in quel tempo e per loro, il mondo intero. È ne Le opere e i giorni che, invece, Esiodo racconta delle età dell’uomo, di ciò che Calasso definisce il racconto del grande e drammatico distacco dell’anthropos dal resto degli zôion, gli esseri viventi: la separazione assoluta, l’inizio delle ere e dei tempi. Questa “caduta” dell’uomo è narrata in due versioni: la prima è il famoso mito di Prometeo, mentre la seconda, “che Esiodo chiama lógos”8, è una caduta lenta e molto lunga, tutt’altro che lineare. Dall’età dell’oro, tempo del massimo splendore e benessere, all’età del ferro, il tempo di Esiodo, gli anni che preannunciano l’età classica – l’età delle poleis, e della guerra mondiale del Peloponneso. Passando per l’argento e il bronzo, e per l’età degli eroi. Quest’ultima, subito prima l’età del ferro, dura non più di tre generazioni. I suoi protagonisti, figli di dèi e di uomini, esseri a metà fra zoè e bios, rappresentano un grande insieme di storie interconnesse fra loro che si concludono con la vicenda di Telegono9. Calasso riconosce nell’età degli eroi un momento di magnificenza ineguagliata del mito: ogni evento e accadimento, ogni luogo e istante, erano raccolti nei singoli racconti che si legavano, in maniera quasi ossessiva, gli uni agli altri. Non è, però, un’esclusiva di quell’età, che piuttosto rappresenta l’inizio della frammentazione. “La successione esiodea delle età del mondo ha paralleli indiani, iranici, mesopotamici, ebraici”10; il mondo è la pergamena su cui si scrive il racconto del mondo.
La fama di Göbekli Tepe è andata aumentando negli anni, da quando le datazioni al carbonio ne hanno indicato l’inaspettata antichità. Circa dodicimila anni fa, poco distante da quella che sarà la città sumera di Uruk, una popolazione di cacciatori-raccoglitori eresse una sorta di santuario, composto da pilastri di pietra disposti in circolo, ognuno di essi recante altorilievi o incisioni di figure animali11. Il XII e XI millennio non erano il tempo dell’uomo allevatore; gli esseri rappresentati a Göbekli Tepe erano ancora contendenti diretti allo spazio sulla terra per gli esseri che li avevano rappresentati. Questi ultimi potevano essere uccisi, o potevano uccidere. Anche quella sui pilastri era una storia, e insieme era anche un insieme di volti riconoscibili: una classificazione. Era memoria degli altri esseri, che erano “altri” in maniera molto meno severa di quanto non lo siano stati millenni dopo. Göbekli Tepe fu poi interrato volontariamente, e abbandonato; memorie di quando il tempo era anche degli animali. La Mesopotamia cominciò a sperimentare l’universo che è la città; quell’altra storia, forse, non serviva più.
***
Il termine cosmogramma viene utilizzato da Tresch per offrire un concetto generale attraverso cui pensare tutte le complesse e molteplici forme che l’umano ha sviluppato, lungo tutta la storia, per “materializzare” le proprie interpretazioni del mondo, le cosmologie12. Esempi di ciò possono essere oggetti di qualsiasi tipo e genere, come la Bibbia, un rito, la struttura di una città, un dipinto, un tempio; ognuno di questi oggetti, per Tresch, è la concretizzazione di una cosmologia particolare, materializzazione di una visione di mondo performativa in quanto capace di comunicare e tramandare informazioni a coloro che fanno parte di una certa comunità13. Questi oggetti sono, perciò, simboli, catalizzatori d’informazione. Esempio particolarmente rilevante è il tempio: esso è modellato sulla base di istruzioni divine (come nel caso del Tabernacolo nell’Esodo) e corrispondenze celesti e cosmologiche, e ha perciò il compito di rappresentare l’immagine del mondo. Nel cosmogramma il cosmo si incarna; la materia viene modellata in modo che veicoli non tanto un significato, che è già differito, ma il cosmo stesso. Dalla materia si separa una parte che descrive l’indivisibilità del tutto. Per evitare di dover ammettere che ogni artefatto sia un cosmogramma, in quanto manifestazione di un’operatività dell’individuo e del suo vissuto sul mondo, Tresch sottolinea come esso debba assumere un valore sociale14. Ovvero, si può chiamare cosmogramma quell’oggetto che esprime un’interpretazione del mondo condivisa fra più individui e che fa epoca o fa comunità o produce senso.
La vera differenza tra le culture e tra le narrative sarebbe perciò manifestabile in maniera più chiara e limpida attraverso i cosmogrammi. Ognuno di questi segni non esaurisce la sua performatività nell’affermazione di un’imago mundi fondata sul consenso, ma innesca processi di critica e reinterpretazione, fungendo in ultima istanza anche da fulcro del dissenso e del cambiamento. Ogni cosmogramma, per potente che esso sia, è destinato a moltiplicarsi in forme differenti, strutturando un reticolato di segni che, insieme, vanno a comporre la grammatica della storia universale. Quando nel 1979 Lyotard descrive la condizione postmoderna come il momento di dissoluzione delle grandi narrazioni di verità, egli non parla soltanto della progressiva perdita di significato dei singoli cosmogrammi storici, come la Bibbia, il Capitale, o La libertà che guida il popolo di Delacroix. Il collasso delle grandi narrazioni indica più propriamente la sempre minore capacità dei cosmogrammi di produrre reticolati, di differire in eventuali reinterpretazioni e reinscrizioni: di produrre, perciò, il differente e il nuovo. È ciò di cui discute Fisher in Realismo Capitalista:
Il nuovo definisce se stesso come risposta a quanto è già stabilito; allo stesso tempo, quanto è già stabilito deve riconfigurarsi in risposta al nuovo. Secondo Eliot, l’esaurimento del futuro ci lascia anche senza passato: quando la tradizione smette di essere contestata e modificata, smette di avere senso. Una cultura che limita a preservarsi non è una cultura15.
Tale è il risultato ottenuto dall’utopia realizzata dalla modernità occidentale, nei due volti della fine-della-storia (Fukuyama) e del postmodernismo (Jameson). Il tempo si rompe, il meccanismo dell’orologio cosmico si arresta; la vita continua, ma le lancette non corrono. Time is out of joint, scrive Derrida in esergo al suo Spettri di Marx: il tempo è uscito dai cardini. I cosmogrammi entrano a far parte del rumore incessante della comunicazione, e dell’universo dei segni senza referente, i simulacri. L’iperrealtà e la sparizione del tempo: possibile titolo di un prodotto cinematografico hollywoodiano. Il reale parzialmente mancante da cui si originano i cosmogrammi e i relativi paradigmi viene sostituito dalla sua rappresentazione: l’immagine di una compiutezza da svelare, o svelata. Senza più uno sfondo a cui aggrapparsi, le figure levitano e si disperdono. Il collasso del tempo su se stesso – il suo compimento – risulta anche in un collasso dello spazio. Un cosmo che si addensa, e in tale densità la produzione di cosmogrammi è neutralizzata. La modalità principale di relazione con le cosmologie è nostalgica, revival, come afferma Jameson; esse sono disconnesse le une dalle altre, fuori tempo – letteralmente, e musicalmente. Recuperi senza affermazione e senza contesto, con il solo fine di riempire il vuoto della rottura del tempo. In tal senso, i cosmogrammi di Tresch entrano a far parte di quell’universo di spettri che a) non sono (più) concretamente presenti, eppure continuano a insistere sul presente come virtualità, e b) si estendono, dal passato, verso un futuro che abitano come attrattori, come vecchie proiezioni di mondi possibili16. La scienza dei cosmogrammi che Tresch auspica di delineare è già una scienza dei cadaveri, o dei loro sospiri fra le stanze delle loro antiche dimore. Ma se per comprendere le immagini del cosmo è necessario il presente-specifico going native, ammette Tresch, a noi rimane indagare il dialogo, il conflitto, la fusione, la sostituzione, l’alleanza tra cosmogrammi. Di questi oggetti – di questi involucri di fantasmi – non ci rimangono che i passaggi: non ci rimane che osservare gli spettri abbandonare le loro carni.
***
La nascita della tragedia è esistita almeno in tre forme. La prima è quella che concepisce il testo come un sottoprodotto della metafisica di Schopenhauer, quindi in chiaro contrasto con le posizioni del tardo Nietzsche antimetafisico17. La seconda nascita, che si oppone alla prima, è quella per cui Nietzsche utilizza quella metafisica come fosse un mito, una buona illusione redentiva18, e funzionale alla creazione di una nuova civiltà tragica. In quella metafisica non c’è verità, ma una strategia del buon vivere; in essa si crede, pur non riconoscendole alcuna realtà. Nietzsche usa quella metafisica, e il potere produttivo della narrazione. Ci si chiede, però: da cosa deve essere redenta la realtà che viene sostituita dalla “buona illusione” del mito? Dalla sua finta purezza – che ha prodotto, e nutrito, l’ospite inatteso. Anche Nietzsche gioca con le dissonanze.
Il recupero della metafisica in atto nella tragedia attica risulta da una preliminare difficoltà. Nietzsche sa bene – lo ha imparato leggendo i Greci – che nulla è più minaccioso del passaggio. Non si lascia una casa senza che l’esistenza dei suoi stessi abitanti sia a rischio di dissolversi. La caduta di ogni immagine del mondo non può significare una caduta nel nulla: bisogna offrire altri ripari. Si ripete il gioco della sostituzione – il gioco a cui Lyotard guarda con disprezzo19 –, ma Nietzsche intuisce già che in esso il demone dell’immobilità attende paziente. La nuova immagine non può assumere il ruolo della vecchia, non può definirsi come Verità – ma in essa, nonostante tutto, bisogna credere. Nel valore della credenza si definisce la posta in gioco: ci si può affidare a qualcosa che non abbia pretese universali? Una metafisica come quella tragica, esposta in modo tale che appaia come rimedio all’indigestione di illusioni, non va a definirsi come nuova universalizzazione di una visione del mondo particolare? Non una verità, ma uno strumento di affermazione della vita. Nietzsche dimostra di credere, e di esprimersi per coloro che gli sono affini, gli “iniziati”20. Più tardi, egli abbandonerà la fiducia nelle buone illusioni: affermare la vita diverrà percorso individuale, e non più collettivo21. Qualcuno ha provato a dimostrare che Nietzsche credesse davvero nella teoria dell’eterno ritorno22. Ma la teoria non crea, sospende; l’eterno ritorno non sarà che una strategia, un tentativo di cortocircuitare il pensiero. Non un’illusione di verità, ma una possibilità da cui ogni fuga è preclusa. Un fantasma: “virtualità la cui minaccia di realizzazione era già nell’atto di compromettere lo stato di cose attuale”23.
Ad un certo livello, la metafisica tragica – né persa nell’intuizione immediata, né nell’illusione di verità universali – è punto di giuntura fra l’Hermes maggiore (il dio della verità e della sua comunicabilità) e l’Hermes minore (il dio del reale-come-segreto) di Laurelle24. Il rapporto fra il segreto e il soggetto è sempre unidirezionale, afferma Laruelle; ogni filosofia – e invero ogni cosmologia – risulta come dispositivo di interazione con il reale-come-segreto, il reale opaco, l’amorfo originario da cui le forme vengono estratte. Il carattere curativo della tragedia e della sua metafisica è efficace solamente se ognuno struttura il suo mito a partire dall’esperienza del segreto. La terza nascita è il rizoma.
I miti greci sono molti e ridicoli, scrive Ecateo di Mileto nel proemio alle sue Genealogie25. È necessario, per noi che vogliamo ricordare e comprendere quando le raccontiamo, che le cose siano somiglianti alla realtà, a quello che i nostri occhi vedono e le nostre orecchie sentono. La mente e il mondo devono essere conformi, o tutto è solo convenzione, e allora ogni cosa può dirsi. Ovvero: troviamo un modo di rimembrare le cose che trascenda il tempo e lo spazio. Ecateo fu la prima manifestazione di un passaggio, una metamorfosi che può apparire una sciocchezza rispetto a ciò che accadde a Göbekli Tepe. Alla cetra e alla voce dell’aedo, incarnazione del racconto e della memoria – Omero è uno e molti: è la memoria collettiva, e un cosmogramma – si sostituisce la pergamena dello storiografo e del geografo, che mal sopportano il linguaggio oracolare e simbolico. Tucidide non scrive per dilettare – a differenza di Erodoto. I mondi si sostituiscono gli uni agli altri; i cosmogrammi collidono. Un passaggio di tale profondità e complessità culmina in maniera tremendamente simile al tumulto nicciano; Platone estrae dalla terra le radici più pulsanti della grecità, i miti, e li trasforma in un órganon, uno strumento che accompagna l’argomentazione, che spiega o riveste. Il mito, che prima non lo era mai stato, diventa metafora. Il mito, che era stato il mondo, diventa di questi l’analogon. Nell’Epinomide, che si crede possa essere l’ultimo libro de Le Leggi, Platone spende poche, ma cruciali parole sulla scoperta degli incommensurabili. La posta in gioco è immensa, come immensa fu l’ira degli dèi “con i divulgatori delle dottrine di Pitagora”26 sulle grandezze irrazionali: lo scarto, approssimabile ma irreconciliabile, fra la mente e il mondo.
Ciò che fece Platone non fu però un atto di domesticazione dell’indomito. Al contrario, egli cercò di trattenere il divino, e con esso il sacro, al di fuori dell’ordine sociale; implicato in esso – l’ordine sociale è un far-ordine fra le necessità del mondo – ma esterno. C’erano due parole greche che indicavano la necessità, nota Calasso: ananke, l’assolutamente necessario che precede anche il divino, e týchē, l’inevitabile accadere, il destino o la sorte, che è tipo di necessità più disordinata e fluttuante27. A governare le cose umane sono un dio, e poi la sorte (týchē), l’occasione (kairós), e la téchnē. Nell’occasione si manifesta l’inevitabilità, che l’uomo può seguire, assecondare, mediante la sua maestria, la sua arte. Tutto ciò Platone lo faceva affermare dall’Ateniese, dialogante principale de Le Leggi, in un ultimo sussulto anti-nichilista. Lontano dalla forza espressiva e stilistica dei primi dialoghi28, Platone si ritrovava a imbastire le ultime difese contro un mondo che aveva cominciato ad abbandonare il divino (prima di lui) e avrebbe continuato ad abbandonarlo – a relegarlo nell’ordine sociale, come suo organo. Ma senza un fondamento, la società sarebbe stata poggiata su nulla – e avrebbe dimenticato se stessa. Per questo la riflessione di Platone è in prima istanza una politeia.
“Una novità dirompente introdotta dai sofisti in Atene fu la concezione del nomos come convenzione. Quindi come qualcosa di estraneo alla physis e da essa indipendente”29. La téchnē perdeva il connotato di arte della comprensione delle resistenze del mondo, e si apriva alla creazione. L’uomo crea l’ordine del (suo) mondo, orizzontalità che si rinnova e si afferma con l’aristotelismo. Platone, fra due fuochi, emerge dal pericolo di un vuoto abissale – la tirannia della libertà e della creazione – nel passaggio fra il mondo attraversato dal e intrecciato col sacro, percorso da memorie e dall’invisibile, e il mondo dominato dal sacro, in cui si produceva dunque un contromovimento emancipativo. “O stranieri, è un dio o qualcuno fra gli uomini che fu all’origine della istituzione delle leggi?”30; fu questa l’ultima questione platonica, tanto quanto fu la prima. Quando Platone conia il concetto di theatrokratìa, il “governo dello spettacolo”, egli guarda con attenzione all’evoluzione dello spettatore del teatro. Non più un individuo perso nella contemplazione silenziosa e mimetica del flusso di significati e percezioni che gli scorrono dinanzi, ma personaggio tracotante, “loquace da muto che era, e convinto di saper discernere il brutto e il bello”31. Se la sapienza concessa dal dio era anche il riconoscimento dei limiti umani nel discernimento delle cose del mondo – Socrate non potrà che recuperare questa postura contro i sofisti –, ciò che andava affermandosi davanti agli occhi di Platone era un eccesso di libertà, l’abbandono di un approccio cauto al cospetto dell’ineffabile e della sua sacralità. E lo spettatore, così, parlava e agiva, chiacchierava e sentenziava, forte di una sicurezza infondata – tanto che il pubblico diventa il cuore di una forma di politeia posta accanto alla monarchia e alla democrazia. Teatrocrazia, regno della doxa; il divino non veniva respinto, ma assimilato nella familiarità. Più di due millenni dopo, Debord non ha inventato nulla.
Cosa significava salvare il divino? Riparare il tempo. Il divino era la dimensione in cui si salvaguardava il divenire – la possibilità di assecondare la sorte che appariva negli strappi del tempo. L’utilizzo del mito da parte di Platone non fu, quindi, un atto di dominazione, ma di riverenza. Non solamente credenza, ma produzione di credenza. Platone osservava la volta della caverna come si osserva la volta celeste, il luogo in cui si raccontavano le storie (le costellazioni e le pitture rupestri), in cui si acquietava il mondo. Che quieto non era mai: l’Ateniese ne Le Leggi riconosceva che la forma realizzabile della società giusta era solo seconda a quella migliore. Ovvero, l’ideale era obbligato a cedere alle resistenze del reale. Lungi dall’implicare che l’idealità sia inutile, Platone emana uno spettro. Fine strategia hauntologica: demoni che insinuano pensieri ricorrenti, ossessioni – i pesi più grandi. Quanto di Platone fu in Nietzsche? Quanto dei cacciatori di Göbekli Tepe in Platone? Quanto degli esseri del pre (-istoria, -umanità, -mondo, –socius) nei cacciatori? La catena delle domande, poi, può scorrere all’indietro. Memorie di molti passaggi, e del segreto del loro accadere.
***
Mai come in quest’epoca della frammentazione l’uomo è stato così vicino a sperimentare il significato dell’eternità. In essa, il suo carattere totalizzante e claustrofobico. L’eternità è la più angusta delle stanze del tempo. La più grande è l’infinità, e lo testimonia l’intricata, insensata, e immensa città al margine del quale abitano gli immortali di Borges. Nell’infinità, Marco Flaminio Rufo attraversa la storia e sceglie il giusto momento per morire. Nell’eternità, la nascita e la morte sono lo stesso istante. “Come si delineava nel pensiero dei socialdemocratici”32, afferma Benjamin, il progresso era articolato in tre istanze. Progresso umano, senza particolari determinazioni; progresso senza fine, ovvero il perenne cammino verso una perfettibilità che mai si compie; progresso incessante, che definisce un percorso del tempo come linea. L’immagine che Benjamin offre di tale concetto è la catastrofe: “che tutto continui così”33. E le giustappone l’eterno ritorno nicciano in una veste ulteriormente nuova. Non strategia né minaccia all’immobilità del pensiero, ma espressione storicamente determinata della felicità – della buona vita. “L’eterno ritorno è un tentativo di legare insieme i due principi antinomici della felicità: quello dell’eternità e quello dell’‘ancora una volta’”34. Ogni tentativo di ripetere è una minaccia all’immobilità. Se la carica messianica di Fisher risiedeva nella riappropriazione del tempo, essa comprendeva l’intero delle dimensioni temporali: del passato, dimora degli spettri, del futuro, ventaglio di possibilità, e del presente, crocevia delle correnti. Nella catastrofe bisogna ricercare i piccoli salti in cui l’eternità si arresta silenziosa. “Si deve studiare a fondo la questione in quale misura gli estremi da comprendere nella salvazione sono il ‘troppo presto’ e il ‘troppo tardi’”35; molto dell’immaginario collettivo contemporaneo annega nei simulacri di piccole e grandi apocalissi. Sintomi ricorrenti della malattia del tempo.
“Solo nell’immagine … si lascia fissare il passato”36, afferma Benjamin nella sesta delle tesi sulla filosofia della storia. Aggiunta fondamentale a una delle tesi precedenti, la seconda, finissima e tagliente come un foglio di carta tra le mani del frettoloso: la totalità del passato – delle immagini del passato – è il gioiello portato in dote a un’umanità redenta. “C’è un’intesa segreta fra le generazioni passate e la nostra”37 – segreta a tutti, anche ai poli dell’intesa stessa. Solo per l’umanità redenta il passato è citabile in ognuno dei suoi aspetti; di nulla si ha terrore, di nessuna immagine, di nessuna parola. Questo è il significato del materialismo storico, della storia come grande narrazione della lotta di classe. Prima che tempo, questa storia è senso, e quindi decisione. Non può fare a meno di apparire, però, la questione del passare del tempo, e di ciò che in esso passa. Anche la lotta è sostituzione di figure – anche se fossero solo due, i dominanti e i dominati, e la loro sublimazione finale. Fra le figure stanno gli istanti sospesi – i “piccoli salti nell’eternità” – come le rivoluzioni. Che non sono mai ciò che promettono; Lyotard è categorico sull’illusione della reiscrizione. Stiamo solo reiterando, ancora e ancora, nutrendo l’eternità. Che tempo è quello dopo la fine del tempo? Non c’è redenzione in Lyotard, solo testimonianza. Benjamin cita Hegel: “cercate dapprima cibo e vestimento; e il regno di Dio vi arriverà da solo”38. Gli spiriti sanno emergere solo in corpore sano.
Nella sua lettura immanentistica di Hegel, Stephen Houlgate evidenzia nel concetto di virtualità una delle principali differenze tra il filosofo di Stoccarda e Gilles Deleuze. Per Deleuze, il virtuale e l’attuale sono entrambi reali: il virtuale non è semplicemente il possibile. Hegel riconosce l’esistenza di qualcosa che non è né attuale, né necessario, né semplicemente possibile; c’è differenza fra il formalmente possibile e il concretamente possibile, dove questa seconda forma di possibilità rappresenta una situazione che contiene in sé le condizioni reali di qualcosa che non si è ancora manifestato, e che perciò è solo virtualmente attuale. Tali condizioni si manifesteranno, eppure rimangono ancora conchiuse in loro stesse. Per Hegel, queste forme di possibilità non hanno una struttura differente rispetto alle possibilità formali: non possono essere definite condizioni quasi-trascendentali. Il problema del virtuale, afferma Houlgate, risiede nel fatto che esso sembra prendere semplicemente il posto del trascendentale – il virtuale, come sfondo generativo, non si manifesta mai come tale, mentre per Hegel non esiste nulla che non si manifesti: niente rimane, in ultima istanza, nascosto. Anche quando qualcosa tenta di rimanere nascosto, esso appare attraverso tale nascondimento. Il tempo è perciò il luogo dell’estrinsecazione di tutto ciò che è possibile. Scrive Deleuze: “Bergson ricorda costantemente che il Tutto non è dato. E ciò non significa che l’idea del tutto sia priva di senso, ma che designa una virtualità in quanto le parti attuali non si lasciano totalizzare”39. Nel piccolo reame del pensiero, nulla è nascosto.
Conoscere tutto: giungere, nel tempo, alla piena appropriazione di ogni oggetto di conoscenza che è anche ogni oggetto del mondo e il mondo come oggetto, in cui il tempo stesso non è che una concessione, un dono. È grazie al tempo che esiste la conoscenza: Apollo e Dioniso sono nipoti di Crono. Laruelle definirebbe questa vana speranza come essenza del dispositivo di Differenza ermetologica, correlazione indissolubile fra la verità e la sua comunicabilità. L’assunto hegeliano del nulla è nascosto sarebbe inconciliabile con la limitatezza della filosofia, dal punto di vista di Laruelle, che descrive il dispositivo filosofico come una téchnē fra le altre, un macchinario che offre immagini parziali estratte da uno sfondo opaco e oscuro. Nella non-filosofia laruelliana, non c’è conoscenza filosofica che non sia sempre frutto di una decisione preliminare, e di una metodologia, che finirà irrimediabilmente per nascondere qualcosa a favore di qualcos’altro – e a nascondere il fatto che il reale stesso si dà in essenza come segreto. Hegel non fa mai riferimento a una conoscenza totale. La conoscenza assoluta dello spirito è invece, dalla stessa etimologia della parola, ab-solutus, una conoscenza sciolta dal finito, in continuo divenire e in perenne evoluzione, senza condizioni di possibilità preliminari. Né premesse, come sottolinea con forza nell’introduzione alla Scienza della Logica. Postura di fronte all’impossibilità di afferrare tutto a un solo momento; niente è nascosto in assoluto, ogni cosa lo è a un tempo. Laruelle utilizza la figura mitologica di Hermes, e il mito stesso come veicolo di manifestazione, per mettere in atto la sua analisi sui limiti della filosofia. Hegel, nella Fenomenologia, racconta la lunga storia della coscienza e dei suoi nascondimenti-disconoscimenti-riconoscimenti attraverso figure impossibili da circoscrivere senza che sfuggano dalle mani non appena si crede di tenerle strette. L’Hermes “minore” di Laruelle non svela segreti, ma li presenta – così come la storia della coscienza è presentata nella Fenomenologia senza che nulla in essa sia afferrabile fino alla realizzazione dello spirito, quando il segreto, invece, pare svelarsi. È nella razionalità, e quindi massima comunicabilità, del reale che Laruelle ravvisa l’errore hegeliano: il reale-come-segreto è incomunicabile e intangibile. Risponderebbe Hegel: niente è nascosto in assoluto, neanche il segreto – pure nell’estremo silenzio, esso si presenta. É bene sperare che, nella storia della filosofia come storia di larve esitanti40, Laruelle non sia farfalla.
Nella famosa lezione del 1894 The Four Phases of Philosophy and its Current State, Franz Brentano descrive la filosofia come una disciplina dalla doppia natura. Da una parte, essa sembra seguire il percorso delle scienze, in un progresso costante e positivo; dall’altra, qualcosa della filosofia è gemellato con l’arte, e col suo procedere a strappi e cadute, collassi e rinascite. Brentano offre un’immagine impossibile, fra Apollo, Dioniso, e la sapienza di cui sono latori. Come scorre il tempo della filosofia? Essa abita un bozzolo, manifestazione estrema dell’eternità, in cui ognuna delle grandi e piccole figure che articolano il percorso continua a discorrere con le altre, in un singolo cristallo di tempo – al di là dei millenni e degli oceani. Ma ancora, di cosa discute eternamente questo dispositivo immortale, e sempre quasi morto e sempre appena nato? “Quando la potenza dell’unità svanisce dalla vita degli uomini e le antitesi perdono le loro vive relazioni e reciprocità, e si fanno indipendenti, lì emerge il bisogno della filosofia”41. Nella morte di qualcosa, l’unità – il desiderio di un’unità che è perduta e che si dà come perduta, la morte del senso e la disgiunzione di questo dal mondo – il pensiero si attiva. Non è questione di origine, del quando di questa morte, ma di cosa la morte è il segno. Il lutto va elaborato, prende tempo, segue alla scomparsa, riempie il vuoto – se ci riesce – di ciò che è scomparso. La filosofia non emerge allora nella morte, ma nel lutto; non assiste al morire, ma osserva il cadavere, gli sta innanzi. L’accadere è già compiuto, quando emerge il bisogno dell’unità. La morte è il segno di ogni passaggio – ed è solo nel passaggio che può emergere la continuità. E il tempo. Nella perdita dell’unità, in mezzo alle figure e dinanzi a un’opacità inafferrabile, emerge l’orizzonte preliminare a ogni Decisione ermetologica. Lyotard lo chiama giudizio; è l’orizzonte dell’inumano.
***
Una crisi ci costringe a tornare alle domande; esige da noi risposte nuove o vecchie, […] e si trasforma in una catastrofe solo quando noi cerchiamo di farvi fronte con giudizi preconcetti, aggravando così la crisi, e rinunciando a vivere quell’esperienza della realtà […] che la crisi stessa costituisce 42
Con queste parole, raccolte nel volume Tra passato e futuro del 1961, Hannah Arendt discute della crisi dell’istruzione negli Stati Uniti di quegli anni. L’uso del termine “catastrofe” appare opposto da quello di Benjamin, e più legato all’etimologia ed essenza della parola: la katastrophḗ è un ribaltamento quasi geometrico, un capovolgimento. Ma cos’è che rischia di capovolgersi in una crisi? Il campo in cui si dispiega la questione della crisi della scolarizzazione di quegli anni è, per Arendt, la relazione fra il tempo tramandato dagli educatori, e il tempo che abitano gli alunni. “Gli educatori rappresentano di fronte ai giovani un mondo del quale devono dichiararsi responsabili anche se non l’hanno fatto loro, e anche se, in segreto o apertamente, lo desiderassero diverso”43. La formulazione è perentoria e assoluta, quasi un imperativo. La responsabilità di coloro che formano i nuovi umani è quella della credenza, o dell’illusione della credenza – rivolta tanto ai giovani, quanto a se stessi. Per permettere la liberazione del futuro, è necessario offrire il passato in dono come se esso fosse la verità compiuta. Per educare, è necessario il buon inganno. Poche pagine dopo, ella rincara, come se fosse la più ovvia delle considerazioni: “in fondo, noi educhiamo sempre i nostri figli in vista di un mondo che è già, o sta per diventare, fuori sesto”44. Tra i mondi di coloro che hanno un mondo e coloro che devono costruirlo esiste un rapporto asimmetrico, che sottintende questo: ciò che ti offro è ciò che dovrà scomparire con la tua venuta, rinascendo. “Proteggere il mondo dalla sua natura mortale”45 significa, invero, compiere un sacrificio obbligato, in cui ci si reinsudicia, e ci si ripurifica. Salvare il cosmo dalla sua disintegrazione, e rinnovarlo: niente che non fosse già chiaro agli ierofanti eleusini, o agli sciamani Ashanti. Reiterare il passato – trattenere il mondo – è l’atto più efferato, pari all’empietà di lasciare un cadavere al sole a imputridire all’interno delle mura della città. Il sudicio, come nemico, emerge proprio quando lo si nasconde. “Diventare i nostri padri e le nostre madri” è l’augurio di una società senza tempo.
Benjamin intende per catastrofe il ribaltamento che pone fine a tutti i ribaltamenti, e quindi alla dialettica del materialismo storico. Sogno d’eternità, sfera conchiusa e immobile. In qualche modo, anche lo stesso capovolgersi del mondo appare salvifico – testimonia che, nonostante tutto, esiste qualcosa pronto a diventare altro. Nella Scienza della Logica, Hegel arriva a definire con nettezza il campo della verità come campo del divenire, l’unico momento che persiste nel susseguirsi delle figure. La Fenomenologia dello Spirito, d’altro canto, mette in atto tale speculazione attraverso l’analisi di figure che non persistono mai se non nel loro esser-di-passaggio. Quindi, nella loro irriducibile precarietà da momenti, istanti, mondi in continua relazione e scambio con il loro intorno. Ogni passaggio è una crisi, soprattutto perché non è mai scontato. Le figure hegeliane lottano e si sforzano in una danza nella quale è in gioco la loro stessa sopravvivenza. La danza è della coscienza, protagonista di molte frammentazioni e molte rinascite. É capitato che la Fenomenologia, in particolare, fosse descritta come un’opera iniziatica di carattere ermetico46. Hegel appare esotico e ctonio, e così la coscienza stessa che si osserva in ciò che non riconosce più.
Cosa è un passaggio? È ciò che accade nella crisi. Krísis significa decisione, ma essendo sostantivazione di krī́nō (discernere, separare47) essa appare relativa fondamentalmente alle forme, e alla loro geometrizzazione. In Demostene48 e in Sofocle49, krī́nō è anche il giudicare. Il più interessante degli utilizzi del termine crisi è però di Ippocrate50: il punto di svolta nel decorso di una malattia, che può risolversi sia in positivo, che in negativo. É la medicina a descrivere con più grande chiarezza il divenire hegeliano, il conflitto delle figure. Ciò che il termine crisi, in tutte le sue varie declinazioni, fallisce apparentemente a restituire é un’idea di continuità temporale, a parte che nella definizione di Ippocrate. La decisione, la scelta, il discernimento di fronte alla separazione, che è essa stessa una rottura, aprono a una dimensione sospesa, una dimensione teorica che precede l’atto di decidere, di giudicare, di discernere. La crisi, così, è rottura del tempo che però apre al suo procedere: è il momento di risoluzione o di disintegrazione. In ciò, krísis è una categoria del sacro – una sua condizione di possibilità espressa nel fatto che la ritualità mira alla perfetta consapevolezza necessaria a operare in una crisi attesa. Se a Durkheim sembra che le varie forme del sacro celebrino l’ordine sociale stesso è perché tale ordine è il frutto del riconoscimento di un’opacità costitutiva del reale, che il sacro trattiene e ripresenta. La sacralità è la forma fondamentale della veglia, laddove la proceduralità moderna è schema, ripetizione, rottura, e aggiustamento. Mortalità ed eternità; la questione della continuità, centrale per gli antichi, è stata semplicemente dismessa.
Pensare il passaggio nella crisi è un atto di sostanziale violenza. Proprio perché il buon decorso di una crisi ricuce lo strappo che il tempo aveva sofferto, il passaggio è qualcosa che alla coscienza appare solo a posteriori, nel ricordo, la rimembranza. Esso è, perciò, un oggetto storico che svanisce nel tentativo di oggettivarlo. Tale suo carattere, che mantiene in sé il continuum – non come oggetto, ma come segreto – manca sempre di manifestarsi nel presente della crisi. E nel futuro della crisi, nella sua fine, il passaggio appare solo come discontinuità, e quindi svanisce, non lascia niente di sé, solo apparizioni fraintese. Quel tempo, il tempo sospeso, è così attraversato dal sentimento di estraneità del passato, che spinge in avanti in cerca di una fuga impossibile, e dalla tenebra del futuro, che invece ci respinge “verso casa”, alla ricerca di qualcosa di familiare in ciò che fu. Il presente diventa così eterno e spoglio, dimensione strutturata attorno a un ordine avvinghiato alla “realtà”, e quanto più grande quell’ordine, tanto più insistente la crisi. Ma il passaggio non è nascosto, non può essere nascosto, poiché nella sua stessa possibilità futura, esso è già – nei ricordi futuri di un’(altra)umanità, o nel silenzio della disintegrazione. Pensare il passaggio nella crisi è violentare il presente, restituirlo al sudicio e all’amorfo, per poi giudicare – e purificarsi nuovamente. La crisi è dell’umano, è un’identità, una dialettica che si risolve nell’identità. Ma il passaggio, che è dell’inumano, non può essere altro che differenza: una resistenza assoluta, anche alla memoria stessa.
- trad. A. Tonelli, Feltrinelli, Milano 2012 (XI ed., I ed. 1995), pp. 99 e 101.
- Descrizione della Grecia, X, 12, 2
- R. Calasso, Il Cacciatore Celeste, Adelphi, Milano, 2016, p. 57
- J. Tresch, op. cit., 2001, p. 305
- T. Kuhn, op. cit., 1970, p. 190-196
- The Orientalizing Revolution. Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age, Harvard University Press, Cambridge (Massachussets) 1992; La religione greca. Milano, Jaca Book, 2010
- Principium Sapientiae. The Origins of Greek Philosophical Thought, Cambridge University Press, Cambridge, 1952
- R. Calasso, op. cit., 2016, p. 107
- Igino, Fabulae, 127; Pseudo-Apollodoro, Bibliotheca, 4, 7, 16-36-37
- Calasso, op. cit., p. 107
- G. Haklay, A. Gopher, “Geometry and Architectural Planning at Göbekli Tepe, Turkey”, in Cambridge Archaeological Journal, Vol. 30, Issue 2, 2020, pp. 343-357
- J. Tresch, “Cosmologies Materialized: History of Science and History of Ideas”, in Rethinking Modern European Intellectual History, ed. D. McMahon and S. Moyn, 2014, pp. 153-172
- per approfondimenti: http://www.youtube.com/watch?v=Z2stwPd_MSw&t=1h44m35s (Conference: Buddhism, Mind, and Cognitive Science, UC Berkeley, 2014)
- J. Tresch, “Cosmogram”, in Cosmogram, ed. J. Royoux Melik Ohanian, 2005, pp. 67-76
- M. Fisher, Capitalist Realism: Is There No Alternative?, Zero Books, 2009, p. 46 (Realismo Capitalista, Nero Edizioni, Milano, 2018)
- Mark Fisher, “What is Hauntology”, in Film quarterly vol 66 n 1, 16-24 (16)
- Cfr. in particolare P. Poellner, Myth, Art and Illusion in Nietzsche, in P. Poellner, M. Bell, Myth and the Making of Modernity, Rodopi, 1998
- P. Poellner, op. cit., 1998, pp. 62-65
- J. Lyotard, “Rewriting Modernity”, in op. cit., 1991, pp. 24-28
- F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, Outlook Verlag, 2018, §22
- C. Blake, “Myth and the Problem of Initiation in the Birth of Tragedy”, in The Agonist, 2020, pp. 129-130
- Cfr. N. Sinhababu, K. U. Teng, “Loving the Eternal Recurrence”, in The Journal of Nietzsche Studies, 2019, 50 (1), pp. 106–124
- Fisher, Ghosts of my life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures, Zero Books, London, 2014, p. 18
- F. Laruelle, “La Verité Selon Hermès”, in Analecta Husserliana, Vol. XXII, 1987, 397-401 (La Verità secondo Hermes)
- FGrHist 1, F 1 J.
- Giamblico, Vit. Pyth. 88 de comm. math sc. 25 p. 77 18-24, racconta che “Perì infatti come empio in mare colui che rivelò come s’iscrive nella sfera l’icosagono, cioè il dodecaedro, una delle cinque figure dette solide. Alcuni però narrano che questo accadesse a colui che aveva propagato la dottrina degli irrazionali e degli incommensurabili.”
- Calasso, op. cit., 2016, p. 235
- ivi, p. 231
- ivi, p. 234
- Platone, Leggi, 756 a-b
- ivi, 701 a
- W. Benjamin, op. cit., 2012, tesi 13
- W. Benjamin, “Catastrofe e Progresso”, in ivi, frammento 35
- idem
- idem
- ivi, tesi 6
- ivi, tesi 2
- esergo alla tesi 4
- G. Deleuze, Le bergsonisme, PUF, Paris, 2014, p. 32
- F. Laruelle, Philosophies of Difference. A Critical Introduction to Non-philosophy, trad. R. Gangle, Bloomsbury, 2011, p. 179
- G. W. F. Hegel, The difference between Fichte’s and Schelling’s system of philosophy, trans. H. S. Harris and Walter Cerf (Albany, NY: State University of New York Press, 1977), p. 91.
- H. Arendt, Tra passato e futuro, trad. T. Gargiulo, Garzanti, 1999, p. 189
- ivi, p. 201
- ivi, 205
- idem
- G. A. Magee, Hegel and the Hermetic Tradition, Cornell University Press, 2008
- Hdt.6.129, Le storie; Il.5.501, Iliade
- D.21.154, Orazioni (Contro Midia)
- S.OT34, Edipo Tiranno
- Hp. VM19, De prisca Medicina